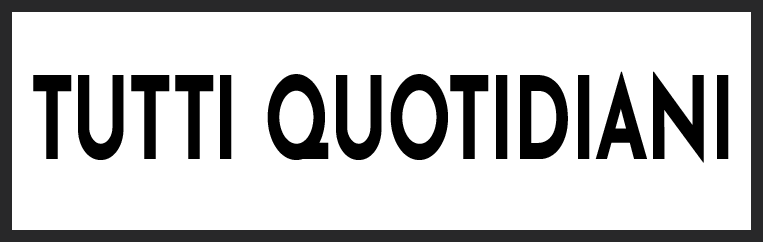50 anni dalla fine della guerra in Vietnam: la ferita che non si è mai chiusa
- Postato il 1 maggio 2025
- Di Panorama
- 1 Visualizzazioni


I marines, il 30 aprile 1975, appesi alla scaletta dall’elicottero, già in decollo dal tetto dell’ambasciata americana di Saigon, sembrarono in fuga precipitosa da nemici che li tallonavano dappresso. E offrirono l’immagine scomposta di una sconfitta, destinata a dilagare nelle pagine di storia. Con quella fotografia, in Vietnam, terminò una guerra che, per la verità, non ebbe un vero inizio perché non fu mai formalmente dichiarata. A dispetto di un bilancio finale che obbligò l’America a fare i conti con 58 mila vittime e una lacerazione sociale che solo le generazioni dei nipoti riuscirono, in qualche modo, a rimarginare. Il conflitto – prima degli scontri fra reparti in divisa – si dipanò fra operazioni segrete, interventi nascosti, aiuti sotterranei, «burocrati» in mimetica e «consiglieri» a difesa di arsenali clandestini. L’intelligence obbedì a ordini protetti dal massimo riserbo e riferì del suo operato con relazioni volutamente ambigue.
La crisi si manifestò all’inizio degli anni Cinquanta del Novecento quando i francesi furono costretti ad abbandonare le colonie del Sud-est asiatico, a cominciare dall’Indocina. Il Vietnam – con provvedimento «provvisorio» – fu diviso in due amministrazioni, in attesa di elezioni destinate ad assicurare un unico governo all’intero Paese.
In realtà, il presidente del Sud Ngo Dhien Diem rifiutò il voto, sostenendo che il Nord non poteva esprimersi liberamente perché intontito dalla propaganda comunista di Ho Chi Minh. Unione Sovietica e Cina presero a finanziare i «rossi» – i «cong» – e a prepararli a combattere contro avversari che – non era difficile comprenderlo – avrebbero dovuto presto affrontare. Gli Usa – pure loro sul piede di guerra – armarono il sud presidiandolo con contingenti di volta in volta più robusti.
Gli americani si lasciarono convincere che la fragilità dello schieramento anticomunista dipendesse proprio dal presidente del Vietnam del Sud. Il quale, pur essendo personalmente una persona per bene, era come assediato da schiere di parenti che spadroneggiavano nel Paese rendendolo ostile. I servizi segreti Usa approvarono il progetto di sbarazzarsene, offrendo ogni complicità utile all’esecuzione del delitto. A cominciare dall’intervento diretto del presidente degli States John Fitzgerald Kennedy che impose all’ambasciatore statunitense a Saigon – Henry Cabot Lodge – di «lasciare fare».
Risultato controproducente. Il governo del Vietnam del Sud (dal 1° novembre 1963) finì nelle mani di un generale – Duong Van Minh – il quale, oltre a fare affidamento su uomini corrotti, era lui stesso di discutibile moralità. Il consenso a favore dei comunisti e – peggio – l’antipatia verso gli yankee andò aumentando.
A Washington, «il problema Vietnam» venne lasciato decantare negli angoli bui della Casa Bianca dove le decisioni «delicate» vennero assunte dal presidente e da quella cerchia ristretta di fidatissimi collaboratori che – già allora, con evidente disappunto – veniva indicata come «la corte di Camelot». Kennedy sarebbe stato il re Artù e agli altri era attribuito il titolo di Cavalieri della tavola rotonda.
Le indicazioni operative vennero mantenute a tale livello di riservatezza da lasciare all’oscuro persino il vice presidente Lyndon Johnson. Il quale, subentrando alla presidenza (22 novembre 1963) quando Kennedy venne assassinato a Dallas, si trovò alle prese con una questione della quale non conosceva né i dettagli di contesto né gli impegni cui era vincolato. Si mosse con la superficialità suggerita da informazioni che, più che sommarie, si rivelarono inattendibili. E, sulla base di una mezza verità e di un’enorme bugia, schierò apertamente l’esercito che, fino a quel momento, aveva operato con interventi mimetizzati.
La scintilla che accese il fuoco della guerra brillò nel golfo del Tonchino dove si scontrano il cacciatorpediniere americano Maddox e una motosilurante vietnamita. Nessuna vittima statunitense e quattro morti dall’altra parte. Ricerche successive ritennero che si trattasse di un incidente determinato da un errore involontario del timoniere Viet. Certo, non avvenne l’attacco denunciato nei giorni successivi che servì per accreditare una sorta di escalation contro le forze Usa e, quindi, la necessità di rispondere con fermezza. Sulla base di relazioni che – falsamente – riferirono di un «inequivocabile attacco non provocato» la Camera (all’unanimità) e il Senato (con due voti contrari) approvarono (7 agosto 1964) la risoluzione che consentiva al Presidente di «assumere le necessarie misure (incluso l’utilizzo delle Forze armate) per assistere ogni Stato membro del Seato che richieda assistenza a difesa della propria libera sovranità».
Il Seato (Southeast Asia Treaty Organization) richiamava un «patto di difesa» firmato a Manila nel 1954 a tutela di alcuni Paesi dell’area. Anche se era del tutto chiaro che con quel testo si allestiva una campagna militare in Vietnam, la dichiarazione – per come era stata formulata (e votata) – aveva mantenuto una forma in apparenza neutra. Del resto, l’argomento doveva sembrare di marginale importanza. I membri del congresso sapevano – davvero – dove si trovava il Tonchino? E, certo nessuno ipotizzò che la potenza americana potesse incontrare ostacoli. Che pericolo poteva venire da una marmaglia senza divisa, che calzava sandali fatti in casa e sparava con dei ferrivecchi?
La verità è che si conosce il tempo dell’inizio ma non quello della fine. Il 2 marzo 1965 fu scatenato il primo bombardamento e sei giorni dopo i marines sbarcarono sulle coste del Vietnam del Sud. Con i soldati che già c’erano, arrivarono a 25 mila, destinati a raggiungere il mezzo milione quando lo scontro si fece più aspro.
Johnson si mostrò fiducioso tanto da assicurare che quell’operazione si sarebbe svolta «con la stessa comodità garantita dalla camicia da notte di una nonna». Il segretario di Stato Robert McNamara minacciò di far precipitare su quello spicchio di territorio «più bombe di quante cadute su Italia, Germania e Giappone messi insieme». Ho Chi Minh – non si sa se per baldanza o per convinzione – replicò che «potevano perdere anche mille uomini per ogni americano» ma che «alla fine, avrebbero vinto».
Gli americani credettero – lo credono sempre – di sbrigare la questione rapidamente, affermando la loro superiorità. Invece si trovarono invischiati nella spirale di un conflitto che non aveva niente di convenzionale e che si sviluppò – uomo contro uomo – in agguati che snervarono i soldati abituati ad altri tipi di combattimento. Le disposizioni tattiche, mandate a memoria per gli esami in accademia, non servivano in mezzo a decine di chilometri quadrati di alberi ognuno dei quali nascondeva il pericolo di un nemico.
Non ci furono battaglie in campo aperto. Gli americani furono coinvolti in una serie ininterrotta di imboscate che i Viet Cong praticavano quando si trovavano nelle condizioni più favorevoli. Si trattò di scontri «mordi e fuggi». Gli yankee non riuscirono a rispondere efficacemente tanto che, da aggressori, si trovarono a essere gli aggrediti. Avvelenarono le foreste con la diossina – l’«agente arancio» – che doveva disboscare la giungla per togliere riparo ai nemici. Rovesciarono milioni di tonnellate di esplosivi e dell’incendiario napalm in ogni angolo senza badare ai danni collaterali. Non si trattennero dal bombardare Laos e Cambogia accusati di offrire riparo ai Viet Cong in ritirata. E mostrarono la faccia feroce ai contadini, con il risultato di inimicarseli del tutto.
Andarono avanti dieci anni nel corso dei quali si accatastarono montagne di vittime che indignarono l’opinione pubblica americana fino a creare una pressione insopportabile sul governo. Inutile – e dannoso – continuare.
Nel gennaio 1973 iniziarono i primi approcci per un «cessate» il fuoco» parziale che doveva anticipare la fine del conflitto e la ritirata degli americani. Henry Kissinger che aveva gestito gli anni della guerra s’intestò le trattative – non facili – per la sua fine.
Che non risparmiò code di polemiche feroci. Chi si lamentò di un’America imbelle che non aveva portato a termine il lavoro iniziato e chi la accusò di aver cominciato una guerra ingiusta, con l’aggravante dell’utilizzo di metodi infami e di strumenti ignobili.
I soldati tornarono a casa fiaccati nel fisico e segnati per sempre nel morale. Si trovarono emarginati in una società che, prima, aveva loro imposto di imbracciare i mitragliatori ma che, poi, si era vergognata di averlo chiesto.
Ci volle del tempo perché gli schermi dei cinematografi fossero in grado di raccontare di Rambo che pretendeva rispetto per aver combattuto per ordine di altri.