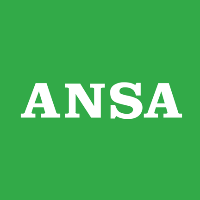Carbone & Co. alla riscossa: i fossili tornano a crescere nonostante la transizione verde
- Postato il 27 settembre 2025
- Di Panorama
- 3 Visualizzazioni


Nel 2024, per la prima volta nella storia, rinnovabili e nucleare hanno contribuito al 40 per cento della generazione di elettricità a livello mondiale, con le rinnovabili da sole che hanno fornito il 32 per cento. Un bel risultato nella lotta alle emissioni di anidride carbonica. Ma mentre i riflettori dei media si concentrano a illuminare pieni di giustificata soddisfazione questa notizia, ignorano quasi del tutto una verità scomoda: le fonti fossili non solo continuano a soddisfare il 60 per cento della domanda di energia elettrica, ma segnano nuovi record di produzione e di consumo.
In pratica, nella battaglia per il futuro energetico del pianeta i carburanti tradizionali non stanno perdendo terreno, anzi. Per esempio, il consumo globale di carbone, il più inquinante tra i combustibili fossili, ha toccato nel 2024 il suo massimo storico. Persino l’Europa, un continente che si è autoproclamato alfiere della transizione verde, nel 2025 è tornata a bruciare più carbone per la produzione di energia. Nuovi record anche per il gas naturale, mentre l’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) prevede che la domanda mondiale di petrolio continuerà a crescere, aggiungendo nel 2025 ulteriori 740 mila barili al giorno su base annua. Apparentemente, c’è qualcosa che non torna: com’è possibile che, mentre le fonti rinnovabili si espandono a un ritmo senza precedenti, anche i combustibili fossili possano vantare ogni anno nuovi primati?
La risposta si trova in un dato che sovrasta tutti gli altri: la fame apparentemente insaziabile di energia del mondo moderno. La domanda globale di elettricità ha raggiunto nel 2024 i 31.153 terawattora (31,1 milioni di gigawattora), con un incremento nell’ultimo anno del 4,3 per cento, circa 1.100 TWh in più, una crescita doppia rispetto alla media dell’ultimo decennio. È un balzo vertiginoso alimentato dalla digitalizzazione pervasiva, dall’elettrificazione dei trasporti e dall’industrializzazione continua delle economie emergenti. Il mondo ha un’enorme fame di elettroni e, allo stato attuale, non può contare solo sulle fonti rinnovabili per soddisfare il suo appetito. In questa corsa energetica, ogni fonte disponibile viene sfruttata, e i combustibili fossili, economici, affidabili e consolidati, restano la spina dorsale del sistema.
A questo fenomeno puramente quantitativo si aggiunge un cambiamento qualitativo nel clima politico e diplomatico. Con molti Paesi, a partire dagli Stati Uniti, che sono sempre meno ostili se non favorevoli alle fonti fossili, la pressione sulla decarbonizzazione si è attenuata. Il risultato è che carbone, gas naturale e petrolio mostrano un’incredibile e inaspettata resilienza.
Il carbone è l’emblema di questa capacità di resistere alla transizione. Il suo consumo globale ha raggiunto la cifra record di 8,8 miliardi di tonnellate. L’uso del combustibile nelle centrali elettriche, il suo impiego primario, fornisce ancora oggi quasi un terzo della generazione globale di elettricità, mantenendosi su livelli mai registrati nella storia. In questo scenario, la Cina gioca un ruolo egemonico e insostituibile, rappresentando da sola il 56 per cento del consumo globale di carbone. Sebbene Pechino stia investendo massicciamente anche nelle rinnovabili, la sua priorità assoluta rimane la sicurezza energetica e la stabilità economica, obiettivi per i quali il carbone rappresenta ancora una garanzia. A seguire, l’India e il Sud-est asiatico continuano a fare affidamento su questa fonte per alimentare la loro impetuosa crescita economica. La previsione di un timido inizio del declino della domanda globale di carbone a partire dal 2025 deve essere interpretata con estrema cautela.
La crescente domanda di elettricità non è guidata solo dai fattori tradizionali. Un nuovo, vorace consumatore si è affacciato sulla scena globale: il settore dei data center e dell’Intelligenza artificiale. Secondo l’Aie, vent’anni fa i data center consumavano meno di 120 TWh; oggi ne divorano 485, e le stime sono in continua crescita. L’addestramento e il funzionamento dei modelli di Ia richiedono una potenza di calcolo enorme, che si traduce in un fabbisogno energetico colossale.
Questa nuova domanda, per la sua necessità di essere costante e affidabile 24 ore su 24, non può essere soddisfatta dalle sole rinnovabili intermittenti. Di conseguenza, in attesa di accumulatori più potenti e di piccoli impianti nucleari, si sta assistendo a una rinascita del gas naturale come fonte energetica di backup e primaria per alimentare questi giganti digitali. In Italia, grandi utility come A2A stanno proponendo che le nuove centrali a gas ad alta efficienza vengano utilizzate per garantire la stabilità della rete e soddisfare le necessità dei futuri data center.
Il caso di Elon Musk e della sua azienda xAI è emblematico. Per alimentare il suo data center Colossus a Memphis nel Tennessee ha installato 35 turbine a gas. Per il suo prossimo mega-progetto, che prevede un milione di processori e un consumo energetico stimato pari a quello di 1,9 milioni di case, ha addirittura acquistato una centrale elettrica all’estero per spedirla negli Stati Uniti, data l’impossibilità di costruirne una nuova in tempi brevi. Questo dimostra come la rivoluzione dell’Ia, almeno nel breve e medio termine, sarà alimentata in gran parte dai combustibili fossili.
Per l’Europa la crisi ucraina ha agito come un brutale acceleratore di realtà, smascherando le fragilità strutturali delle sue politiche energetiche. Il Green deal si è scontrato con l’amara verità della geopolitica. La necessità impellente di affrancarsi dalla dipendenza dal gas russo ha innescato una corsa frenetica alla diversificazione che, nel breve termine, ha significato un ritorno pragmatico e doloroso proprio a quei combustibili fossili che si volevano abbandonare. In tutta l’Ue, la domanda di carbone è tornata a crescere quest’anno per garantire la stabilità della rete, con la Germania che, dopo aver chiuso i suoi impianti nucleari, ha visto un aumento dell’11 per cento nella generazione fossile. Berlino prevede comunque di dismettere gradualmente le centrali a carbone entro il 2030 anche se l’obiettivo appare poco realistico. In Polonia nel 2024, la produzione di energia da questo combustibile rappresentava circa il 56,7 per cento del mix elettrico nazionale, nonostante una crescente quota di energia da fonti rinnovabili che ha raggiunto il 29 per cento nello stesso anno.
Per sostituire le forniture russe di metano, l’Europa si è lanciata in una competizione globale per accaparrarsi carichi di Gas naturale liquefatto (Gnl), investendo miliardi in nuove infrastrutture come i terminali di rigassificazione. Si è così creato un paradosso: per garantire la sicurezza energetica oggi, l’Europa rischia di cadere in una nuova dipendenza a lungo termine dal gas fossile importato, rendendo il percorso verso la neutralità climatica più tortuoso. Questa crisi ha messo a nudo una verità fondamentale: la transizione energetica non è solo una questione tecnologica, ma è prima di tutto una questione di sicurezza nazionale.
Il ritorno dei combustibili fossili non è solo una questione di domanda o di geopolitica, ma anche di strategie interne. Si sta assistendo a un cambiamento nel clima politico in molte nazioni occidentali, con una crescente reazione contro le politiche di decarbonizzazione considerate troppo rapide o costose. Negli Stati Uniti, l’amministrazione Trump ha dichiarato una vera e propria guerra alle rinnovabili, implementando una serie di misure per sostenere l’industria fossile: dall’espansione delle estrazioni su terre federali alla classificazione del carbone come fonte «pulita», fino al taglio dei finanziamenti per le tecnologie verdi. Le previsioni indicano un calo del 23 per cento nei nuovi impianti di energia pulita entro il 2030 rispetto agli scenari precedenti.
Questo trend non è isolato. In Europa la presidente della Commissione Ursula von der Leyen è costretta ad ammorbidire il Green deal sotto la pressione dell’industria. E un’eventuale ascesa dei partiti conservatori potrebbe tradursi in un rallentamento delle politiche di decarbonizzazione. Programmi politici come quelli dei Conservatori e Riformisti europei (Ecr) o dei Tory o Reform Uk nel Regno Unito puntano sulla competitività industriale e sulla sicurezza energetica: la leader conservatrice Kemi Badenoch ha detto che il suo partito rimuoverà tutti i requisiti di zero emissioni nette per le compagnie petrolifere e del gas e promettendo di «estrarre tutto il petrolio e il gas dal Mare del Nord». Si rinnova il «pragmatismo» energetico, che spesso si traduce in un rinvio degli obiettivi climatici più ambiziosi.
Il quadro che emerge è quello di una transizione energetica piena di contraddizioni. Non stiamo assistendo a una semplice sostituzione, ma a un’espansione complessiva del sistema energetico globale, in cui le nuove tecnologie pulite si aggiungono, piuttosto che soppiantare, le vecchie fonti fossili. Il vero motore è la crescita esponenziale della domanda, ora ulteriormente amplificata dalla rivoluzione dell’Ia. La dura realtà è che il mondo è ancora profondamente dipendente dai combustibili fossili, e la strada verso un sistema veramente sostenibile è molto più lunga e complessa di quanto si potesse immaginare. La resilienza dei fossili non è un’anomalia, ma il sintomo di un mondo che, di fronte alla fame di energia e all’incertezza politica, sta riscoprendo la tentazione del rinvio.
La chiave per navigare questo scenario sarà la capacità di coniugare innovazione tecnologica, politiche energetiche realistiche e lungimiranti, e una gestione pragmatica delle dinamiche geopolitiche ed economiche. Spingere troppo rapidamente verso la decarbonizzazione senza tener conto delle esigenze di sicurezza e sviluppo rischia di compromettere la stabilità globale. Allo stesso tempo, ritardare la transizione significa aggravare i rischi sociali ed economici legati ai cambiamenti climatici. Un bel dilemma.