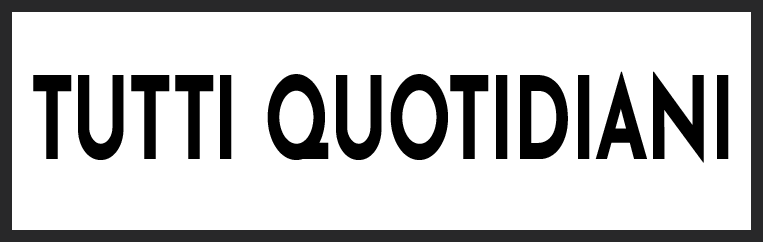Enzo Tortora, uno scandalo nazionale
- Postato il 20 settembre 2025
- Di Panorama
- 2 Visualizzazioni


Con le ultime volontà, Enzo Tortora chiese che gli mettessero nella bara la Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni che denunciava l’arrogante abuso del potere giudiziario. Ma, certo, nel tempo passato in prigione e nei giorni di udienza ai processi, deve aver richiamato alla memoria anche Il processo di Franz Kafka. Eccone l’incipit: «Qualcuno doveva aver calunniato Josef K. perché, senza che avesse fatto nulla di male, una mattina fu arrestato».
Tortora non sapeva di che cosa lo incolpassero né su quali presupposti si basassero le accuse contro di lui ma, senza dirgli niente, lo portarono via. Era il volto “perbene” della televisione, un uomo considerato affidabile per garbo e sincerità. Mentre era ospite dell’Hotel Plaza di Roma (17 giugno 1983) lo ammanettarono e – dopo un calvario mediatico e giudiziario – diventò l’immagine della malagiustizia.
E pensare che era al culmine della carriera. Tortora aveva ideato un programma innovativo che anticipò gli spettacoli di varietà di là da venire: un po’ informazione e un po’ divertimento, personaggi anche strani che propagandavano le loro invenzioni e un gioco con il pappagallo che veniva incoraggiato a parlare. In onda il venerdì, il suo pubblico raggiungeva 28 milioni di persone. Si chiamava Portobello.
E Portobello è il titolo della serie televisiva-denuncia che Marco Bellocchio ha “firmato” per presentarla all’ultimo festival di Venezia. Fabrizio Gifuni nel ruolo del protagonista a dare conto, in fotogrammi spaventosi, dell’agghiacciante sorpresa di chi veniva accusato di eventi di cui non aveva memoria, da persone mai viste, per circostanze del tutto estranee. Come sentirsi precipitare in una malabolgia dell’infermo.
A metterlo nei guai – inizialmente – furono le dichiarazioni di Giovanni Pandico, Gianni “il bello” Melluso e Pasquale Barra, tre pregiudicati variamente affiliati ai clan della camorra che avevano vestito i panni dei “pentiti”, accettando di denunciare i complici in cambio di un trattamento favorevole della legge.
In quel periodo la magistratura faceva largo uso dei collaboratori di giustizia. Si era cominciato a utilizzarli nelle inchieste sul terrorismo e poi, per analoga corrispondenza, nei confronti delle bande criminali di origine mafiosa. Innegabile il vantaggio di disporre di una voce che, da dentro le organizzazioni malavitose, fosse in grado di raccontare lo svolgimento di alcuni delitti, eseguiti per mano di chi e per volontà di quali mandanti.
Ma altrettanto evidente c’era il rischio che il “pentito” non fosse affatto pentito. La storia giudiziaria ne conta un numero discreto. Finsero per inquinare le indagini, vendicarsi di nemici o di ex amici.
Chi accusò Tortora lo fece probabilmente per vanitosa arroganza. Pandico, dal quale prese avvio l’intero procedimento, aveva spedito al presentatore alcuni centrini fatti all’uncinetto perché fossero venduti all’asta durante la trasmissione Portobello. La redazione, oberata da materiale in arrivo da mezza Italia, li aveva smarriti e Tortora – da gentiluomo qual era – scrisse a Pandico una lettera di scuse includendo un indennizzo di 800 mila lire. Ma il detenuto non apprezzò e prese a spedire messaggi sempre più intimidatori fino a minacciare rappresaglie. Che, alla fine, si concretizzarono nell’accusarlo di essere un affiliato della camorra.
Dall’altro lato, coloro che, per dovere, avrebbero avuto l’obbligo di cercare qualche riscontro concreto non lo fecero e si limitarono a considerare attendibili quelle invenzioni.
La notorietà del personaggio rese ghiotta la vicenda e sollecitò tanti ad approfittarne. Un’altra dozzina di pregiudicati si accodarono per confermare le imputazioni a cominciare dal “killer dei cento giorni” Michelangelo D’Agostino, un cane sciolto della camorra. E Giuseppe Margutti, un pittore che aveva dimestichezza anche con le truffe insieme alla moglie Rosalba Castellini, assicurò di aver visto Tortora spacciare droga in un retropalco degli studi televisivi di Antenna 3.
L’unico elemento che, per gli iter processuali, poteva rappresentare un elemento “oggettivo” di addebito consistette nell’appunto trovato nell’agenda di “o’ Giappone” Giuseppe Puca. In una pagina compariva un nome che, frettolosamente, venne letto come se si trattasse di “Tortora” con accanto un numero. Nessun accertamento che, pure, non avrebbe comportato enormi sforzi di verifica. Ci vollero anni perché qualcuno si preoccupasse di controllare scoprendo che il manoscritto si riferiva a un “Enzo Tortona” con la “enne” al quale, per l’appunto, corrispondeva il recapito telefonico.
L’indagine che coinvolse il presentatore di Portobello riguardò altri 855 imputati – camorristi o presunti camorristi -, comportò un atto di 3.800 pagine e portò ad arresti a raffica, soprattutto, in Campania, Lazio, Lombardia e Sardegna.
Come difendersi dai pregiudizi? Lo arrestarono ma, prima di portarlo in carcere attesero che i reporter – ma proprio tutti – fossero in agguato all’ingresso dell’hotel, in modo da fotografarlo in manette mentre lo portavano via. E i giornali (con irrilevanti eccezioni) sposarono le tesi della Procura facendosene, di fatto, i portavoce.
Tortora rimase 271 giorni nel carcere di Bergamo. Poi (17 gennaio 1984) gli concessero la libertà provvisoria. Accettò la candidatura del Partito Radicale di Marco Pannella e venne eletto al Parlamento europeo (17 giugno 1984).
In quei mesi la gente andava al cinema per vedere Non ci resta che piangere e cantava Terra promessa di Eros Ramazzotti. In Italia era la stagione di Bettino Craxi premier a Palazzo Chigi.
Il processo che coinvolse Tortora, riguardando un’infinità di episodi e di imputati, si declinò percorrendo mille rivoli. Nell’ultimo giorno di udienza, i giudici, pronti per la camera di consiglio, chiesero se qualcuno avesse una dichiarazione finale. Tortora, con voce indebolita dalle traversie ma senza affettazione, scandì: «Io sono innocente e, dal profondo del cuore, spero che lo siate anche voi». Diciassette gennaio 1985: lo condannarono a 10 anni.
Per ottenere giustizia dovette attendere il 15 settembre 1986: con il processo d’appello la Corte lo assolse con formula piena. Il 17 giugno 1987, a quattro anni dal suo arresto, la Cassazione confermò. Il ribaltamento della sentenza fu il risultato di un lavoro più appropriato di cui si fece carico Michele Morello, che avrebbe dovuto sostenere l’accusa. «Per comprendere la questione» precisò in seguito il magistrato «volli ricostruire il processo in ordine cronologico. Cominciai dalla prima dichiarazione fino all’ultima, rilevando che s’intrecciavano in maniera troppo sospetta». Sembrava che il secondo accusatore “copiasse” il primo e che il terzo facesse affidamento sulle parole del secondo. Del resto, stando tutti insieme alla caserma dei Carabinieri di Napoli, non dovette essere difficile confrontarsi (e concordare le versioni dei fatti) prima di riempire verbali di interrogatorio. «Perciò si trattò di verificare le circostanze che venivano descritte». Risultato? «I conti non tornavano. Di un centinaio di controlli, la maggior parte risultò senza riscontri e per gli altri trovammo indicazioni, addirittura, a favore dell’imputato». Questo lavoro non era possibile realizzarlo prima? «Anche i magistrati soffrono di simpatie e antipatie e Tortora, in aula, fece di tutto per dimostrarsi antipatico ricusando i giudici napoletani perché non si fidava di loro».
In realtà, tutti quelli con qualche dimestichezza per le procedure giudiziarie erano già convinti che le accuse si appoggiassero sul nulla. E che l’errore consistette nel trascinarla per le lunghe.
Restaurato nell’onore, Enzo Tortora rifiutò offerte di lavoro anche molto vantaggiose. Volle ritornare a Portobello per rivolgersi di nuovo al suo pubblico in un attesissimo «Dunque, dove eravamo rimasti?». Aveva lo sguardo provato ma gli scintillavano gli occhi. Trafitto nel fisico ma fiero nel morale.
Dicono che non esistono prove che la sua morte per cancro (18 maggio 1988) sia stata provocata dal calvario subìto. Ma non servono esperti per intuire che le ingiustizie possono accendere il detonatore di malattie latenti. E renderle irreversibili.