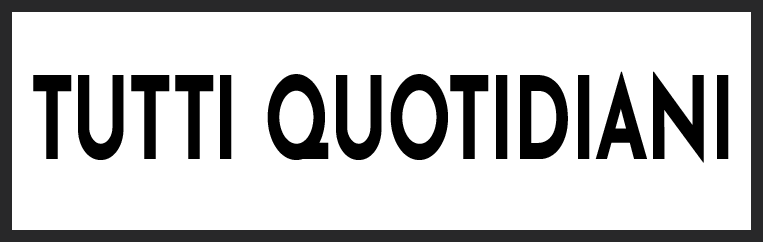Giovanni Battaglin: "Spinte, furbate e anfetamine nel ciclismo eroico anni ’70 Per vincere rinunciai al sesso"
- Postato il 26 ottobre 2025
- Sport
- Di Libero Quotidiano
- 3 Visualizzazioni

Giovanni Battaglin: "Spinte, furbate e anfetamine nel ciclismo eroico anni ’70 Per vincere rinunciai al sesso"
Quando la strada cominciava a salire, e lui decideva di partire, erano guai per tutti e non importava che tu fossi un gregario, un ragazzino o Eddy Merckx: Giovanni Battaglin ti staccava comunque. Già, perché era uno scalatore fenomenale degli Anni ’70 e ’80, ma pure un buon passista capace di conquistare tappe in tutti i Grandi Giri. E - nel 1981- di compiere un’impresa storica: trionfare alla Vuelta di Spagna e al Giro d’Italia in soli 48 giorni. Battaglin, che ha 74 anni, ora è in pensione e si racconta. Gli inizi («Ho esordito a 18 anni»), un ciclismo selvaggio («Quante scorrettezze: i big si facevano trainare»), i successi, l’azienda di famiglia e il dramma della figlia Francesca.
Giovanni Battaglin, questa esposta che bici è?
«Quella della vittoria delGiro d’Italia del 1981».
Sembra un pezzo d’antiquariato rispetto ai modelli di oggi.
«Lo è. Venga, le faccio vedere le biciclette che produciamo adesso qui, nell’azienda che ho fondato nel 1981 e che ora si chiama “Officina Battaglin”. Vede? Dieci anni fa abbiamo deciso di mollare il carbonio, che è un po’ una moda, per tornare a questi telai d’acciaio. Produciamo bici artigianali e personalizzate per amatori e le vendiamo on-line. Sono prodotti di nicchia e ne realizziamo circa 700 l’anno, soprattutto per l’estero: America, Europa e perfino India».
[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:44728307]]
Quanto costano?
«Dai 5 mila ai 20mila euro, dipende dal modello».
Fate anche E-bike?
«No, troppo complicato stare dietro all’evoluzione dei motori e delle batterie».
Ma lei è un purista della bici muscolare o accetta l’idea della pedalata assistita?
«Per chi ha una certa età va benissimo un aiutino: evita di fare sforzi pericolosi».
Lei quale usa?
«Nessuna delle due».
Scherza, vero?
«Non esco più in bicicletta da 5 anni, c’è troppo traffico».
Non le manca pedalare?
«Per niente, anche perché ho già dato a sufficienza: nella vita ho fatto più di un milione di km. E comunque ora non avrei tempo: do una mano a mio figlio Alessandro in azienda e, poi, c’è la caccia».
Ama sparare?
«Lo facevo già quando gareggiavo: al Giro di Lombardia ho partecipato solo due volte, sa perché?».
No.
«Si corre a ottobre, nel periodo migliore perla caccia, e preferivo andarmene in Croazia in cerca di beccacce. Questa è una passione che mi rilassa tanto, ce l’ho fin da ragazzino».
Torniamo indietro nel tempo, allora. Al piccolo Giovanni.
«Nasco qui a Marostica, anzi nella frazione San Luca, il 22 luglio 1951. Papà Pietro fa il bombarolo e piazza esplosivi per far spazio agli invasi delle dighe, mamma Ermida è casalinga».
Figlio unico?
«Due sorelle: Rita e Loretta».
Raccontava della passione per la caccia.
«Me l’attacca papà, che mi porta in un capanno strategico: lì vicino passano, bassissimi perché c’è la collina, migliaia di uccelli migratori».
Quando inizia a sparare da solo? Perché quel sorriso furbo?
«A 11 anni ovviamente non ho la licenza, ma quando torno a casa da scuola prendo il fucile a una canna di mio padre, lo nascondo sotto il giaccone e, senza dire niente a nessuno, vado nei campi coltivati in cui gli uccelli si fermano a mangiare sui cachi: pum pum pum, faccio fuori due tasche di cartucce».
La caccia crea dibattiti feroci: molti sono contrari.
«Guardi, io non sono d’accordo con chi ammazza centinaia di uccelli, ma finché ne uccidi 15 o 20 non succede niente. È selezione naturale. Ne muoiono di più a causa del veleno che si trova nella vegetazione».
Torniamo alla sua adolescenza. Scuole?
«Elementari e avviamento, ma non ho troppa voglia di studiare».
Meglio pedalare?
«In realtà io mi appassiono soprattutto alle parti meccaniche: passo le giornate a smontare i pezzi più nuovi della bicicletta di papà e rimontarli sulla mia. A gareggiare, in quel momento, non ci penso proprio».
Non vede il ciclismo come sport?
«Preferisco giocare a pallone: con gli amici sfidiamo i paesi vicini».
Ruolo?
«Difensore, me la cavo bene e il mio idolo è Rivera».
Quando molla la palla per le due ruote?
«A 17 anni e per caso».
Cioè?
«Per arrivare a casa a San Luca c’è un piccolo strappo di 300 metri in sterrato. Un giorno, mentre pedalo, mi vede un vecchietto: “Coma vai te in salita ce n’è pochi. Devi correre, vedrai che hai successo”. Lo ringrazio, ma non ci do peso».
Poi?
«Dopo qualche tempo, il 29 giugno 1968, io e un amico andiamo a seguire una gara. C’è una salita impegnativa di 8 km che è aspra, vediamo passare un gruppetto e commentiamo entrambi: “A questa velocità possiamo farla anche noi”».
Ci provate?
«Sì e ci appassioniamo, tanto che in inverno entriamo nella squadra Junior Nove con la quale cominciamo ad allenarci».
E la bicicletta?
«Ne recupero una bellissima, verde pistacchio, che però è tre taglie di troppo: io ho una 54 e quella è una 57».
Prima corsa?
«A Orsago, la ricordo bene».
Perché è un un trionfo?
«Macché. Ci sono 200 corridori e parto in prima fila, ma non sono capace di stare in gruppo- per me è la prima vola -, ho paura, mi sfilo e in poco tempo mi ritrovo in coda, staccato di 400 metri. Alla salita finale, però, inizio a rimontare, ne prendo uno e poi due e aggancio il gruppetto dei primi».
Poi impara?
«Già alla seconda gara capisco la lezione e resto davanti così, nelle corse successive, arrivano i risultati: secondo, terzo, quinto, quarto».
Mai primo posto?
«Campionato provinciale a Vicenza, vado in fuga da solo e guadagno minuti, sto volando verso il traguardo e, improvvisamente, da una strada parallela sbucano in tre. “Sarà gente che si è ritirata”, penso. Invece mi precedono, fanno la volata e vincono. Resto di sasso, chiedo spiegazioni: “Guarda che hai sbagliato strada”, rispondono. E io: “Ma come, stavo seguendo la staffetta e l’auto dell’organizzatore!”. Risultato: mi danno un mese di squalifica che devo scontare nella stagione successiva».
Che beffa.
«È la prima grande ingiustizia di una carriera che in seguito sarà caratterizzata anche da molta sfiga: cadute, intossicazioni alimentari, epidemie di congiuntivite, bici volanti che mi arrivano addosso».
A 21 anni, però, inizia a vincere per davvero. E guadagnare i primi soldi.
«Nel 1972 vado forte e prendo 400mila lire al mese, quando lo stipendio di un operaio è di 60mila. Trionfo al Giro d’Italia dilettanti e inizio a farmi conoscere come scalatore».
Già, la salita. Parliamone.
«Quando la strada va su ti scatta qualcosa dentro. È dura, ma se sei uno specialista fai meno fatica degli altri».
Il più grande scalatore?
«Lo spagnolo Fuente è il migliore dei miei tempi. Talento puro anche se a volte è ingestibile e attacca un po’ a caso. Ed è simpaticissimo: in hotel, a fine corsa, si siede in corridoio e fuma sigari giganteschi. “Cabron vieni qui- mi dice- domani attacchiamo, eh?”».
In Italia uno dei più forti di sempre è considerato Marco Pantani.
«Per un periodo il Pirata corre con una bici della mia azienda e lo conosco bene. È bravo, in gamba, ma col tempo cambia un po’. Anche il ciclismo, però, nel frattempo è cambiato».
Cioè?
«Alla fine degli Anni ’80 iniziano a girare troppi medicinali e troppe porcherie, quelli sono periodi burrascosi. Ora, per fortuna, è rientrato tutto: con i controlli di adesso è impossibile sgarrare».
Ai suoi tempi invece?
«L’unico doping, in quegli anni, è l’anfetamina. Ma io non la prendo mai».
Però con le sostanze proibite ha dei guai.
«Seconda ingiustizia della carriera. Nel 1979, al Tour de France, sono in forma e in classifica tallono Hinault, ma ho un po’ di raucedine per aver corso sotto l’acqua. Il medico, allora, mi dà una pastiglia. Dopo due giorni la gendarmeria mi consegna una lettera: mi hanno trovato positivo».
Per quale sostanza?
«“Zerinol”, un farmaco per la gola che si prescrive anche ai bambini e che il dottore, che non è del settore, non sa che in quell’anno è considerato doping. Risultato: mi danno 10 minuti di penalità e alla fine arrivo sesto in classifica generale».
Riprendiamo con la carriera. Dopo il successo al Giro dilettanti, nel 1973 diventa professionista.
«Ci arrivo preparato grazie agli allenamenti che faccio, nei mesi prima, con Marino Basso, neo campione del mondo, Farisato e Tumellero.Il passo è diverso e dopo soli 15 giorni mi sembra di volare».
Prima squadra prof?
«Mi vogliono alla Bianchi, ma la sera prima di firmare mi chiama il ds della Jolly Ceramica: “Giovanni, hanno deciso di costruire una formazione di professionisti per te. Resta e sarai il corridore di punta”».
Lei accetta e firma un contratto di tre stagioni. Battaglin che tipo di capitano è?
«Tratto i gregari da compagni, addirittura fratelli come nel caso di Luciano Loro, ragazzo eccezionale. Non come altri colleghi...».
Cioè? Facciamo qualche esempio per capire meglio i vari leader: partiamo da Merckx.
«Eddy ha una classe e un carisma mostruoso, più consuma i compagni e più lo adorano. Anche perché fa guadagnare loro molti soldi».
Gimondi?
«Meno ruvido di Merckx, ma comunque duretto: se non gli obbedisci si arrabbia».
Moser e Saronni?
«Con Francesco non si scherza, mentre Beppe è duro ma più educato. E ha più pudore nel farsi spingere».
In che senso farsi spingere?
«Eh, quello di quegli anni è un ciclismo selvaggio, da Far West, in cui succede un po’ di tutto».
Tipo?
«Grandi campioni che si aggrappano alle moto dei fotografi osi avvinghiano ai gregari in salita, attaccandosi ai loro pantaloncini e, quando sono spremuti, li usano per lanciarsi in avanti. Come quella volta che Saronni... ».
Racconti.
«Tirreno-Adriatico del 1974, “muro” di Ferentino: Beppe utilizza il povero Luciano Conati come fionda, il quale però, rinculando, mi stende rompendomi lo scafoide».
Urca. Ma nessuno dice niente contro le spinte?
«Io lo trovo ingiusto, odioso, mi incazzo e lotto molto per cambiare queste usanze: in corsa non voglio nemmeno essere toccato. I giudici, però, hanno un occhio di riguardo per i corridori più amati dai tifosi e dai giornalisti».
Un altro super corretto come lei?
«Tista Baronchelli, grande corridore ma troppo buono, cuore puro: con più cattiveria avrebbe vinto due Giri».
Torniamo alle sue imprese. Primo anno da prof e subito un terzo posto al Giro del 1973, alle spalle di Merckx e Gimondi. Mica male.
«Sono secondo fino alla fine, ma mi frega la pioggia e qualche caduta di troppo. Però spavento i big».
Come è la vita da professionista al Giro?
«Dura e faticosa, anche perché, rispetto a oggi, non esistono radio o auricolari. E non ci sono nemmeno le ammiraglie che ti portano da bere, si fa tutto da soli».
Le borracce, durante la corsa, come le riempite?
«I gregari fanno l’assalto alle fontane o ai bar che si trovano sul tragitto: arraffano tutto il possibile e poi dicono “Paga Torriani”. E la sera, in albergo, arriva il conto».
Alimentazione?
«La mattina, prima di ogni tappa, appena svegli, si fa colazione e dopo mezz’ora già si pranza: riso alla parmigiana, filetto e frutta. Tutti i giorni sempre così, da nausea».
Come è il rapporto tra corridori?
«Nelle frazioni lunghe facciamo i primi 20 km a tutta, poi si “passeggia” a 30 all’ora fino a 60 km dall’arrivo: è il momento per chiacchierare e scherzare».
Curiosità stupida: ma per i bisogni?
«C’è chi si fa la pipì addosso pedalando e chi la fa in coda al gruppo. Io, invece, mi fermo sempre appena trovo uno posto riparato».
Diatriba storica: il sesso fa male ai ciclisti?
«Se vuoi vincere devi rinunciarci. Io, in quegli anni, lo evito anche per mesi. E ne vale la pena».
Proseguiamo. Nel 1975 sembra destinato a vincere il Giro, ma crolla.
«Sono in maglia rosa e, a Campobasso, alcuni ragazzini lanciano delle puntine da disegno sull’asfalto. Buco e mi fermo, passano tre compagni Gavazzi, Bergamo e Bertoglioma nessuno mi dà la sua bici come dovrebbe. Così la squadra si spacca. Ma soprattutto, alla vigilia della cronoscalata del Ciocco, anziché sfruttare il giorno di riposo mi obbligano a provare la salita. E mi imballo, perdendo maglia e Giro».
Nel 1979 passa alla Inoprax e, con la Nazionale, partecipa ai Mondiali di Valkenburg in Olanda: sta per vincere, ma la fanno cadere nella volata finale.
«Terza ingiustizia della carriera, la più grande. Un vero furto. Trionfa Raas, che ha pedalato per km al traino delle moto della tv e che, nel finale, mi spinge a terra contro le transenne».
Racconti meglio.
«Manca poco all’arrivo, alzo la testa e vedo il cartello dei 150 metri al traguardo: siamo in quattro a ventaglio, ancora tutti seduti sul sellino e capisco che il primo che parte a tutta vince. Mi alzo sui pedali, scatto, ma vengo chiuso verso le transenne e cado. Scorrettezza ignobile che la giuria non punisce».
Giovanni, il 1981, invece, è l’anno dell’impresa leggendaria: vince Vuelta e Giro in soli 48 giorni.
«Impensabile, inimmaginabile. Partenza in Spagna il 21 aprile e mi accorgo che i corridori di casa sono aggrappati alle transenne con i pedali già agganciati per non perdere tempo. E mi dico: “Sarà guerra”. Anche perché fa freddo e non sono previste pause».
Dopo otto giorni, invece, prende la maglia “amarillo”, che poi tiene fino alla fine. Trionfando.
«Molto merito è della squadra, fondamentale. Nemmeno il tempo di festeggiare, però, e inizia il Giro: arriviamo a Milano il lunedì e il mercoledì c’è la prima tappa».
Lei parte favorito?
«No, nessuno mi considera pensando che sia affaticato e spremuto. Invece sto bene e non ho malanni».
Stupisce tutti e, alla terzultima tappa, sfila la maglia rosa a Contini sulle Tre Cime di Lavaredo.
«Una salita micidiale, 6 km in piedi che sembra non finire mai. Io, però, rispetto agli altri ho una marcia in più».
Nel senso che è più determinato?
«No, proprio letteralmente. Tutto merito di quanto mi invento l’anno prima al “Brescia Tour”, dove c’è da salire sul Valcava, uno sterrato al 17 per cento di ripidità».
Cioè?
«La sera prima della tappa mi viene l’idea giusta. In quel periodo il cambio ha solo due corone di moltiplica davanti e, così, decido di provare a inserire una terza coroncina: prendo le misure e disegno il progetto su carta. Il meccanico modifica tutto, però mi spiega che cambiando dovrò dare un colpetto al deragliatore con la mano, senza rallentare, per non far cadere la catena».
Funziona?
«Arrivo all’inizio della salita, abbasso la testa, mi chino e tac, do il colpo decisivo: la bici inizia decollare».
Quindi anche sulle Tre Cime di Lavaredo stacca tutti con la terza marcia?
«Sì, sono l’unico a usarla e volo verso la vittoria del Giro».
Tre anni dopo l’impresa storica, nel 1984, decide di ritirarsi definitivamente. Perché?
«Ho una spalla rotta che non si può sistemare, diventa tutto una sofferenza senza senso».
Battaglin, ultime domande veloci. 1) Rapporto con la religione?
«Sono credente, ma non praticante».
2) Paura della morte?
«Non più da quando, quasi due anni fa, ho perso mia figlia Francesca. Aveva solo 40 anni e la sua morte ha tolto la vita anche a me e mia moglie Sonia. I genitori non dovrebbero mai perdere un figlio».
3) Ha guadagnato molto con il ciclismo?
«Gli ingaggi migliori erano quelli dei circuiti: l’impresario stabiliva una cifra, che però veniva decurtata se non ti eri impegnato e dimezzata se ti ritiravi. Dopo Giro e Tour giravamo due mesi tra Belgio, Francia e Olanda: correvo anche su due circuiti in un giorno, poi salivo su un aereo, disputavo una gara pre-mondiale in Italia e tornavo in Belgio la sera stessa».
4) Il corridore più forte di oggi?
«Pogacar. È un fenomeno ai livelli di Coppie Merckx».
5) C’è un nuovo Battaglin?
«Non mi sembra. Ai miei tempi i campioni erano tanti, ora ce ne sono solo 3 o 4».
Ultimissima domanda: lei è scaramantico?
«Sì. Quando gareggiavo portavo sempre in valigia un disegno su pietra fatto da mio figlio Alessandro».