Il mito del digiuno: la tendenza social che promette salute e regala malattie
- Postato il 27 settembre 2025
- Di Panorama
- 2 Visualizzazioni

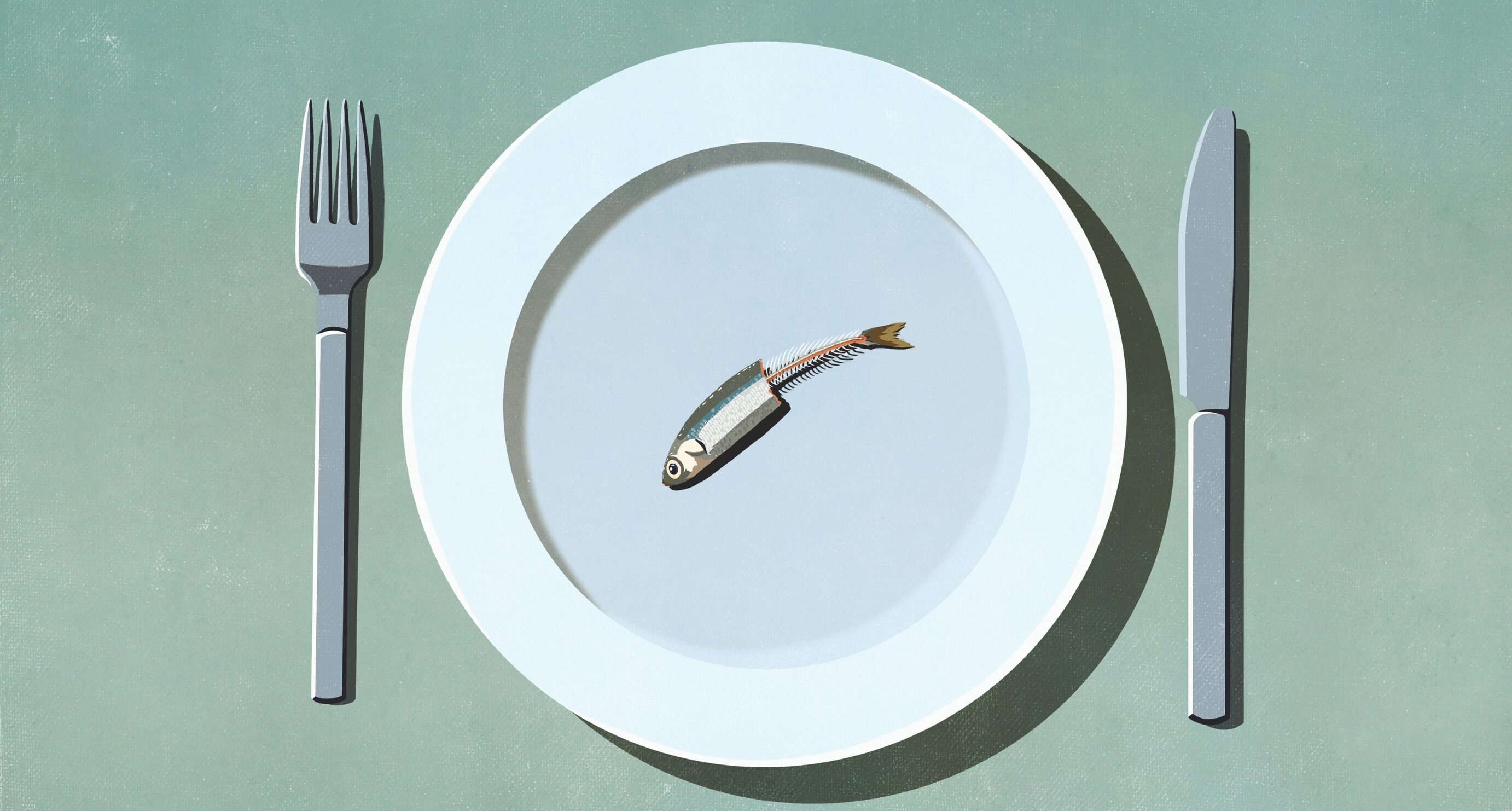
Il digiuno è uscito dai monasteri per approdare su Instagram. Da pratica antica con profonde radici religiose, spirituali e di protesta civile, è diventato la nuova frontiera del benessere: trasformandosi in una tendenza globale che spopola tra social media, applicazioni e guru improvvisati che promuovono il digiuno come ricetta di salute e longevità. A guidare il popolo dei nuovi “asceti digitali” è Raz Degan, antitesi gandhiana che dall’alto dei suoi più di 400 mila follower, decide lo scorso agosto di lanciare sul social «il primo digiuno collettivo della storia in Italia». Quarantotto ore di sola acqua e 3 mila persone che si iscrivono in pochi giorni all’evento, affrontando questa improvvisata maratona della fame.
Ma se la promessa è quella di un corpo più leggero, di un metabolismo rigenerato e di un fisico da urlo – spoiler, non funzionerà – la realtà è molto più complessa. Districarsi tra tutti i tipi di restrizioni, dall’intermittente al 5:2 (5 giorni di nutrizione normale e due di dieta) fino al mima-digiuno (vedi riquadro nella pagina successiva) e a tanti altri, può rivelarsi molto rischioso. «La dieta non è mai un atto neutro: è sempre un atto terapeutico, e come tale deve partire da una diagnosi medica» spiega a Panorama il professor Emanuele Rinninella del reparto di nutrizione clinica del Policlinico Gemelli Irccs di Roma. «Iniziare un digiuno scriteriato, senza capire le reali cause del sovrappeso o del malessere rischia di mascherare patologie importanti, come diabete, patologie epatiche o malattie cardiovascolari. Il primo errore è quello di banalizzare il sovrappeso e di non leggere i segnali del corpo come un campanello d’allarme; se non si intercettano i bisogni di salute che sono alla base dei chili in più si rischia di perdere tempo prezioso nel curarli».
C’è poi un secondo aspetto, strettamente correlato alla nostra pessima abitudine di indirizzarci verso soluzioni impulsive, veloci e non durature. Vogliamo tutto e subito, senza considerare che la “via breve” tipicamente finisce male, e spesso in un vicolo cieco. «Una delle conseguenze più importanti del digiuno fai da te, o comunque delle diete ultra-restrittive è il rischio di deficit di macro e micronutrienti» prosegue Rinninella. «Quando l’apporto calorico è troppo basso, il corpo consuma prima le riserve, ma subito dopo inizia ad attaccare il muscolo, riducendo la massa magra invece di quella grassa. È un punto cruciale: se si danneggia la “massa metabolicamente attiva” e con essa gli organi vitali, si indebolisce il sistema immunitario aumentando la vulnerabilità alle infezioni».
Eppure, il fascino dei digiuni dilaga. Per convincere e auto-convincersi dell’utilità del classico “intermittente”, cioè mangiare qualunque cosa, ma solo in una finestra temporale di 8 ore, e poi passare le successive 16 senza toccare caloria alcuna (per esempio, se si fa colazione alle 7 si può mangiare fino alle 15 e poi a digiuno fino alla mattina dopo) si scomodano persino i premi Nobel: il razionale scientifico di questo tipo di dieta, infatti, si lega al fenomeno dell’autofagia, descritto dal giapponese Yoshinori Osumi, premio Nobel per la Medicina 2016. «L’autofagia è il processo con cui le cellule eliminano i componenti danneggiati al fine di rigenerarsi», conclude Rinninella. «In teoria, il digiuno stimolerebbe questo meccanismo, e quindi il ringiovanimento cellulare e la riduzione dell’infiammazione. Tuttavia, rimane un nodo aperto: non sappiamo con chiarezza dopo quante ore di digiuno si attivi nell’uomo. Alcuni parlano di 16 ore, altri di 24 o addirittura 72, ma le prove sono state condotte soprattutto su animali».
Certezze, al momento, non ve ne sono. Ma se è tutto così sbagliato e negativo, allora perché quando andiamo a letto senza cena – o dopo aver mangiato in maniera frugale – ci capita magari di dormire meglio, di evitarci sogni assurdi e di svegliarci più riposati? Tutto sta nel fatto che il metabolismo è bello perché è vario. «C’è un aspetto che spesso viene trascurato, ed è la variabilità individuale, cioè il fatto che non tutti reagiscono allo stesso modo al digiuno» dice Jessica Falcone, coordinatrice nutrizionista dell’Unità operativa disturbi alimentari dell’ospedale San Raffaele Turro di Milano. «Alcune persone, per genetica o storia personale, tollerano meglio i periodi senza cibo e riescono a sfruttarne i benefici metabolici; altre, al contrario, ne subiscono più facilmente gli effetti negativi. Questo rimanda a un principio essenziale della nutrizione: costruire un regime alimentare ad hoc significa considerare non solo metabolismo e fabbisogni calorici, ma anche fattori come qualità del sonno, livelli di stress, tipo di lavoro e ritmi biologici. Senza questa visione integrata, ogni pratica rischia di diventare insostenibile».
Inoltre, la sensazione di benessere che alcuni provano saltando un pasto deriva in parte anche da un olistico ritorno a principi antichi di crono-nutrizione, cioè l’allineamento dei ritmi alimentari con quelli biologici della luce e del buio. «I nostri nonni, che cenavano alle 18 e andavano a letto presto, rispettavano naturalmente questi meccanismi», conclude Falcone. «Oggi, invece, tendiamo a mangiare molto tardi la sera e saltare la colazione, un’abitudine che contrasta con i nostri ritmi ormonali e metabolici ottimali che – questi sì – possono realmente apportare diversi benefici, anche senza diete estreme e digiuni fantasiosi».
Fantasiosi come il celeberrimo 5:2, cioè 5 giorni di alimentazione libera e senza restrizioni e poi 2 durante i quali si possono assumere al massimo 500 o 600 calorie: questo regime, spinto da molti improvvisati influencer del benessere che su TikTok magnificano i suoi straordinari risultati è in realtà uno schema privo di evidenze cliniche e al di fuori di ogni logica scientifica: uno studio randomizzato portato avanti dalla Queen Mary University of London ha dimostrato che non è sostenibile a lungo termine e ha effetti molto modesti se comparato alle diete tradizionali. Mentre, come tutti i tipi di digiuno, ha forti effetti collaterali, perché i giorni di ingente restrizione calorica possono causare affaticamento, vertigini, debolezza e stress metabolico e ormonale. E per chi ha una predisposizione psicologica, il digiuno può addirittura diventare un trigger, cioè un fattore scatenante di disturbi alimentari, trasformandosi da pratica di benessere in un elemento di rischio clinico.
Da Gandhi a Raz Degan, il passo è stato breve. Non solo abbiamo svilito il digiuno, trasformandolo da pratica ascetica e strumento di lotta pacifista in un banale tentativo di piacerci di più davanti allo specchio, ma abbiamo anche fallito: rischiando di ottenere l’unico risultato di ammalarci ancora di più e ancora più gravemente.
E con il girovita ancora lì, uguale a sé stesso, a ricordarci che le insensate scorciatoie finiscono sempre contro un muro.




