Il racconto dei reporter di Gaza: “Ogni giorno alla prima esplosione prendiamo la telecamera. Israele non vuole che documentiamo la fame e i crimini contro i civili”
- Postato il 31 agosto 2025
- Mondo
- Di Il Fatto Quotidiano
- 4 Visualizzazioni
.png)
“Ho paura di indossare il giubbotto da giornalista con la scritta PRESS. Temo che sia usato per identificarci e colpirci più facilmente”. La giornata tipo di Hanin Hamdouna comincia ogni mattina alle 6. “Impasto un po’ di pasta e di farina per fare il pane, accendo il fuoco con i resti dei mobili distrutti di casa mia per cuocere quello che ho preparato”. Poi, racconta a Ilfattoquotidiano.it che l’ha raggiunta al telefono a Gaza, “mi preparo per andare a lavorare alla tenda del Centro di Solidarietà”. Hanin, 33 anni, è una giornalista freelance palestinese con alle spalle 11 anni di esperienza. “Da casa mia al centro – continua – devo camminare circa trenta minuti. Le interviste le realizzo con il mio vecchio telefono cellulare, poi produco il mio servizio in ufficio e torno a casa a piedi portando un po’ di lenticchie da cucinare per la mia famiglia”.
Fare il giornalista a Gaza è una missione. Il 26 agosto un raid israeliano ha colpito l’ospedale Nasser, giustiziando di fatto 5 giornalisti palestinesi e suscitando l’indignazione internazionale. Ma sono solo gli ultimi di una lunga lista con oltre 240 nomi di reporter palestinesi uccisi dall’inizio del conflitto. Io stessa, racconta Hanin, “sono sopravvissuta a un massacro in cui sono stati uccisi dei miei colleghi. La tenda in cui lavoravo, nel giardino dell’ospedale dei Martiri di Al-Aqsa, è stata colpita causando la morte di 5 persone e il ferimento di altre”.
A Gaza, dall’inizio delle operazioni di terra, le violenze contro gli operatori della stampa sono aumentate esponenzialmente. Per Baha’a Tobasi, giornalista palestinese e corrispondente a Gaza di Kurdistan TV, i motivi sono chiari: “Israele – dice al telefono a Ilfattoquotidiano.it – vuole controllare la narrativa. Noi documentiamo violazioni e crimini contro i civili e questo non vogliono che accada”. Come le immagini dei bambini malnutriti che hanno fatto il giro del mondo guadagnando le copertine di importanti quotidiani, fra cui quella de Il Fatto Quotidiano. “Siamo riusciti a mostrare la vera immagine della fame a Gaza attraverso scatti crudi e dolorosi, colpendo le coscienze del mondo e imbarazzando Israele davanti ai suoi stessi sostenitori”, sottolinea il giornalista.
E a chi critica i giornalisti palestinesi, accusandoli di essere parziali e di fare il megafono di Hamas, Tobasi risponde: “Noi trasmettiamo il grido delle madri sotto le macerie, non gli slogan delle fazioni. Che sia la fazione X o Y, noi copriamo i bombardamenti sugli ospedali, sulle scuole e sui centri di accoglienza. Non siamo nelle stanze operative militari, come fanno invece i giornalisti israeliani che accompagnano l’esercito israeliano”.
Come per Hanin, anche la giornata di Baha’a comincia all’alba, al suono della prima esplosione o di un grido di aiuto. “Ognuno di noi prende la propria videocamera e prepara l’attrezzatura giornalistica”. Il racconto accellera. “Cerco innanzitutto di capire dove sia stato l’attacco israeliano e chi sia stato colpito stavolta, una tenda, un gruppo di cittadini in fila per prendere acqua salata o dolce, oppure persone che vanno a prendere cibo da una mensa di beneficenza a Gaza”. Poi c’è il pellegrinaggio nei luoghi della morte. “Mi sposto tra ospedali, luoghi bombardati e centri di accoglienza, raccolgo immagini, ascolto le testimonianze di madri e bambini, prendo appunti o piango, o entrambe le cose”, dice parlando a telefono con naturalezza. “Come sai, le madri raccontano tantissime storie strazianti e nemmeno tutte le telecamere del mondo basterebbero a rendere giustizia alle loro sofferenze — che sia la perdita di un figlio, di un marito o di tutti i bambini di una famiglia”. Scrive in fretta, invia i materiali. “Può capitare – dice Tobasi – che non mangi per tutta la giornata e che non riesca nemmeno a tornare alla mia tenda”.
Ora, a telefono, il giornalista si ferma: come se avesse dimenticato qualcosa. “A proposito, io stesso ho lasciato la mia casa e non so quale sia la sua sorte. È stata demolita? Bombardata?”, si domanda, come se dall’altra parte della cornetta, in Italia, avessimo la risposta. Hanin, invece, continua la sua giornata accanto al fuoco fino al tramonto. “Poi dormiamo qualche ora, svegliandoci spesso al suono dei bombardamenti e delle esplosioni, e il giorno dopo ricomincia uguale al precedente”. È tutto uguale a Gaza. Lo stesso ciclo di eventi. Un missile, un articolo scritto su di un morto o un sopravvissuto. La metafora la dice Tobasi: “È una corsa tra la parola e il missile, tra la verità e la morte, tra i bisogni della famiglia e la paura di perderla”. In realtà, però, “non è soltanto la tua vita a essere appesa tra morte e sopravvivenza: l’intera giornata è intrisa di morte — mentre vai al lavoro, mentre torni alla tenda, mentre sei in tenda o persino mentre dormi”.
La possibilità che un missile ti colpisca mentre fai il tuo lavoro è, appunto, una possibilità concreta e non più remota. La morte è una ossessione: è ovunque, in ogni istante. E a chi dice che sono tutte menzogne, che non si muore a Gaza o che è tutto sotto controllo, come raccontavano degli influencer portati dal governo di Netanyahu qualche giorno fa in visita nella Striscia, Tobasi risponde: “Se raccontare i massacri viene interpretato come ‘parziale’ – sottolinea – , questa accusa cade davanti alle immagini dei cadaveri e alle voci delle vittime”. Noi, conclude, “raccontiamo la realtà, a volte col nostro stesso sangue, e non siamo parte della narrazione, siamo testimoni”.
L'articolo Il racconto dei reporter di Gaza: “Ogni giorno alla prima esplosione prendiamo la telecamera. Israele non vuole che documentiamo la fame e i crimini contro i civili” proviene da Il Fatto Quotidiano.

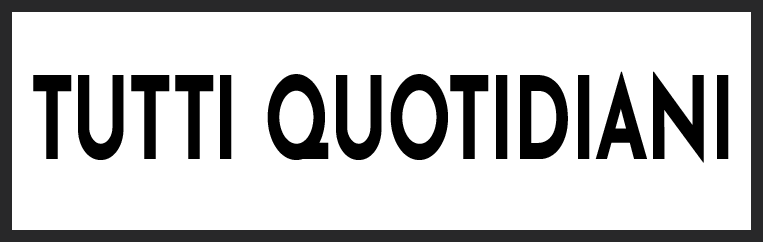
.png)

