Ilva, 13 anni fa il sequestro. Palombella (Uilm): “Ultima chance per salvarla. Politica miope e succube dei privati”
- Postato il 26 luglio 2025
- Lavoro
- Di Il Fatto Quotidiano
- 1 Visualizzazioni
.png)
“Questa è l’ultima chance, non ce ne saranno altre”. Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, nato a Faggiano, ventitré chilometri dalle ciminiere dell’Ilva di Taranto, entrò per la prima volta in quella fabbrica nel giorno del suo diciottesimo compleanno. Era il 5 dicembre 1973. L’allora Italsider stava crescendo: era in programma il “raddoppio”. Fuori dal gergo tecnico: nuovi altoforni, nuovi impianti di lavorazione. La fabbrica doveva produrre più ghisa e doveva poi trasformare l’acciaio in prodotti finiti: lamiere, tubi, bramme. Tutto il contrario di quanto sta avvenendo ora. Il governo sta tentando l’ultimo rilancio, l’estremo tentativo di salvare un impianto siderurgico che per anni è stato il più grande d’Europa. Tutto era iniziato il 26 luglio 2012, tredici anni fa. L’acciaieria della famiglia Riva veniva sequestrata dalla magistratura perché ritenuta causa di “malattie e morte”. Otto governi non sono riusciti a darle un futuro: dal “garante” di Mario Monti alla discussione in corso per una nuova vendita, dopo quella fallita ad ArcelorMittal, è trascorso oltre un decennio di occasioni sprecate, illusioni, inerzia e speranze tradite. Mentre la produzione si è ridotta da 8 a 2 milioni di tonnellate all’anno, sempre meno operai lavorano e i problemi ambientali restano nel limbo di bonifiche raffazzonate e di vecchi altoforni che resteranno in marcia per almeno altri otto anni.
Si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi in una situazione simile?
Non avrei mai potuto immaginarlo. Venni assunto perché si dovevano avviare l’altoforno 5 e l’altoforno 4, il treno nastri 2 e il tubificio 2. E, nonostante il raddoppio dell’impianto di Taranto, c’era così tanta fame di acciaio da mettere in piedi l’ipotesi di un quinto centro siderurgico. A Genova, Piombino, Bagnoli e Taranto si pensava di aggiungere Gioia Tauro. Oggi c’è un solo altoforno attivo, anche sgangherato, e si producono meno di 2 milioni di tonnellate di acciaio. Era impensabile.
Anche tredici anni fa, quando scattò il sequestro. Dove era?
Ero a Roma, già segretario generale della Uilm da due anni. Mi chiamarono i colleghi di Taranto: “Rocco, qui non si capisce nulla. È pieno di forze dell’ordine”. Fu dirompente, qualcosa di inedito nella sua drammaticità. Non sapevano neanche se sarebbe stata concessa la facoltà d’uso degli impianti. Andai a Taranto, insieme ai segretari generali di Fiom e Fim, dopo giorni di blocchi stradali da parte dei lavoratori.
Lei è tarantino e sindacalista: impossibile non vivere entrambi i problemi, tutela dell’ambiente e del lavoro.
Oggi, certamente. Dodici anni fa anche. Quando lavoravo, invece, ero incosciente. Non sapevamo quali sostanze venissero sprigionate e cosa potessero provocare alla salute delle persone. Si pensava solo alla possibilità che quella fabbrica dava, una condizione sociale diversa. Ho lavorato per anni nell’area ghisa, dove era normale convivere con le polveri. Non esisteva la coscienza del pericolo. Le racconto un aneddoto che, ahinoi, rende bene l’idea.




Prego.
Il minerale di ferro, quello famoso perché svolazzava dai parchi primari e finiva nel rione Tamburi, per noi era la routine. Avevamo un’indennità alla polvere ma non consisteva in un elemento economico: ci davano una busta di latte al giorno, come avveniva anche negli impianti petrolchimici. Una sorta di antidoto per purificare il corpo. La rappresentanza plastica dell’ignoranza che c’era.
Che l’Ilva inquinasse però non fu una sorpresa, il dibattito era già in corso.
Nessuno mette in dubbio che lo stabilimento abbia avuto un impatto su ambiente e salute, internamente e nel rione Tamburi: lo spolverio del minerale, il Pm10 e la diossina. Allo stesso tempo, non potevamo non considerare – ed era la nostra maggiore responsabilità – che c’erano 16-17mila migliaia di posti di lavoro in ballo, oltretutto con un ricambio generazionale appena avvenuto. Dentro c’erano tutti operai giovanissimi, gli anziani erano tutti andati in pensione tra il 1995 e il 2000.
Tredici anni dopo è tutto in bilico. Perché i piani di rilancio sono falliti?
Perché non si è mai toccato il cuore del problema: un massiccio intervento sugli impianti. Si è messo un tampone ai problemi ambientali, penso ai parchi minerari e ai filtri di agglomerato, ma non si è mai andati a fondo sul sistema di produzione. Gli impianti dell’Ilva hanno un grande valore se quella fabbrica produce oltre 6 milioni di tonnellate all’anno, sotto questa soglia l’azienda è perennemente in perdita. È come avere un bus da 50 posti che trasporta ogni giorno tre passeggeri: puoi cambiare l’autista o le gomme, ma il proprietario del bus non guadagnerà mai. Si sono spesi miliardi ma non sono stati sufficienti a rendere lo stabilimento a basso impatto ambientale e sostenibile per un privato. Oggi è ancora più complicato: Taranto ha quattro altoforni, l’Afo 5 è chiuso da dieci anni e quindi ne restano tre che sono però a fine “campagna” (necessitano cioè di profondi interventi, ndc).
Un cul-de-sac, quindi. Come se ne esce?
La frattura tra ambiente e lavoro esiste, è ben radicata e sotto gli occhi di tutti. Ma esiste una coscienza anche tra gli operai che vogliono ovviamente il lavoro ma lo pretendono pulito. Serve superare il ciclo integrale, cioè la produzione con gli altoforni. Dirlo cinque anni fa era una bestemmia, oggi è invece possibile anche se ci sono pochi precedenti. Per ogni altoforno che si ferma, bisognerà accendere un forno elettrico. Così toglieremo l’agglomerato, le cokerie, le due acciaierie, i parchi primari: sarà tutto finito. Ma bisognerà farlo con il preridotto, non come avviene nelle acciaierie del Nord con il rottame di ferro. L’Ilva non può passare dal ciclo integrale al rottame di ferro. Serve il preridotto e servono gli impianti per produrlo.
Queste tecnologie impiegano meno lavoratori. Accetterete gli esuberi?
No. Per questo chiediamo di non limitare il futuro dell’Ilva agli impianti a caldo, che assorbirebbero meno del 50% degli attuali 8.200 occupati nell’impianto pugliese e poco meno di 10mila in tutta Italia. Tutto l’acciaio sfornato a Taranto, i 6 milioni di tonnellate di cui si parla oggi, va “verticalizzato”, cioè trasformato in un prodotto finito. Cosa significa? Rimettere in marcia laminatoi e tubifici, impianti che già esistono in quella fabbrica. Con 6 milioni è possibile far lavorare quasi tutti, bisogna solo spostare le loro funzioni. Il territorio e i lavoratori hanno già pagato abbastanza, vanno risarciti.
I soldi chi li mette? I privati non vogliono pagare il “green” deciso dal pubblico.
Lo Stato deve entrare nella compagine societaria per la durata del rifacimento degli impianti. Se si va fino in fondo, i forni elettrici si pagheranno da soli perché l’acciaio di Taranto, con quella tecnologia, sarà il miglior acciaio in circolazione.
Qualcosa di simile è già stato sperimentato con Mittal e Invitalia. Non è andata bene.
Era un problema di forze in campo, non di strategia. ArcelorMittal controlla il mercato, produce 100 milioni di tonnellate all’anno, è il più forte al mondo e quindi detta le condizioni. Forse avrà scelto Taranto con l’intento di far produrre l’impianto, ma poi ha provato ad annientarlo. Non a caso il sindacato si è battuto per l’amministrazione straordinaria. Diversamente oggi gli altoforni sarebbero già chiusi. Il problema è che lo Stato entrò in Acciaierie d’Italia con il 30% ma da un punto di vista del controllo e della gestione era tutto in mano al privato. È necessario entrare con la maggioranza ed essere garanti della realizzazione degli investimenti, con scadenze ben definite. Non si può sbagliare un’altra volta, si rischia una strage lavorativa e un deserto industriale.
Questa è l’ultima chance?
Sì, è l’ultima.
Otto governi non ce l’hanno fatta, serve un miracolo.
La politica è diventata miope ed è succube dei privati, lo abbiamo visto a Taranto ma anche nel settore auto e nell’elettrodomestico. Nessuno si assume le responsabilità di indicare la strada e prendere provvedimenti risolutivi anche se dolorosi. Si preferisce spostare quel momento sempre al domani. Non c’è programmazione, non si fa politica industriale, si decide sulla base della permanenza del singolo. Si vivacchia e si rimandano le decisioni pesanti al successore. L’Ilva ha sempre ricevuto solo decreti decreti legge che tamponavano l’emergenza, mai una visione dettagliata e di lungo periodo.
E il sindacato? Ha mai sbagliato prima o dopo il sequestro?
Abbiamo sempre cercato di tenere insieme ambiente e lavoro.
Nell’inchiesta che portò al sequestro furono ricostruire alcune situazioni imbarazzanti.
Come chiunque, avremo anche sbagliato in alcune situazioni. Ma l’ho sempre detto e lo continuo a dire: la chiusura è il peggiore dei mali. Bagnoli è lì a dimostrarlo. E a Taranto esisterebbe il problema occupazionale oltre che quello ambientale. Resta ancora da bonificare la Yard ex Belleli, ci sono i problemi della Sanac e della Cementir. L’Ilva non diventerebbe un museo di archeologia industriale, ma una bomba ecologica. Il lavoro può cambiare, ma serve tempo. In questi anni è merito del sindacato se sono stati creati due insediamenti industriali importanti come Leonardo e Vestas che hanno generato 3.000 posti di lavoro. Sono disposto al mea culpa, se qualcuno mi fa notare degli errori. Ma non è vero che abbiamo sacrificato la salute per salvare i posti di lavoro. Ora esiste la possibilità di eliminare il ciclo continuo. Chiediamo solo tempo, un tempo definito: otto anni per spegnere l’ultimo altoforno. Sediamoci intorno a un tavolo e mettiamolo nero su bianco, imponendo nel frattempo paletti che garantiscano la tutela della salute.
L'articolo Ilva, 13 anni fa il sequestro. Palombella (Uilm): “Ultima chance per salvarla. Politica miope e succube dei privati” proviene da Il Fatto Quotidiano.

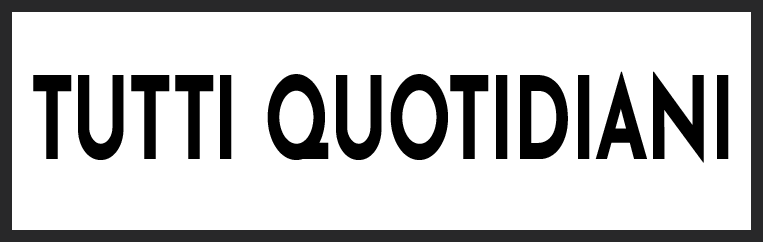




.png)
