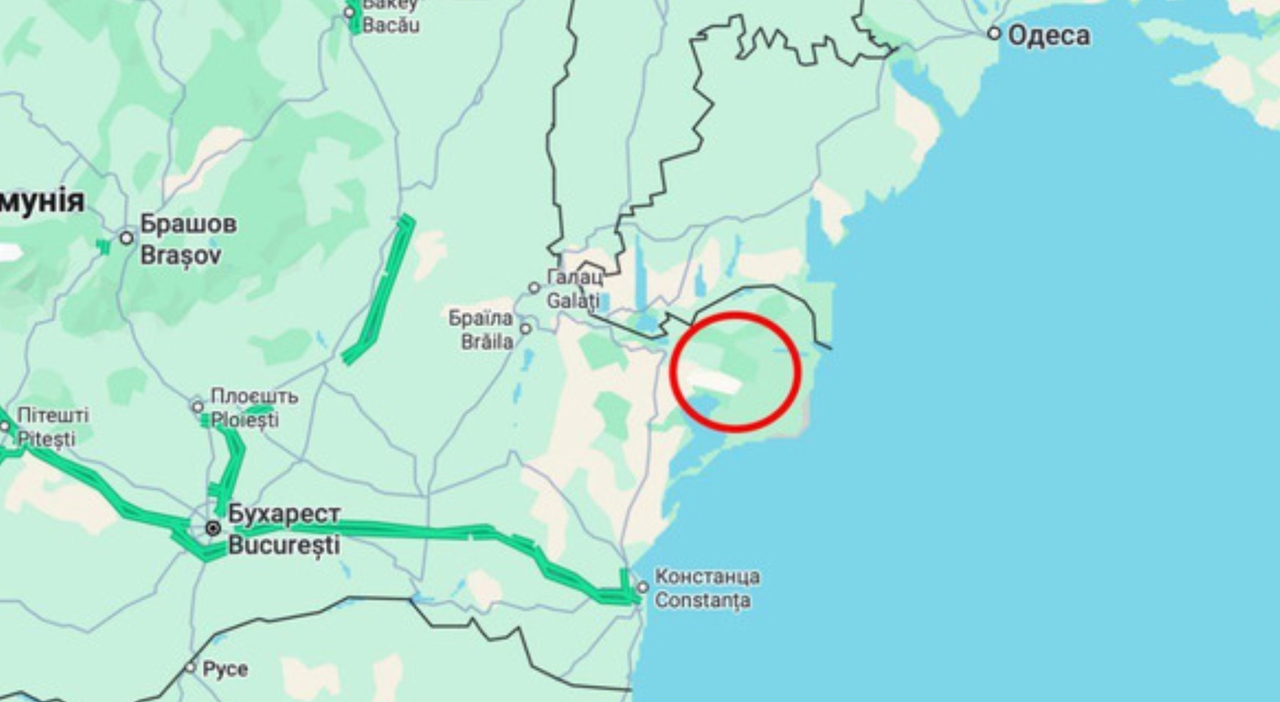Iran, la sete e la «mafia dell’acqua»
- Postato il 13 settembre 2025
- Di Panorama
- 1 Visualizzazioni


In Iran la siccità non è soltanto il frutto di un destino avverso. Alla cronica scarsità di piogge, al cambiamento climatico e alla geografia ostile di un Paese in gran parte arido, si aggiunge un elemento che pesa come un macigno: la corruzione. È questa miscela tossica ad aver trasformato la crisi idrica in un’emergenza strutturale che mina la stabilità sociale ed economica della Repubblica islamica. Negli ultimi anni, la definizione che circola tra analisti e attivisti è diventata familiare: «la mafia dell’acqua». Non si tratta di un’esagerazione giornalistica, ma di una realtà riconosciuta da studiosi e persino da alcuni ex funzionari iraniani. Dietro l’etichetta si cela un sistema di interessi che unisce burocrazia, imprenditori, appaltatori di grandi opere e potentati locali, con un ruolo centrale del Corpo delle Guardie della Rivoluzione (IRGC). Questi attori decidono quali dighe costruire, quali fiumi deviare, quali pozzi autorizzare e, soprattutto, chi deve rimanere all’asciutto. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Secondo i dati più recenti, oltre il 70% delle falde acquifere iraniane è stato sfruttato oltre i limiti di rigenerazione, provocando fenomeni drammatici come la subsidenza del terreno. A Teheran, in alcune zone, il suolo sprofonda di decine di centimetri ogni anno, mettendo a rischio infrastrutture e palazzi. Eppure i pozzi illegali – spesso controllati da élite locali – continuano a pompare acqua senza controllo, alimentando coltivazioni ad altissimo consumo idrico come il riso o i pistacchi, destinati al mercato internazionale.
Le grandi dighe, costruite a decine negli ultimi decenni, hanno accentuato il problema. Molti di questi progetti non rispondevano a reali esigenze idriche, ma erano il pretesto per alimentare un giro d’affari miliardario. La sedimentazione ne ha ridotto l’efficienza, mentre la deviazione dei fiumi ha prosciugato laghi e zone umide, tra cui il Lago Urmia, un tempo simbolo della biodiversità iraniana, oggi ridotto a un bacino salato quasi sterile. Dietro le scelte infrastrutturali non c’era un piano nazionale di sostenibilità, ma la logica del profitto e del clientelismo politico. Le province più povere pagano il prezzo più alto. Nel Khuzestan, ricco di petrolio ma povero d’acqua, la popolazione scende in piazza quasi ogni estate per protestare contro i rubinetti a secco. Nel Sistan-Baluchestan, una delle regioni più marginalizzate del Paese, i villaggi sopravvivono grazie alle autocisterne o ad acquedotti improvvisati. Intanto le aree industriali vicine al potere centrale ricevono forniture prioritarie, accentuando disuguaglianze e tensioni sociali.
Il governo di Teheran tende a minimizzare, parlando di «fenomeni naturali» o di «uso eccessivo da parte della popolazione». Ma i dati smentiscono la narrativa ufficiale: oltre il 90% dell’acqua iraniana viene assorbita dall’agricoltura, spesso inefficiente, mentre il sistema idrico urbano soffre perdite enormi a causa di tubature obsolete. L’assenza di trasparenza peggiora la situazione: i dati reali sulle riserve idriche vengono manipolati o nascosti, impedendo un dibattito pubblico basato su fatti concreti. Secondo Iran International, la crisi idrica è diventata anche un affare di sicurezza nazionale. Le autorità temono che la scarsità d’acqua possa trasformarsi in detonatore di nuove ondate di proteste, come già accaduto negli ultimi anni. Non a caso, il regime risponde con la repressione: alle manifestazioni per l’acqua si risponde con arresti e proiettili. In questo contesto, la corruzione agisce come un moltiplicatore: non solo priva i cittadini di un bene essenziale, ma erode anche la fiducia nella capacità dello Stato di garantire la sopravvivenza quotidiana.
A rendere più cupo il quadro è l’impatto del cambiamento climatico. Negli ultimi vent’anni le precipitazioni sono calate di oltre il 20%, mentre le temperature medie continuano a crescere. La combinazione di siccità naturale e mala gestione sta portando l’Iran verso una condizione di stress idrico permanente. Secondo le stime, diciannove province sono già oggi in stato di emergenza. A Teheran, le dighe che alimentano la metropoli hanno raggiunto livelli critici, con alcuni bacini al 13% della loro capacità. Di fronte a questo scenario, le soluzioni tecniche – dal riciclo delle acque reflue alla modernizzazione delle reti urbane – vengono invocate, ma raramente applicate. Il problema non è solo tecnologico: è politico. Finché la «mafia dell’acqua» continuerà a orientare le scelte, il ciclo perverso di sprechi, favoritismi e degrado ambientale resterà intatto. La crisi idrica in Iran non è dunque soltanto una sfida ecologica: è un test di sopravvivenza per la Repubblica islamica. Un Paese senza acqua non può garantire né agricoltura, né industria, né stabilità sociale. E se l’acqua diventa un privilegio gestito dalla corruzione, allora la sete rischia di trasformarsi in rabbia.Mentre milioni di cittadini fanno la fila per pochi litri d’acqua e intere province sopravvivono con razionamenti, i signori della «mafia dell’acqua» continuano a prosperare tra contratti gonfiati e pozzi illegali. Nelle loro ville di Teheran e nei resort lungo il Caspio, le piscine restano piene e le fontane zampillano. È la fotografia perfetta di un regime che predica sacrificio ma non rinuncia al privilegio: un potere che, di fronte alla sete del suo popolo, non arrossisce, perché da anni ha imparato a bere solo champagne. Ma prima o poi il popolo si muoverà e i mullah dovranno scappare di notte dall’Iran.