Iran, perché le rivolte questa volta possono portare a un cambiamento. Dalla questione generazionale alla debolezza del regime: i punti
- Postato il 15 gennaio 2026
- Mondo
- Di Il Fatto Quotidiano
- 1 Visualizzazioni
.png)
I moti di rivolta contro il regime iraniano in almeno 31 province e 187 città, con oltre 600 singoli focolai di protesta, non accennano ad attenuarsi. L’inasprimento della repressione da parte delle forze di sicurezza si riflette nel sempre più allarmante numero di vittime sinora registrate: secondo Human Rights Activists News Agency (HRANA), con base in Virginia, al 13 gennaio erano 2.403 le persone uccise, 12 delle quali sotto ai 18 anni, e 1.134 quelle rimaste gravemente ferite. Dall’altro lato della sempre più infuocata barricata, 147 membri delle Forze di sicurezza hanno perso la vita nel corso di scontri. A impressionare è anche il numero degli arrestati: 18.434, sempre secondo HRANA, tra i quali si registrano almeno 97 casi di confessioni forzate, trasmesse sulla tv nazionale.
Il paese è pronto alla svolta?
Il processo di scollamento tra il regime nato dopo la rivoluzione del 1979 e gran parte della popolazione sembra arrivato a un punto di non ritorno, estremamente difficile da ricomporre, anche al di là dei livelli di violenza registrati. L’intensità, la diffusione e anche l’eterogeneità delle istanze che sorreggono queste proteste sembrano fotografare la distanza venutasi a creare tra la società civile e il sistema istituzionale, oltre che il governo stesso. Ciò accade per giunta in una congiuntura di profonda crisi economica, di isolamento sempre più marcato e soprattutto di esplicite e montanti pressioni internazionali, attestate una volta di più dalla rinnovata promessa di intervento armato da parte di Donald Trump che era stata preceduta da esplicite quanto incaute dichiarazioni – da parte dell’ex segretario di Stato Mike Pompeo, ma anche dallo stesso Mossad su X – circa la rivendicata presenza di agenti israeliani a fianco dei rivoltosi.
I numeri e la durata di questa protesta, specie se messi in relazione a questo genere di comunicazione pubblica priva di filtri o di alcuna forma di contegno “tattico” da parte degli americani e degli israeliani, getta una luce sulla sua diversità rispetto alle precedenti tornate, oltre a far ipotizzare seriamente degli sviluppi più concreti, magari stimolati proprio dall’ormai atteso intervento americano. La più importante delle ultime proteste, esplosa in seguito alla morte di Mahsa Amini, aveva dato vita a un movimento di protesta civile guidato anzitutto dalle donne con lo slogan “Donna, vita, libertà” che, in modo graduale, aveva sostanzialmente stimolato l’alleggerimento de facto delle restrizioni sul dress code: da quei giorni in poi, nelle grandi città in particolare migliaia di donne avevano iniziato a non indossare più il velo obbligatorio, con le pattuglie della polizia morale non più in grado, o non più istruite a perseguire con eguale solerzia le “trasgressioni”.
La crisi economica, con l’ennesimo recente crollo del rial, ha però stimolato dal 28 dicembre le serrate e gli scioperi dei bazar, contribuendo a ravvivare a cascata tutte le altre istanze, soprattutto quelle sistemiche, che ormai sembrano prevalere su tutte le altre. La crisi economica, quindi, come acceleratore del diffuso malcontento, della stanchezza pervasiva di una società che dal punto di vista demografico “parla” chiaro: il 65% della popolazione è nata dopo la rivoluzione del 1979 ed è quindi in molti casi estranea ai suoi “miti fondativi” – la rivoluzione stessa, la guerra con l’Iraq, la morte di Khomeini nel 1989 – ma sempre più esasperata rispetto alle proprie condizioni materiali, alla postura internazionale del regime, all’assenza di prospettive.
Sembra tardi anche per la prospettiva di una eventuale “pacificatrice” successione di Khamenei, ormai 86enne: dopo la morte dell’ex presidente principalista Ebrahim Raisi – considerato il più papabile, ed abbastanza in linea con la sua postura – sembrava che i nomi rimasti in lizza potessero essere quelli di due figure diverse, più vicine a quella corrente riformista che aveva perso il suo slancio dopo l’arresto dei leader Mehdi Karroubi e Mir Hossein Mousavi nel 2011: il primo è l’ex presidente Hassan Rouhani, il secondo il 53enne Hassan Khomeini, nipote di Ruhollah, molto vicino proprio a Mousavi.
Il futuro appare quanto mai incerto, nonché fortemente influenzabile da eventi esogeni. È comprensibile l’ondata di entusiasmo, di senso di inevitabilità che si respira in questi giorni. Tuttavia in un paese di 92 milioni di persone, nate e cresciute in un sistema istituzionale tanto autoritario, repressivo, quanto complesso e stratificato, con basi di consenso in alcuni settori della popolazione, e considerando il fatto che al momento non si registrano defezioni tra le forze di sicurezza – uno degli aspetti più importanti nel 1978, con migliaia di coscritti che erano giovani ammiratori di Khomeini e defezionarono in massa, prima che lo Shah disponesse la neutralità dell’Esercito -, le cose potrebbero esser più complicate di quanto non sembrino.
Le tante anime dell’Iran e il rischio balcanizzazione
Come scrive l’analista Narges Bajoghli, una rivoluzione – più che entusiasmo – è anzitutto “organizzazione, istituzioni, un potere strutturato e coordinato in grado di sostituire l’esistente”. Nella storia moderna iraniana, continua, le principali istituzioni dotate di una qualche forma di potere sono sempre state la monarchia, il clero, l’Esercito, i bazaari, e la società stessa, specie a partire dalla rivoluzione costituzionale del 1906. Nel 1979, la monarchia è in sostanza caduta grazie all’allineamento tra tre di esse: la società (soprattutto gli studenti delle università, sia khomeinisti, che comunisti, che afferenti al Mek), il clero e i bazaari.
Oggi, spiega l’analista, la monarchia sta cercando di fare il suo ritorno attraverso la ampiamente sponsorizzata figura di Ciro Pahlavi, figlio dell’ultimo Shah, che però in Iran ha una base di sostegno sì esistente, ma certamente limitata dal punto di vista numerico, nonché confinata alla componente persiana (che, ricordiamo, arriva al 55% di una popolazione multietnica). Non è forse un caso che persino Trump, mentre si esprime sull’Iran con i toni di chi potrebbe deciderne le sorti, non abbia alla fine incontrato Ciro Pahlavi a Mar-a-Lago.
Il clero, da parte sua, gode ormai di un credito minimo presso una società che lo identifica come il simbolo del sistema stesso. Va però ricordato come anch’esso non sia un monolite. Al suo interno è più eterogeneo di quanto non si creda – basti pensare ai religiosi critici del sistema, tanto odierni quanto del passato, come l’ayatollah Muntazeri -, con la compresenza di diversi centri di potere in competizione tra loro, con visioni diverse del futuro ed evidenti fratture interne. Insomma, può essere in molti sensi sbagliata l’equazione tra clero e “regime”.
Come già accennato in precedenza, i recenti scioperi dei bazaari hanno ricordato a molti quelli del 1978 e hanno quindi stimolato in una parte degli iraniani l’idea che ciò potesse portare a un’altra rivoluzione. È però importante ricordare che i bazaari odierni non sono quelli di 50 anni fa: la loro indipendenza è stata continuamente minata dal regime in un’ottica centralista e non si tratta più della prorompente forza autonoma degli Anni 70.
Bajoghli conclude poi con un punto fondamentale: in questi anni sia il regime che i suoi nemici – interni ed esterni – si sono spesi molto per impedire che le varie sacche di malcontento si coalizzassero tra loro. Sorveglianza, repressione, infiltrazione (da parte del regime ma anche di agenti stranieri, come notato nell’ultima guerra dei 12 giorni), “agenti di discordia” che avevano il solo obiettivo di precludere la costruzione di una alternativa, dell’embrione di una formazione che potesse promettere di durare nel tempo, rappresentando la popolazione. Questo ha fatto sì che negli ultimi 15 anni si sia assistito a isolate e disorganizzate esplosioni di rabbia, anziché a movimenti coordinati.
L'articolo Iran, perché le rivolte questa volta possono portare a un cambiamento. Dalla questione generazionale alla debolezza del regime: i punti proviene da Il Fatto Quotidiano.

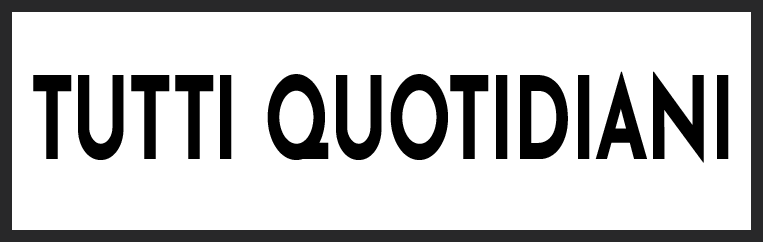
.png)
