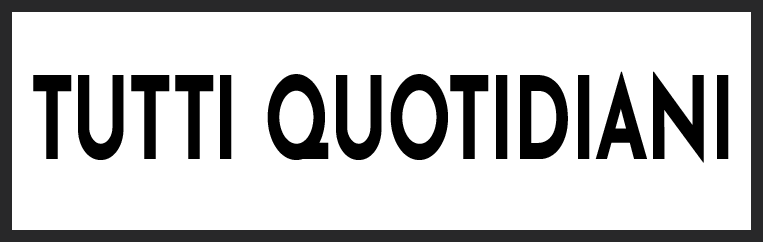KINO 2.0. Il giorno in cui il k-pop idol è diventato uomo
- Postato il 27 ottobre 2025
- Di Panorama
- 2 Visualizzazioni


C’è qualcosa di magnetico in KINO: un’energia che non urla, ma travolge. È quella dei veri artisti, quelli che non cercano di piacere — si limitano a essere. Per anni è stato il volto dell’idol perfetto, elegante, preciso, quasi irreale. Poi ha fatto quello che pochi in Corea hanno il coraggio di fare: si è guardato dentro, ha accettato la parte fragile, quella che fa rumore, e ne ha fatto musica.
KINO oggi è un uomo nuovo, ma non perché abbia cambiato pelle — semplicemente, ha smesso di nascondersi. “KINO 2.0” non è un rebranding, è una confessione. È il risultato di un percorso personale e artistico in cui vulnerabilità e rabbia, desiderio e paura si intrecciano fino a diventare verità. Non più l’idol patinato, ma un essere umano che si sporca le mani con la propria realtà, che non si vergogna del disordine emotivo, anzi lo rivendica.
In Everybody’s Guilty, But No One’s to Blame c’è questo: la resa dei conti con se stesso. L’ammissione che la perfezione non esiste e che anche chi brilla sul palco può sentirsi perso dietro le luci. KINO non chiede comprensione, chiede attenzione — quella vera, quella che non si limita ad applaudire ma ad ascoltare.
E la sua voce, nel nuovo progetto, suona diversa. Più profonda, più inquieta, più viva. È il suono di chi ha smesso di trattenersi. Perché Club Sex Cigarettes non è solo una provocazione: è una liberazione. È l’urlo elegante di chi ha deciso che non è più disposto a compiacere un sistema che pretende disciplina dove servirebbe istinto. È il manifesto di un artista che non ha paura di dire le cose come stanno, anche quando sanno di scandalo.
Oggi, KINO non si limita a cantare: interpreta il conflitto interiore di una generazione che ha imparato a sorridere mentre brucia. E lo fa con una naturalezza disarmante, trasformando ogni contraddizione in arte, ogni ferita in linguaggio.
È un artista che si spinge oltre il confine del K-pop per entrare in un territorio più adulto, più ruvido, più vero.
KINO 2.0 è la prova che la vulnerabilità non è debolezza, ma potenza pura. Che la sincerità, quando è radicale, spaventa più di qualsiasi provocazione. E che, forse, l’unico modo per restare vivi in un mondo di maschere è avere il coraggio di togliersela.
Eppure, nonostante la lucidità con cui parla del proprio dolore, KINO non ha perso la leggerezza. La porta addosso come un profumo, insieme a quella calma disarmante di chi ha già attraversato il fuoco e ne è uscito intero, anche se annerito.
Incontrarlo oggi significa entrare in un universo dove ogni gesto è consapevole, ogni parola è un atto politico, ogni silenzio è pieno. Il suo sguardo è fermo, limpido, ma dietro si intuisce la tempesta che lo ha portato fin qui.
Ed è da lì che partiamo. Dalla verità, dalle ferite, da quel bisogno umano — prima ancora che artistico — di essere finalmente sé stessi.
Panorama ha parlato in esclusiva con lui.
Chi è KINO oggi? Non l’idol, non il performer. Ma l’uomo dietro ogni notte insonne, ogni dubbio, ogni frammento di verità che una volta avevi paura di dire ad alta voce — chi è lui, oggi?
Credo di star finalmente imparando a vivere sia come Kang Hyeonggu che come KINO, senza sentirmi in colpa da nessuna parte. Per anni ho lavorato come una macchina: svegliarmi, andare alle prove, scrivere canzoni, esibirmi e ricominciare. Pensavo che tutto ciò che non rientrava in quella routine fosse sbagliato. Ma dopo innumerevoli notti insonni e qualche crollo emotivo, ho capito che essere umani significa che non ci sono risposte corrette. Ancora oggi penso troppo e inseguo troppi obiettivi, ma ho smesso di fingere che vada sempre tutto bene. Avere anche solo un po’ di onestà mi fa già sentire cresciuto.
Hai trascorso quindici anni cercando di adattarti a uno stampo di perfezione. Cosa succede quando quello stampo finalmente si incrina?
All’inizio è stato caotico. Quando lo stampo si è rotto, non sapevo chi fossi senza le pressioni a spingermi. Ricordo una mattina dello scorso inverno: fissavo il portatile da ore, senza ispirazione né motivazione, e ho capito di aver costruito una vita in cui esistevo solo quando ero “produttivo”. È stato un colpo durissimo. Da allora, ho cercato di ricostruire quello stampo rendendolo flessibile, qualcosa che mi permettesse di sbagliare e fermarmi ogni tanto.
Questo nuovo album è brutalmente onesto — niente filtri, niente luccichii. C’è stato un momento in cui hai deciso: “Basta fingere”?
Sì. È successo durante il mio ultimo tour. Ho cantato “Back In Time”, una canzone tecnicamente imperfetta, e mi si è persino incrinata la voce. Ma il pubblico si è connesso con me in un modo che non avevo mai visto. Ricordo di aver pensato: “Ecco come suona l’onestà”. Quella sera qualcosa è cambiato. Ho capito che le persone non si innamorano della perfezione, ma della sincerità. Da quel giorno ho smesso di esibirmi con emozioni che non provavo davvero.
Quando hai iniziato a scrivere questo disco, quale emozione stavi inseguendo — rabbia, libertà o chiarezza?
È iniziato con la frustrazione. Per mesi mi sono sentito bloccato, creativamente e personalmente. Ricordo di aver registrato dei demo nel mio studio e di aver urlato nel microfono, senza neanche cantare. Era rabbia mescolata a stanchezza. Ma dopo settimane così, ho capito che la rabbia non era diretta agli altri, ma a me stesso, per aver avuto paura di cambiare. Così ho continuato a scrivere finché quella frustrazione non si è trasformata lentamente in qualcosa di più chiaro, forse persino in pace. Così è nato questo album.
Parli di ansia, avidità, depressione, rabbia — emozioni che spesso agli idol viene detto di nascondere. Cosa ti ha dato il coraggio di trasformarle in musica invece che in segreti?
Onestamente, la stanchezza. Ero esausto dal sorridere quando non stavo bene. Una notte, ero sdraiato sul pavimento dello studio dopo aver finito un brano, e ho pensato: “Se continuo a fingere, perderò la parte di me che sente davvero”. Mi ha spaventato più di qualsiasi critica. Così ho deciso di mettere tutto nella mia musica, anche le parti brutte. Se qualcuno l’ascolta e si sente meno solo, è già una ragione sufficiente per me.
Com’è nato il suono di questo album? È più cupo, più pesante — ma anche stranamente curativo. Volevi che la musica suonasse come il tuo caos?
Non avevo pianificato che suonasse cupo. È venuto fuori così. Quando ho iniziato a scrivere, le mie sessioni in studio erano quasi sempre di notte, verso le due o tre del mattino. Quando tutto sembra più pesante. Stavo seduto lì, con le luci spente, a ripetere lo stesso kick loop finché non diventava ipnotico. È stato allora che ho capito che la ripetizione di un ritmo techno rumoroso può essere curativa. Ero frustrato, ma quel beat mi dava una strana forma di conforto, come se il caos avesse finalmente una struttura.
“Everybody’s Guilty, But No One’s to Blame” suona come una confessione, ma anche come un perdono. Chi stai perdonando — te stesso, il sistema o il mondo?
Forse tutti. Ho passato anni a incolpare l’industria, la mia situazione, persino me stesso per non essere abbastanza. Ma un giorno mi sono sorpreso a pensare: “Sono stanco di odiare”. E lì è scattato qualcosa. Stiamo tutti solo facendo del nostro meglio, ognuno a modo suo. Credo che per me il perdono significhi lasciar andare il bisogno di trovare sempre un colpevole. Questo album non serve a dimostrare chi ha ragione o torto, ma ad accettare che siamo tutti colpevoli a modo nostro — e comunque decidiamo di andare avanti.
È stato spaventoso incontrare la versione di te stesso che avevi evitato?
Ero terrorizzato. Ho aperto per caso un vecchio video di una mia performance. Ero così diverso. Sorridente senza sosta, perfettamente controllato. Era bello. Ero davvero “sincero” nelle mie azioni di allora, ma in un certo senso mi sono chiesto: “L’ho scelto perché avevo paura di mostrare la verità?”.
E allo stesso tempo mi ha fatto sentire di nuovo vivo. Ho capito che non puoi davvero crescere se continui a modificare la tua verità.
Hai sempre avuto una sensibilità pop raffinata. Ti sei allontanato consapevolmente dal ‘suono da idol’ questa volta, o è successo naturalmente mentre evolvevi?
È successo naturalmente. Non mi sono mai seduto pensando: “Voglio suonare diverso”. È nato semplicemente dallo scrivere da solo, senza pensare a cosa avrebbe funzionato sul palco o a cosa si aspettassero i fan. Ho registrato tutto l’album in un piccolo studio disordinato, con una pessima illuminazione. Credo che quell’ambiente abbia tolto via la versione levigata di me su cui contavo troppo. Non si trattava di rinnegare le mie radici da idol, ma di scoprire come suono quando nessuno mi guarda.
Hai detto che essere vulnerabili richiede coraggio. Pensi che l’industria K-pop permetta questo tipo di vulnerabilità — o è qualcosa per cui hai dovuto lottare?
È sicuramente qualcosa per cui devi lottare. Quando ho iniziato a mostrare emozioni negative, anche solo a dire che mi sentivo perso, la gente intorno a me diceva: “Non dovresti dirlo pubblicamente”. Ma credo che il pubblico sia cambiato più in fretta del sistema. I fan oggi capiscono l’onestà. Non vogliono più la perfezione. Quindi sì, il sistema deve ancora adattarsi, ma ho capito che se non inizio io a essere reale, nessuno mi darà il permesso di esserlo. Ho dovuto conquistarmi quello spazio da solo.
Ora che gestisci la tua etichetta, sei sia artista che CEO. La libertà porta con sé un nuovo tipo di pressione?
Assolutamente. Pensavo che libertà significasse fare ciò che volevo. Ma quando sei tu a pagare la bolletta dell’elettricità, “ciò che voglio” improvvisamente diventa costoso, haha. Oggi finisco di registrare alle quattro del mattino e poi mi sveglio per rivedere i contratti. A volte mando e-mail di lavoro mentre ho ancora il trucco di scena. È estenuante, ma mi rende anche più responsabile. La libertà non è gratis. È solo una forma diversa di responsabilità. Ma sceglierei questa vita altre cento volte.
Pensi che questo album rappresenti la tua vera identità sonora? Se qualcuno non avesse mai sentito parlare di KINO prima, è questo il suono che ti definisce?
Sì, credo che questo album sia il più vicino che io sia mai stato a “me”. Prima, la mia musica doveva sempre passare attraverso filtri: opinioni della compagnia, concetti, paura di come la gente avrebbe reagito. Ma questa volta ogni decisione sonora è nata dall’istinto. Persino le imperfezioni sono rimaste. Se qualcuno ascolta questo album, voglio che senta come suona la mia stanza di notte. La tensione, l’ansia, le lacrime e quei brevi momenti di pace nel mezzo.
Passi dalle riunioni con gli investitori alla scrittura di canzoni alle tre del mattino — c’è un momento in cui KINO l’uomo d’affari e KINO il sognatore collidono?
Sempre. A volte passo il pomeriggio a parlare di numeri, budget, previsioni, e subito dopo corro in studio dove tutto riguarda le emozioni. È come cambiare cervello. Un momento calcolo i costi di marketing, il successivo scrivo canzoni con il cuore. Una volta cercavo di separare quei due lati, ma ora ho accettato che coesistono. Il cervello d’affari protegge l’artista, e l’artista mantiene umano l’uomo d’affari. Credo che abbiano bisogno l’uno dell’altro per sopravvivere.
In questo disco c’è un’onestà grezza — parli di fama, desiderio, stanchezza, persino rabbia. C’erano versi che hai quasi cancellato perché troppo reali?
Sì. In “CLUB SEX CIGARETTES” c’è una frase in cui dico “비위 맞추다 남은 건 약 봉투 and pains”, letteralmente: “Tutto ciò che mi è rimasto dopo aver assecondato gli altri sono confezioni di medicine e dolori”. Ho esitato a lungo, perché descriveva esattamente come mi sentivo allora: mentalmente e fisicamente esausto. Avevo paura che i fan si preoccupassero troppo o che sembrassi eccessivo, e ho pensato di toglierla. Ma quella era la verità della mia vita in quel momento. Ho capito che là fuori qualcuno probabilmente si sentiva allo stesso modo. Quindi l’ho lasciata.
Quale brano dell’album senti più tuo in questo momento — quello che suoneresti se le parole non bastassero?
“WURK”. È nata nel mio momento più basso. Ero costantemente arrabbiato, stanco e mi chiedevo perché stessi ancora facendo tutto questo. Ma ogni mattina mi svegliavo, aprivo il laptop e ricominciavo a lavorare, come una macchina che rifiuta di morire. È la versione più onesta di me: qualcuno che è stanco, ma va avanti. Ancora oggi, quando sento quel beat, mi ricorda che sopravvivere, a volte, è già una forma di vittoria.
Come artista sempre percepito come “il bravo ragazzo”, cosa significa ribellione per te oggi?
Per me, la ribellione non è infrangere le regole solo per scioccare la gente. È scegliere l’onestà quando sarebbe più facile restare in silenzio. Da giovane pensavo che ribellarsi significasse colori sgargianti o testi provocatori. Ora è qualcosa di più silenzioso. È scegliere di parlare della mia rabbia, della mia stanchezza o dei miei difetti anche quando la gente si aspetta che sorrida. A volte, dire “non sto bene” in un’intervista è già un atto di ribellione in questa industria.
Hai detto che questo album è il tuo primo passo verso la libertà. Cosa significa davvero per te la libertà — silenzio, caos o accettazione?
Penso che per me la libertà sia accettare sia la luce che l’ombra. Prima credevo che essere liberi volesse dire fare ciò che si vuole, ma ora è non nascondere nessuna parte di sé, nemmeno quelle brutte. La libertà è poter dire “non sono perfetto” senza dovermi scusare. A volte significa caos, altre volte silenzio. Ma soprattutto significa pace con me stesso. Ed è qualcosa di nuovo per me.
Guardando indietro agli anni con i PENTAGON, li vedi come un capitolo chiuso o come le fondamenta di tutto ciò che stai facendo ora?
Decisamente le fondamenta. Tutto ciò che so sul lavoro di squadra, sulla performance e sulla connessione con i fan nasce da lì. Quegli anni mi hanno insegnato quanto possano essere potenti i sogni condivisi. Certo, ci sono stati momenti difficili, pressioni, incomprensioni. Ma non rimpiango nulla. PENTAGON mi ha dato empatia. Credo che quell’equilibrio sia ciò che mi permette di sopravvivere oggi come artista solista e come CEO.
Hai vissuto alti e bassi — scandali, successi mancati per un soffio, tour mondiali, il Covid. Cosa ti hanno insegnato quegli anni sulla resilienza?
Che la resilienza non è non rompersi mai. È sapere come ricostruirsi. Durante il Covid tutto si è fermato: tour cancellati, progetti rimandati, e io di nuovo nella mia stanza a chiedermi quale fosse il mio scopo. Credo di aver imparato allora il valore della quiete. Non si può sempre spingere in avanti. A volte la cosa più coraggiosa è fermarsi, respirare, e poi rialzarsi. Questa, per me, è la resilienza.
L’idea che “nessuno di noi è perfetto” attraversa tutto l’album. Pensi che la perfezione sia mai stata il nemico?
Sì. Sono stato sia la vittima che il carnefice di quella mentalità. Incolpavo il sistema per aspettarsi la perfezione, ma ho capito che anche io la pretendevo da me stesso. Avevo paura di mostrare le mie crepe, anche quando dentro stavo crollando. È ironico: la cosa che mi ha reso di successo è anche quella che mi ha reso infelice. Ora sto cercando di fare pace con l’imperfezione. Forse è questo che oggi per me significa successo.
Hai descritto questo disco come una terapia. Cosa hai scoperto di te stesso durante il processo che ti ha sorpreso di più?
Ho scoperto di essere molto più arrabbiato di quanto pensassi. Ma anche molto più dolce. Reprimevo tutto: rabbia, gelosia, persino la gioia, perché credevo che le emozioni forti mi rendessero poco professionale. Ma scrivendo questo album, ho capito che le emozioni sono energia, non debolezza. A volte quasi piangevo mentre registravo, e invece di fermarmi, continuavo. È allora che ho capito che l’onestà può suonare più forte della tecnica.
In uno dei tuoi concept rendi omaggio a Nam June Paik — tagliando legami, letteralmente e metaforicamente. Quali legami hai dovuto tagliare per diventare chi sei oggi?
Ho dovuto tagliare l’idea di dover essere perfetto per essere amato. Era il legame più profondo. Per anni ho creduto che la gente mi amasse perché mi comportavo bene, perché sorridevo al momento giusto. Ma quel tipo di amore sparisce al primo errore. Ora sto cercando di costruire un tipo diverso di legame, uno che permetta l’imperfezione. Proprio come Paik che tagliava una cravatta sul palco, volevo mostrare che la libertà a volte comincia con la distruzione.
Hai detto di essere affamato di fama, ma anche stanco di fingere. Come bilanci ambizione e pace?
Non ho ancora trovato l’equilibrio perfetto. Forse non lo troverò mai. Sono ambizioso. Voglio essere visto e ricordato. Ma so anche che inseguire la convalida all’infinito ti svuota. Oggi cerco di separare “il lavoro che deve avere successo” dalla “persona che merita di riposare”. Dopo una giornata stressante, lavo i piatti o metto in ordine la stanza: è allora che mi sento di nuovo con i piedi per terra. Credo che la pace venga dalle cose semplici, non dagli applausi.
Se potessi parlare al te stesso ventenne — quel ragazzo che inseguiva il sogno — cosa gli diresti?
Gli direi: “Non devi sorridere sempre”. All’epoca pensavo che il successo dipendesse dal piacere agli altri. Gli direi che va bene essere confuso, arrabbiato o spaventato. Quelle emozioni non ti rendono debole. Ti rendono reale. E gli ricorderei che il fallimento non è l’opposto del successo, ma il prezzo dell’onestà. Credo che riderebbe di me, ma forse si sentirebbe anche sollevato.
E adesso, prenditi cinque secondi. Contali nella testa — uno, due, tre, quattro, cinque. Dimmi solo una parola, una soltanto, che definisce chi è KINO oggi.
“Diventare.”
Perché sto ancora imparando, cadendo e ricostruendomi. Non ho finito. E spero di continuare a evolvermi.