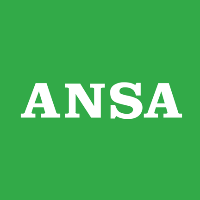La carica dei medici influencer: camici bianchi nell’era dei social media
- Postato il 30 agosto 2025
- Di Panorama
- 4 Visualizzazioni


C’è chi la medicina la fa in ospedale. E chi vuole anche raccontarla, spiegando casi clinici su TikTok o facendo tutorial con il camice bianco su Instagram. In mezzo si trova una linea sottilissima che separa la divulgazione scientifica dalla spettacolarizzazione. O peggio: dalla violazione della deontologia professionale e del rapporto di fiducia con i pazienti. È un crinale pericolosissimo, quello che oggi molti medici si trovano a percorrere, spesso senza gli strumenti giusti e soprattutto senza le capacità per riuscire a districarsi nel complesso mondo della nuova comunicazione.
L’affaire dei medici sui social esplode all’improvviso, come spesso accade nel nostro Paese, in una giornata di inizio luglio: quando Solange Fugger (famosissima su TikTok come “Minerva salute”, più di 400 mila follower, milioni di like e un viso che buca lo schermo mentre spiega i tanti casi clinici che si trova a fronteggiare in reparto) diventa a 36 anni il più giovane primario d’Italia, prendendo la guida del Pronto soccorso dell’Aurelia Hospital di Roma: struttura privata, ma convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. È un attimo e l’universo dei camici bianchi si divide: per alcuni è un modello virtuoso di comunicazione, per altri una mina vagante. Piovono accuse: da quella di aver fatto carriera solo grazie ai social (i primari dei Ps privati non devono vincere un concorso come quelli che lavorano nel pubblico) a quella di sottrarre tempo al reparto, fino ad accuse di violazione della privacy dei pazienti e grandi dibattiti sull’opportunità o meno che i medici raccontino i propri casi su TikTok.
La stessa Fugger, in numerose interviste, mostra di percepire un vago sentore di «rischio» in ciò che fa, e sostiene di non rivelare volentieri dove lavora per paura che poi «i follower vengano a cercarmi in reparto».
È il vaso di Pandora: a preoccupare i colleghi, più della popolarità non solo di “Minerva salute” ma in generale dei tanti medici-influencer, è altro, cioè la proliferazione sulle piattaforme social di contenuti, anche molto delicati, che rischiano di fare più male che bene. «Siamo consapevoli dell’importanza di saper comunicare efficacemente il nostro mondo», spiega a Panorama Fabio De Iaco, past-president di Simeu (Società italiana di emergenza urgenza). «Ma quello è che inquieta è la semplificazione dei messaggi. Soprattutto quando si raccontano casi clinici gravi con lo stile delle piattaforme virali. Non mi riferisco strettamente al caso Fugger, sto analizzando il fenomeno di tutta una serie di divulgatori della salute e della vita ospedaliera: se mostri un arresto cardiaco come se fosse una scena da serie tv stai giocando con l’immaginario collettivo. E rischi di fare danni, anche se sei animato dalle migliori intenzioni. La medicina non è uno spettacolo: è un atto tecnico e umano, che richiede senso della misura».
Il confine non quindi è tra chi comunica e chi no, ma tra chi semplifica per cercare di parlare a tutti, e chi banalizza o, peggio ancora, cede alla spettacolarizzazione, alla ricerca della commozione e all’autocompiacimento. «Il linguaggio popolare può certamente avvicinare l’universo medico agli utenti dei nostri ospedali», dice De Iaco. «Ma deve restare fedele alla complessità. Quando si insegue l’algoritmo, si finisce per tagliare le sfumature e trasformare il dolore in contenuto. Non possiamo permettercelo: ben vengano gli influencer della salute, ma che facciano le cose per bene e che non diano messaggi sbagliati alla popolazione. Perché questo diventa pericoloso, e poi a dover fronteggiare le aggressioni di chi pensa che in Pronto soccorso sia tutto semplice come sembra in video, ci siamo noi, in carne e ossa. Noi cerchiamo di strappare le persone alla morte: ma purtroppo non c’è sempre il lieto fine come su TikTok».
A scoperchiare il vaso di Pandora ci si è messo pure l’Ordine dei medici di Milano, che ha ritenuto d’intervenire non tanto sui medici-influencer ma addirittura sull’uso personale dei canali social, raccomandando ai propri iscritti di non «concedere l’amicizia» ai propri pazienti. Visione un po’ troppo retrograda? «Non credo proprio: il problema è che accettare un paziente tra gli amici su Facebook può creare aspettative sbagliate», spiega il presidente dell’Ordine milanese, Roberto Carlo Rossi. «Il paziente può pensare che il medico sia davvero un amico, sempre disponibile, a ogni messaggio, a ogni ora. Non è così: il medico deve rimanere un tecnico, a garanzia di tutti. Perché l’empatia è uno strumento clinico, non una confidenza personale: il medico entra per un tempo limitato nel mondo del paziente, cerca di comprenderne le sofferenze per calibrare al meglio diagnosi e terapie. Ma deve poi “chiudere l’applicazione”, per usare una metafora informatica, tornare a concentrarsi su un altro paziente, un altro problema. L’errore nasce quando questa empatia viene proiettata nello spazio social, dove qualsiasi cosa è permanente, visibile e fuori contesto».
Sembrerebbe tutto legittimo e sensato, se non fosse che non si può fermare il vento (dei social) con le mani: occorre imparare a governarlo. Posto che la Federazione nazionale degli ordini dei medici (FNOMCeO) ha già da tempo diffuso un vademecum su cosa fare o non fare sui nuovi media (spoiler: raccomandano di creare profili separati, uno personale e uno professionale) quindi, come procedere? «Servono preparazione e giudizio: in generale, per chiunque stia sui social media, figuriamoci per i medici», sostiene Massimiliano Panarari, professore di Sociologia della comunicazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia. «Premesso che stare sui social dovrebbe essere l’ultima delle preoccupazioni per chi lavora in corsia, non nego che la buona divulgazione – fatta proprio laddove si intercetta la grande maggioranza della popolazione – possa avere una funzione potenzialmente utile. Se il primario dell’epoca analogica era una figura distante, quasi ieratica, oggi un uso intelligente delle piattaforme può umanizzare la relazione medico-paziente. Il rischio più grande, però, è la confusione dei ruoli: i social tendono a schiacciare tutto su un piano orizzontale, dove “uno vale uno”. Ma tra medico e paziente c’è un rapporto asimmetrico, ed è giusto che resti tale. Non per gerarchia, ma per tutela reciproca».
I nuovi tempi dei medici-influencer sembrerebbero quindi un grande esempio di «tutto sbagliato, tutto da rifare», ma nella realtà dei social (al di là dell’ossimoro scontato) la storia non è proprio così semplice. Non sarà che in questi complicati anni post-Covid, segnati dall’irreperibilità di tanti medici di base e dal proliferare di pericolose fake news, i volti amici dei dottori che «spiegano cose» sul nostro smartphone potrebbe davvero fare la differenza e aiutarci a ricostruire un minimo di patto di fiducia tra medici e pazienti?
Un esempio virtuoso è rappresentato da alcuni pediatri, che hanno deciso di combattere nell’agone dei social media per aiutare mamme e papà alle prese con i problemi dei pargoli. Dall’account “iPediatri” su TikTok alla pagina di Giorgio Cuffaro su Facebook, questi divulgatori fanno squadra contro fenomeni pericolosi come l’automedicazione, l’anti-vaccinismo o l’uso eccessivo degli antibiotici e attirano centinaia di migliaia di follower, che partecipano e commentano. Quasi sempre con correttezza. «Serve tanto tempo e tanta pazienza, ma i risultati arrivano. Entrare nei luoghi dove nascono le fake news può essere una strategia efficace», sottolinea Cuffaro. «E per questo, con altri colleghi, stiamo costruendo reti informali, condividendo contenuti, creando coesione. Quando un altro pediatra condivide un mio post, alla fine il suo pubblico si fida anche di me. Si crea così una catena positiva».
Una rete silenziosa ma solida. Che non punta ai numeri, ma alla qualità dell’informazione. «Il pubblico», conclude De Iaco, «oggi ascolta più i social che i medici. E se vogliamo che torni a fidarsi di noi, forse dobbiamo tutti imparare a parlare anche la sua lingua. Ma senza mai tradire la nostra». E se il paziente poi diventa anche amico, beh, potrebbe anche non essere solo un male: dopotutto, oltre il camice bianco, al di là dello schermo, c’è sempre una persona.