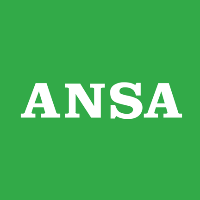L’ossimoro Milano, spiegato da De Bortoli
- Postato il 11 novembre 2025
- Di Il Foglio
- 7 Visualizzazioni

L’ossimoro Milano, spiegato da De Bortoli
Era “un gran Milan” ma è diventata un ossimoro, anzi un “ossimoro irrazionale” fin dal titolo “Milano io ti amo, ma non mi piaci più” che Ferruccio de Bortoli ha scelto per un suo lungo intervento sul magazine 7 del Corriere dedicato allo strano momento, psicologico ma non soltanto, che la città e i milanesi stanno vivendo. Non da ieri. Ma il sentimento di De Bortoli, ammette, “è irrazionale, è un ossimoro: io sono il principale difensore della milanesità ma nello stesso tempo sento che qualcosa non mi appartiene più e da cronista scopro ogni giorno che non appartiene più a molti milanesi. E questo è più grave della crisi edilizia, delle stesse inchieste”. Vale la pena approfondirli, questi ragionamenti di una persona che Milano la conosce come pochi altri.
Lei ha parlato di un disagio, di “un aspetto psicologico e sentimentale” che rende difficile oggi sentirsi parte di una città come Milano. E’ più facile sentirsene esclusi, e non soltanto nel senso della metropoli dei ricchi che “espelle” i poveri. Il tema è più profondo. Quale? “Innanzitutto, tengo a precisare, è un tema metapolitico, non riguarda né la situazione di una giunta – che tra le altre cose ha lavorato secondo me bene nella classica continuità tra amministrazioni che è sempre stata una ricchezza di Milano e che neanche questa inchiesta mi pare metta in dubbio – E’ qualcosa di più grave”. A proposito, lei ha scritto che la vicenda giudiziaria “per ora mi sembra fondata su un pregiudizio morale e non su fatti concreti” ma è allo stesso tempo acceleratore di un “malessere”. “Non è la consistenza delle inchieste ad avermi colpito, quanto la loro percezione. Basti questo: dopo il mio articolo ho ricevuto una quantità inusuale di commenti, molto al di là del solito. E tutti esprimevano sentimenti di questo tipo: di orgoglio, di appartenenza alla città; ma nello stesso tempo di delusione, di estraneità per una città in cui ci si riconosce meno”. Però lei mette in fila dei dubbi a proposito dei luoghi comuni, mediatici o politici, che stanno contribuendo all’immagine negativa. C’è un disamore che cova oltre i fatti. Come è accaduto? “C’è un tema di fondo da sottolineare, che la città contemporanea – l’unica città nella quale investono grandi capitali dall’estero e questo è un fatto indubbiamente positivo – è rimasta vittima di questo grande successo, indubbiamente, da Expo in poi. Non ci siamo accorti che il potere privato tendeva a esondare su quel potere di buona amministrazione di cui parlavo prima; sono arrivati investimenti che però prescindono totalmente dalla ‘milanesità’ del lavoro; allora lì scatta la trappola del successo che crea squilibri, come è accaduto a Londra o a New York. Sono arrivati, anche grazie a una legge fiscale che considero sbagliata, grandi investimenti internazionali e anche nuovi residenti – e per carità Milano è l’unica città internazionale e veramente europea d’Italia, dobbiamo dirlo – che però hanno avuto l’effetto di marginalizzare o espellere dal centro un ceto che si sente impoverito, molto più della sola espulsione dei ceti popolari”. Le giunte dell’ultimo decennio si sono accorte del problema delle case popolari molto in ritardo. “Sì, ma l’aspetto che mi ha colpito di più è che il ceto medio che abita nella zona semiperiferica nelle zone semicentrali comincia a sentirsi estraneo nella propria città. E’ diversa dalla città in cui molti erano arrivati, con la possibilità di avere un lavoro, una casa, una vita dignitosa. Il ‘rito ambrosiano’ è sempre stata una città per sua natura inclusiva, ma è diventata una città esclusiva”. Era anche una città di grande forza sociale, lo è ancora? “La vedo ogni giorno, la generosità dei milanesi: non c’è aspetto di bisogno nella nostra città che non abbia una corrispondente offerta d’aiuto, è il capitale sociale meneghino. Però questa città solidale, ambrosiana, cattolica e nello stesso tempo socialista, cooperativa, mutualistica si sente sempre più distante rispetto alla città dei grandi investimenti, il place to be. E questo divorzio è un divorzio che dovrebbe preoccuparci molto”. Eppure, la sua analisi lo sottolinea, Milano è anche la città di Mind, di università che attirano oltre 250 mila studenti, moltissimi stranieri. “Se Milano vuole avere un futuro la mia proposta è quella di dare una card a tutti gli studenti che sono iscritti alle università, per i servizi e per dare la possibilità di rimanere”. E allora perché tanto spaesamento? “Ovvio che ci sia qualcosa anche di irrazionale, ma è parte della realtà, non va trascurato. Uno dei problemi che ho cercato di mettere in luce è proprio questo: è sbagliato e pericoloso non prendere sul serio la ‘percezione’ dei milanesi”. Ma lei dice che la Milano di oggi non è nemmeno confrontabile, e in positivo, con quella degli anni 70, “questo è innegabile, ma non basta a risolvere lo stato d’animo. Certo, siccome siamo una città vecchia è probabile che guardiamo di più alla nostalgia che non ai progetti futuri”. Non è soltanto questione economica, di capitali e prezzi al metro quadro, insiste De Bortoli. Che apre invece un tema spesso taciuto: “Questo sentimento di estraneità verso la città ‘internazionale’ deriva anche dall’atteggiamento della borghesia produttiva milanese, che è sempre più fatta da grandi famiglie e anche di grandissima generosità sociale; ma questi grandi borghesi si sono internazionalizzati, sono diventati un po’ più cittadini del mondo e un po’ meno cittadini meneghini. Il rischio è che una città del lavoro del talento si trasformi nella città dell’intermediazione, che sconfina con la mano morta, che ha meno a cuore il suo ruolo guida. Per esempio, è estremamente significativa l’arrendevolezza che le istituzioni bancarie milanesi, e anche la borghesia, hanno avuto nella vicenda Mediobanca, che è paradigmatica di una marcia su Milano fatta da un potere politico e di un potere finanziario che è sembrato vittima della propria debolezza”. Rimedi ce ne sono? “La Milano produttiva dovrebbe aprirsi a quella che è la nuova imprenditoria degli immigrati, che costituiscono ormai una classe media che però non ha rappresentanza nelle associazioni. Milano ha sempre avuto per marchio la capacità di includere: chi veniva a lavorare qui ne diventava subito parte. Invece questi nuovi milanesi sono estranei alla città, e ancor più alla sua politica”. Servono milanesi vecchi e nuovi meno estranei a sé stessi. Metapolitica di una città.
Continua a leggere...