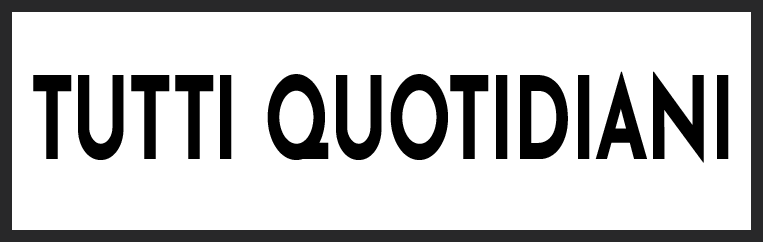Mille notti di grida e rabbia a Teheran. La mattanza al buio di oggi e quel venerdì nero in piazza Jaleh
- Postato il 24 gennaio 2026
- Di Il Foglio
- 30 Visualizzazioni
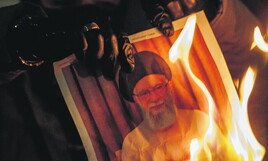
Mille notti di grida e rabbia a Teheran. La mattanza al buio di oggi e quel venerdì nero in piazza Jaleh
Mille notti buie, squarciate da spari, raffiche, esplosioni, grida, slogan, urla di rabbia, di dolore, di paura. A Teheran, a Pechino. Le rivivo come un incubo, che mi accompagna da anni. C’è solo una cosa più angosciante che vedere commettere una mattanza. E’ non vederla, perché viene perpetrata nell’oscurità. A Teheran, prima di procedere alla carneficina, si erano premurati di chiudere la luce. Niente internet, niente campo per i cellulari. Buio totale. Poi, per tre giorni e tre notti, hanno massacrato, picchiato, arrestato senza sosta. Sistematicamente, metodicamente. Come si fa coi tonni, condotti di corridoio di reti in corridoio di reti verso la camera della morte. Con la differenza che nelle tonnare avviene alla luce del sole. Mille notti. Mille indomani. Uno quasi uguale all’altro. Macerie, edifici anneriti e ischeletriti dal fuoco, carcasse di autobus, automobili e mezzi militari incendiati. Cicatrici permanenti, foto e spezzoni di filmati, o anche solo racconti di orrore. E maquillage propagandistici più o meno improvvisati da parte dei regimi. “La sedizione è finita. Dobbiamo essere grati, come sempre, al popolo che l’ha soppressa in modo tempestivo”, l’annuncio del procuratore generale della Repubblica islamica, Mohammad Movahedi. Al prezzo di migliaia di morti riconosciuti dal regime stesso. Mentre, con tempestività davvero eccezionale, comparivano agli incroci e sui cavalcavia striscioni: “Ecco quello che i vandali hanno fatto alle tasse che avete sudato a pagare”. Nemmeno una strage trattiene la propaganda.
Alle prime luci dell’alba, un déjà vu si sovrappone all’altro. Ma talvolta il buio pesto dura anni, decenni, generazioni, avvolge anche la memoria. Solo di recente sono apparsi in rete spezzoni di una corte marziale svoltasi a Pechino nel 1989. Alla sbarra, un generale di corpo d’armata dell’Esercito popolare di liberazione, che si era rifiutato di dare ai suoi soldati l’ordine di sparare in piazza Tiananmen. Il generale Xu Qinxian, in abiti civili, scortato da tre soldati armati, è solo di fronte a un panel di tre alti ufficiali in uniforme. Non ci sono avvocati, non ci sono testimoni, non ci sono spettatori. Gli viene chiesto perché ha rifiutato di far eseguire al trentottesimo Gruppo gli ordini che gli erano stati impartiti. “Non mi sembrava un ordine giusto. Era un delitto contro la nostra storia”, la sua tersa risposta. Condannato al carcere, il generale Xu è deceduto nel 2021, all’età di 85 anni. La sua disobbedienza non era riuscita a impedire che l’unità procedesse alla carneficina. Trentacinque anni dopo i fatti, in Cina è ancora proibito anche solo menzionare Tiananmen.
Non sapere quel che sta succedendo è peggio che vederlo succedere. Non sapere cosa sia successo a tuo figlio, alla tua ragazza, al tuo vicino, al tuo amico, a persone che hai conosciuto, o a persone che non conosci affatto, di cui non sai niente, è, se possibile, anche peggio che sapere che te li hanno ammazzati, sono in prigione, nelle camere di tortura dei regimi. Non è per pietà che si bendavano e si incappucciavano i condannati alle forca o alla fucilazione. Desaparecidos, fu il marchio supremo di terrore del regime dei generali in Argentina. I nazisti perpetrarono l’olocausto nascondendolo agli occhi del mondo. Anche allora qualcuno sapeva, cercò di far sapere. Non gli avevano creduto. Sembrava un’enormità inverosimile. A Londra e a Washington forse sapevano, ma fecero finta di non sapere. Avrebbe distratto dall’obiettivo principale, vincere al più presto la guerra: questa una delle spiegazioni offerte dagli storici. Non c’è peggior buio di quello che ci si impone per indifferenza, per viltà, per opportunità, per partito preso ideologico, per realpolitik.
Nel 1978, quasi mezzo secolo fa, Teheran mi aveva accolto avvolta nel buio della legge marziale e del coprifuoco. Dai tetti si alzavano per tutta la notte imprecazioni contro il regime dello Scià, inni alla libertà, slogan a squarciagola zittiti dalle raffiche di fucili automatici. L’alba rivelava le cicatrici, strade devastate, edifici anneriti dagli incendi. Le sparatorie continuavano durante il giorno. I labirinti del bazar deserto, con le serrande delle botteghe sprangate, sembravano corridoi di un immenso obitorio. Che all’improvviso si rianimavano, come la Kasbah della Battaglia di Algeri, con spari, gente che correva, pattuglie di militari all’inseguimento. Le pallottole che fischiano metalliche – zing, zing, zing – non fanno molta impressione. Sembrano irreali, parte di una colonna sonora. Molto più agghiacciante il click quasi impercettibile del colpo che mette in canna il soldato che ti si para dinanzi. Puoi percepire l’odore della sua paura, sai che, nel suo panico, forse premerà il grilletto.
La prima strage c’era stata l’8 settembre, in piazza Jaleh, una delle piazze del sud povero della capitale iraniana. Era un venerdì. Da allora viene ricordato come “il venerdì nero”. I cortei di protesta confluiti da diverse direzioni, in sfida alla legge marziale che proibiva manifestazioni, erano stati intrappolati nella piazza, poi l’esercito aveva cominciato a sparare. Divenne presto una leggenda, che continuava ad alimentarsi. Si disse che avevano sparato sulla folla anche dagli elicotteri. Si parlava di migliaia di morti. Qualcuno diceva addirittura cinquantamila. Si narrava di enormi fosse scavate coi bulldozer per scaricare i cadaveri. Andai a vedere al cimitero di Behesht-e Zahra. C’erano effettivamente molte fosse scavate di fresco. C’era chi raccontava di aver visto montagne di chador insanguinati appartenenti alle donne vittime del massacro. Ai capannelli che avvicinavamo durante le proteste ti mostravano foto riprese con la polaroid, raffiguranti corridoi di ospedale, obitori insanguinati, mucchi di arti umani amputati.
In realtà ancora oggi, a mezzo secolo di distanza, non si sa quante siano state le vittime, cosa sia successo. E’ innegabile che il massacro ci sia stato. Ma le dimensioni effettive restano un mistero ballerino. Proprio sulla strage di piazza Jaleh, in un recentissimo saggio due studiosi iraniani della svedese Lund University (Arvin e Ardavan Khoshnood, Black Friday revisited: disinformation. misinformation, and the politics of memory at Tehran’s Jaleh square) mostrano efficacemente come la leggenda urbana abbia continuato ad autoalimentarsi. Non è la cronaca a fare le rivoluzioni. E’ il modo in cui vengono raccontate. Io in piazza Jaleh quel giorno non c’ero. Non ero ancora stato inviato a Teheran dal mio giornale, l’Unità. Ma non sono riuscito a trovare un testimonianza diretta nemmeno dai colleghi della stampa internazionale che erano lì già da giorni. Qualcuno mi confessò addirittura che non si erano nemmeno accorti di quel massacro. Piazza Jaleh, all’estremo sud della città era molto distante dagli alberghi del centro in cui alloggiavano i giornalisti. Il New York Times era in sciopero, ne avrebbe riferito per la prima volta solo in un articolo del successivo 6 novembre. Le Monde si limitò a scrivere che c’era stato spargimento di sangue, e che il regime ne attribuiva la responsabilità a potenze straniere. Lo psicanalista Michel Foucault, inviato per il Corriere della Sera, arrivato con la sua equipe di giovani collaboratori quasi allo stesso tempo in cui ero arrivato io, diede per buona la cifra di quattromila morti.
Se l’obiettivo della strage era mostrare il pugno di ferro, terrorizzare, soffocare la protesta, sortì invece l’esatto effetto contrario. Dal bazar di Teheran la protesta si sarebbe estesa agli impianti petroliferi e alle raffinerie di Abadan. Urla e spari sarebbero continuati notte dopo notte. Per settimane, mesi. Intensificandosi anche dopo che lo Scià rilevò dalle sue funzioni il generale Oveissi, il principale esponente della linea dura, e affidò in segno di moderazione il governo a Shapour Bakhtiar, un esponente storico del Fronte nazionale di Mohammed Mossadegh, cioè dell’opposizione allo Scià. Non bastò. Era troppo tardi e troppo poco per cancellare un ventennio di repressione mostruosa, rimediare al vuoto politico creato con il colpo di stato a marchio Cia del 1953. Già allora il tema era: cherchez il petrolio. Non si erano resi conto che quel vuoto sarebbe stato colmato dal ciclone Khomeini. Scontri e sparatorie continuarono giorno dopo giorno, notte dopo notte.
Ricordo bene il giorno in cui lo Scià fece le valigie e scappò all’improvviso. Mi trovavo a intervistare Ehsan Naraghi, un brillante sociologo, dissidente democratico del regime, ma con agganci anche di parentela alla famiglia imperiale. Il telefono continuava a squillare senza interruzione. “Tutti mi chiedono di intercedere con lo Scià perché non parta”, mi spiegò lui. Qualche giorno prima, i giornalisti italiani erano stati convocati dal nostro ambasciatore in Iran. “Ho visto Sua Maestà tranquillo al lavoro, la situazione è pienamente sotto controllo”, ci aveva raccontato. La mattanza non era cessata nemmeno dopo il ritorno dall’esilio parigino di Khomeini, accolto da un’immensa folla, milioni, recatisi a piedi all’aeroporto. Quando, in una sola notte, l’insurrezione spazzò via, come neve squagliatasi al sole, uno dei regimi più sanguinari del Novecento, fu un momento di enorme sollievo. Per tutti. Non si poteva immaginare che il peggio fosse di là da venire.
Mi ero innamorato di una giovane persiana che mi faceva da interprete. Insegnava architettura all’Università, aveva studiato in Italia. Aveva occhi verdi, un volto di luna d’alabastro, e un sorriso splendente. Ci eravamo conosciuti in ospedale, al capezzale di un comune amico, un giornalista ferito nel corso di uno degli innumerevoli scontri di strada. Galeotte erano state le poesie di Catullo che le avevo regalato, e le poesie di Hafez che lei mi traduceva. Mi portava con la sua diane da un capo all’altro dell’immensa città. Protestava attivamente contro il regime. Non indossava il chador, e nemmeno il foulard del pudore, ma eleganti tailleur. Era figlia di un magistrato laico che brevemente fece il ministro della Giustizia nel primo governo di coalizione dopo la caduta del regime, quello del vecchio democratico Bazargan, anche lui esponente storico del Fronte di Mossadegh. Ricordo ancora con una stretta allo stomaco l’angoscia di tante notti insonni nel non sapere se al mattino dopo l’avrei rivista.
L’errore non fu essermi innamorato dell’Iran anche per via di quegli occhi verdi. Fu aver frequentato soprattutto un’élite, trascurando gli umori, gli orientamenti, i fanatismi della massa islamica, della stragrande maggioranza. Confesso di essere recidivo. E’ un errore in cui sono caduto ripetutamente, pervicacemente. Ci caddi a proposito della perestrojka di Gorbaciov. Ci caddi a proposito degli esperimenti di democrazia in Cina, mandati in frantumi dalla mattanza di piazza Tiananmen nel 1989. Ci caddi a proposito delle speranze di un futuro di progresso e di democrazia in un’Europa liberata dal giogo sovietico. Tornai a caderci, ma stavolta con meno entusiasmi, allo scoppio delle Primavere arabe. Ci fu chi brindò alla “rivoluzione del popolo egiziano”. Non immaginavano che sarebbe finita con il generale al-Sisi. Ci si rallegrò per la caduta di Gheddafi. Uno dei peggiori regimi massacratori del proprio popolo è stato quello degli Assad in Siria. Possiamo cullarci nella speranza che con il jihadista Ahmad al-Sharaa vada un po’ meglio?
Più di recente, ci sono in qualche modo ricascato nel ritenere che fosse impossibile che un altro grande paese che ho amato, gli Stati Uniti d’America, potessero finire sotto le grinfie di Trump, e della sua destra sostenuta da un’ondata popolare di consensi dalla pancia dell’America profonda. E poi da un’ondata di consenso servile, di illuminazioni sulla via di Damasco, da parte delle élite che vi hanno trovato un loro tornaconto. Il New York Times ha pubblicato una lista impressionante di quanto hanno guadagnato ancora di più, nel giro di un anno, i super-super ricchi che avevano preso parte in ghingheri all’inaugurazione della nuova presidenza Trump. No, non è vero. Non ci sono cascato affatto. Ho scritto un libro di pessimismo lancinante, quasi profetico, sul peggio che poteva arrivarci addosso, di cui avvertivo i segnali: Sindrome 1933, sulle analogie tra l’attualità e quel che succedeva quando andò al governo Hitler. Anni dopo, si confermano spaventose. Ma speravo, mi illudevo che non succedesse.
La Teheran di fine anni 70 era (e resta ancora oggi) una delle città più brutte al mondo. Una distesa di cemento grigio, attraversata da immensi cavalcavia che non alleviano un traffico impossibile. Rallegrata solo dalla neve che d’inverno imbianca la montagna a cui è addossata. I ricchi in cima, i più poveri giù in fondo, sommersi dai liquami dei ricchi. Il paesaggio è però cambiato in questi decenni. Si è cementificata anche la montagna, ora quasi interamente ricoperta da nuovi casermoni. Sono gli alloggi che il regime ha riservato alla propria nomenklatura, ai pasdaran, agli altri servizi di sicurezza, insomma alla manovalanza della repressione. E’ comprensibile che le autocrazie si abbarbichino al potere, siano terrorizzate all’idea di venirne scalzati. Anche i peggiori regimi hanno i loro beneficati. “La nuova classe” è l’espressione che fu coniata da un comunista jugoslavo, Milovan Djilas, a proposito del sistema staliniano. Di siloviki (apparati) e oligarchi (i nuovi padroni dell’economia, gli ultraricchi, beneficati e al tempo stesso asserviti al potere) si è parlato a proposito della resilienza del regime di Putin. I beneficati dai regimi si stringono sempre come un sol uomo, ferocemente, a sostegno dei propri privilegi. Hanno molto da perdere. Più un regime è fallimentare, più si sente minacciato, più sarà disposto a tutto, anche a massacrare la propria gente.
Potrebbe ripetersi nell’America di Trump? Credo di sì, se perde le elezioni di midterm, e di conseguenza la maggioranza parlamentare che sinora l’ha protetto dall’impeachment per il tentato golpe del 2020. Temo che non si tratti solo di un incubo di quelli che svaniscono all’alba. Il tipo è di quelli che fanno quel che dicono. Ha già convocato i generali per dirgli che dovevano prepararsi a far guerra nelle strade delle città d’America. Impensabile? Quante volte avevamo detto, pensato che certe cose fossero impensabili? Tutti i massacri si somigliano. Ma non tutti si concludono alla stessa maniera. C’è una cosa ancor più spaventosa dei regimi che sparano sui propri cittadini: i regimi che, facendolo, riescono a mantenere il potere. La casistica è varia. Ci sono però delle costanti. Il momento di massima crisi dei regimi autocratici, quello in cui si decide tra cedimento o intensificazione della repressione, ha in genere a che fare con un problema di successione. In Iran le componenti del potere si stanno dilaniando da tempo sulla successione a Khamenei. Il regime sospetta traditori a ogni angolo, ma soprattutto al proprio interno. Putin non ha successori, se non per finta. E nemmeno li ha il sultano Erdogan. Non ha successori Xi Jinping in Cina. Mao, e poi Deng Xiaoping, i successori da loro stessi designati se li erano divorati uno dopo l’altro. Trump è ossessionato da molte cose, ma soprattutto dal problema della successione a sé stesso.
A suo tempo, i despoti a Mosca, e le loro satrapie nell’Europa orientale non avevano osato far sparare sulla folla che demoliva il Muro di Berlino, o su quella che a Mosca aveva reagito al tentato colpo di stato ai danni del riformatore Gorbaciov. Posti dinanzi all’alternativa del fare come aveva fatto Deng Xiaoping a Pechino, avevano ceduto a più miti consigli. Mal glie n’era incolto. Col Muro erano crollati, uno dopo l’altro, regimi di polizia apparentemente inscalfibili. Infine era crollata, da un giorno all’altro, la stessa Unione sovietica. Il regime di Pechino è invece ancora lì, incrollabile nella sua autocrazia imperiale. Tiananmen è passata all’oblio nel corso di appena una generazione. Non ci fosse stato il Covid, probabilmente sarebbe stato soffocato nel sangue il movimento per la democrazia a Hong Kong. E’ andata bene: si sono limitati ad annientarlo con gli arresti in massa. Com’è possibile che se la cavino, vincano regimi che sparano sulla propria gente? It’s the economy, not democracy, stupid?
Continua a leggere...