“Negli Usa avevo casa e lavoro, ho perso tutto. In cella trattamenti inumani e razzisti”: parla l’italo-venezuelano espulso dagli Usa dopo 7 mesi in carcere
- Postato il 21 agosto 2025
- Mondo
- Di Il Fatto Quotidiano
- 1 Visualizzazioni
.png)
Sette mesi in cella negli Stati Uniti, poi l’espulsione in Italia e una vita tutta da ricostruire. David D’Ambrosio, 32enne italiano di origini venezuelane, è rientrato a Roma il 7 agosto dopo la lunga prigionia, trascorsa soprattutto nel carcere della contea di Plymouth, da dove, sotto pseudonimo, aveva raccontato in esclusiva la sua storia a ilfattoquotidiano.it. D’Ambrosio era stato arrestato dagli agenti di frontiera (Ice, Immigration custom enforcement) la sera del 13 febbraio, mentre rientrava a casa: “Non c’erano motivi per catturarmi, avevo la Green card approvata (il permesso di soggiorno permanente, ndr) e aspettavo la residenza, ma non hanno voluto sentire ragioni. E mi hanno portato via lo stesso”, racconta. Dopo i primi 15 giorni al penitenziario Northwest State Correctional Facility, nel Vermont, è stato trasferito per una notte al centro di detenzione di Burlington e infine a Plymouth, in Massachussets. Il rilascio, avvenuto alle 4:30 del mattino, gli è stato annunciato dopo la mezzanotte: “Quando mi hanno detto che sarei uscito da quell’inferno non ho più dormito”, dice. “Mi hanno riportato a Burlington, dove ho aspettato altre quattro ore in una cella condivisa da uomini e donne, e infine in aeroporto, a Boston, per prendere il volo di rientro”. Finita l’odissea, D’Ambrosio parla nuovamente a ilfattoquotidiano.it da Atina (Frosinone) il paese del basso Lazio con poco più di quattromila abitanti dove è cresciuto.
Bentornato a casa. Come ci si sente il “giorno dopo”?
È un’esperienza strana. Da un lato sono contento di rivedere i miei: ho lasciato questo posto un decennio fa e ho lavorato in Scozia per un anno e mezzo, poi negli Stati Uniti per più otto anni. Dall’altro, il paese non è più lo stesso: qui non c’è lavoro, quasi tutti i miei amici sono altrove – chi a Torino, chi all’estero – e non ci sono prospettive per chi rimane. È difficile sentirsi pienamente a casa: nel Massachussets avevo la casa, il lavoro, tanti amici. È lì che sono diventato adulto. Non è facile realizzare di aver perso tutto di un colpo. Ma pazienza.
Meglio lì che in cella…
Non c’è dubbio. Anche perché mi è capitato di condividere la cella con persone che avevano commesso dei reati – spaccio, traffico d’armi – ed erano soliti aggredirmi. Erano stati messi lì con l’etichetta di migranti irregolari per agevolare la loro espulsione e chi non aveva fatto niente doveva solo subire. Mi picchiavano, ricevevo schiaffi all’improvviso mentre ero per conto mio: loro non stavano bene, si credevano intoccabili. La situazione era diventata insopportabile, a un certo punto ho reagito e sono stato portato in isolamento per un paio di giorni: un buco di due metri per quattro, con la luce sempre accesa. Dopo mi hanno cambiato di sezione e non ho più visto i miei aggressori, anche perché il carcere era sovraffollato e c’era un turnover frenetico di detenuti: ne entravano una ventina al giorno, tra cui un minorenne ecuadoriano, cresciuto a New York, ignaro dei motivi della sua reclusione. Gli agenti ignoravano le nostre richieste e domande, e ci rispondevano con insulti razzisti.
Ha mai subito torture?
No, ma il trattamento è stato inumano e degradante. In una cella da cinque persone c’era soltanto un water, in vista, davanti a una finestra e videosorvegliato. La sorveglianza interna era pressoché inesistente: tra i reclusi si verificavano furti, il cibo veniva sottratto sotto minaccia. Qualcuno aveva addirittura un coltello, ma gli agenti non intervenivano. Il cibo poi era spesso crudo, perché veniva preparato dai detenuti stessi, e l’assistenza medica era superficiale: un mese fa mi sono fatto male alla caviglia e non ho ricevuto un’adeguata attenzione. “Non c’è niente di rotto”, mi aveva detto il medico della prigione dopo aver dato un’occhiata veloce. Ora sono in stampelle: la lesione è tale che forse richiederà un intervento. Anche poco prima del rientro mi è stato fatto qualche dispetto: non mi hanno restituito il telefonino e mi hanno sottratto 480 dollari, senza motivo, dal portafoglio.
Le autorità italiane sono mai intervenute?
Va detto che nel mio caso le guardie facevano leva sulle origini venezuelane, senza tenere conto della cittadinanza italiana. Le autorità consolari e diplomatiche erano a conoscenza della mia situazione, l’avevo raccontata al console, ma non potevano garantire condizioni detentive più giuste: quello era un compito delle autorità statunitensi. Il loro obiettivo era quello di tirarmi fuori da quel posto. E ci sono riusciti.
E ora cosa farà?
Direi che non è finita. Il mio caso è aperto, ciò che hanno fatto con me è incostituzionale. Mi hanno rinchiuso in carcere nonostante la Green card fosse approvata: mancava soltanto la residenza, che era in arrivo. Ora sto valutando azioni legali insieme al mio avvocato negli Stati Uniti.
L'articolo “Negli Usa avevo casa e lavoro, ho perso tutto. In cella trattamenti inumani e razzisti”: parla l’italo-venezuelano espulso dagli Usa dopo 7 mesi in carcere proviene da Il Fatto Quotidiano.

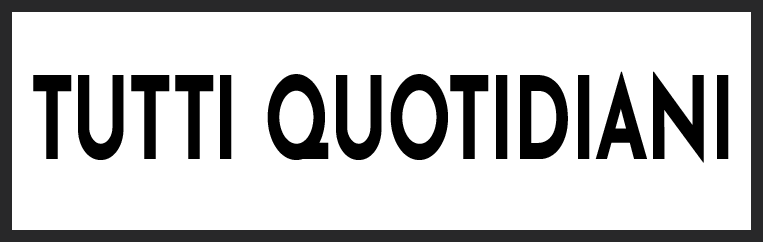
.png)
