“Non potevo fare altrimenti”: eroi loro malgrado, le storie di chi salvò migliaia di persone dallo sterminio nazifascista
- Postato il 25 aprile 2025
- Cronaca
- Di Il Fatto Quotidiano
- 2 Visualizzazioni
.png)
Donne e uomini comuni, spesso giovanissimi, che offrirono rifugio e aiuto a chi veniva perseguitato. Senza proclami, e quasi mai per convinzioni politiche. A loro Fabio Beltrame dedica Sulle tracce del bene – storie di eroismo antinazista (Prospettiva edizioni, 2024), proseguendo il lavoro avviato nel 2016 con Eroi, traditori e
complici nell’inferno nazista. Due raccolte di storie vere, alcune note, altre dimenticate. Studioso di totalitarismi, resistenze e dinamiche del Medio Oriente contemporaneo, nel primo libro Beltrame ricostruiva le responsabilità di chi, per complicità o indifferenza, contribuì agli orrori nazifascisti. In questa nuova raccolta si trovano invece eroi ed eroine loro malgrado. “Molti di loro non si pensavano eroi – spiega Beltrame al Fattoquotidiano.it – ma nel loro insieme, queste scelte individuali di altruismo salvarono migliaia di persone dallo sterminio. Hanno salvato vite e, a volte, anche la propria dignità, infrangendo il conformismo e i propri stessi pregiudizi”.
Cosa ci insegnano oggi quelle scelte controcorrente, così semplici e così radicali?
Il libro non ha pretese pedagogiche, ma da quelle storie si possono trarre molti spunti per l’oggi. Persone diverse per età, provenienza e idee, accomunate dalla scelta di agire per salvare vite e difendere la dignità umana. Molti si trovarono di fronte a una richiesta urgente e imprevista di aiuto. Donne e uomini, ragazzi e persino adolescenti che scelsero di agire senza esitazioni. Dimostrano che è possibile infrangere l’indifferenza e la complicità, anche nelle condizioni più estreme, come avvenne perfino nei campi di sterminio. Sono “persone semplici”, come scrive Carlo Greppi a proposito di Lorenzo Perrone, il muratore di Auschwitz che salvò Primo Levi correndo il rischio di finire a sua volta al di là del reticolato. “Non potevo fare altrimenti” è una delle risposte che diedero più spesso a chi chiedeva dove avessero trovato il coraggio. Non si pensavano eroi, ma ribellandosi di fronte alla barbarie e all’ingiustizia fecero scelte che mantengono, ancora oggi, tutta la loro forza morale.
Quali sono le storie che più l’hanno colpita?
Le storie che lasciano il segno più profondo sono quelle di chi, in Germania, in Italia e nei paesi occupati, inizialmente scelse di ignorare ciò che stava accadendo ad altri. Come Zofia Kossak, scrittrice cattolica e antisemita: per anni pubblicò invettive contro gli ebrei, attingendo ai peggiori luoghi comuni. Li descriveva come una minaccia alla cultura e all’identità nazionale polacca. Poi, nell’agosto del 1942, una svolta radicale: firma un appello pubblico, “Chi non condanna acconsente”, ed entra nel comitato clandestino Zegota, impegnato nel salvataggio dei perseguitati. La sua scelta dimostra che il bene, spesso, implica rompere con il proprio conformismo, con i pregiudizi interiorizzati, con la cultura dominante. Non ha nulla a che vedere con il buonismo, inteso come un individualismo compiaciuto e passivo. Molti di loro erano certo “persone buone”, ma non fu la bontà a guidarli: fu qualcosa di più profondo, il riconoscimento della comune umanità. Lo spiega bene Irena Sendler, assistente sociale di Varsavia che salvò oltre 2.500 bambini dal ghetto. Sapeva che, se fosse stata scoperta, sarebbe stata condannata. Ma sapeva anche che in gioco non c’erano solo delle vite, ma la propria dignità di essere umano. È quella che chiamo “empatia ribelle” e ritrovo in molte di queste vicende. Come quella dei ragazzi e delle ragazze danesi che, nel 1943, organizzarono la fuga della comunità ebraica verso la neutrale Svezia. Una delle figure a cui sono più affezionato è quella Jacques Lusseyran, giovane ipovedente, che malgrado il suo limite fisico non rinunciò alla responsabilità di scegliere da che parte stare, organizzò una rete di giovani resistenti in Francia che misero in scacco la Gestapo per molto tempo durante l’occupazione.
Sono storie che raccontano una sorta di “banalità del bene”, che va in direzione opposta alla tristemente nota “banalità del male” con cui Hannah Arendt definì le scelte distaccate di individui ordinari, incapaci di pensare criticamente e di assumersi responsabilità etica. Per anni queste storie sono rimaste nell’ombra.
Molte sono rimaste sconosciute perché chi le ha vissute ha scelto il silenzio, anche dopo la fine della guerra. È quello che chiamo “il silenzio degli eroi semplici”. Quando hanno parlato hanno dato una spiegazione semplice delle loro azioni di salvataggio: “Cos’altro potevo fare?”. Sono soprattutto i salvati, i sopravvissuti, ad aver parlato dei loro salvatori. Spesso sono emerse per caso: una frase detta a un nipote, una lettera trovata da un figlio. Ci sono studi su queste storie dimenticate. In Italia una delle più significative è la ricerca condotta da anni da Gabriele Nissim.
Forse è più facile studiare le guerre combattute che quelle evitate grazie a mediazioni o obiezioni di coscienza individuali. Cosa ci perdiamo concentrandoci su chi ha fatto scelte sbagliate anziché studiare le ragioni dei “buoni”?
Sono convinto di ciò che scrive Dario Renzi: “Quando il Male appare assoluto è sempre possibile rintracciare il Bene”. Comprendere le scelte di chi ha agito per il bene degli altri è anche un modo per resistere alla rassegnazione. Marek Edelman, vicecomandante della rivolta del ghetto di Varsavia nel 1943, mi disse che la rivolta non puntava alla vittoria militare, avevano combattuto per affermare la dignità umana pur consapevoli che non avrebbero potuto sconfiggere l’esercito nazista, la Gestapo e le SS. Le rivolte nei ghetti e nei campi di sterminio – condotte da ebrei, rom, oppositori politici, omosessuali – hanno infranto luoghi comuni come la presunta passività e rassegnazione delle vittime. L’obiettivo dei carnefici nazisti non era solo l’eliminazione fisica, ma l’annientamento della volontà e della dignità umana. Eppure, anche lì, qualcuno ha scelto. Non erano persone straordinarie: erano persone comuni che hanno compiuto scelte straordinarie. “Non c’è ambiguità: noi restiamo uomini, finiremo da uomini”, scrive Robert Antelme, sopravvissuto ad Auschwitz. Oggi, quel “restare umani” ci interpella, perché viviamo una crisi globale. Le guerre non riguardano solo l’Ucraina o il genocidio nella Striscia di Gaza scatenato dalla ritorsione feroce dal governo di Israele dopo il pogrom di Hamas del 7 ottobre. Nel mondo ce ne sono oltre cinquanta. Restare umani forse non basta più: bisognerebbe cercare di essere ‘meglio’ umani. Nel linguaggio della politica, la disumanizzazione è costante. A volte si presenta con toni apparentemente stupidi, ma produce effetti pericolosi: alimenta quel “cattivismo” che vede nell’altro una minaccia e finisce per legittimare la violenza.
Certo, le forme del razzismo contemporaneo sono diverse da quelle espresse dai regimi fascista e nazista di cui scrive nei suoi libri. Come si può evitare di fare paragoni inopportuni con il passato?
Non ci sono camicie nere con il fez, né la Gestapo per le strade di Berlino. Ma l’odio e il pregiudizio sono ancora ovunque, con nuovi strumenti. Il web e i social hanno amplificato forme di negazionismo, antisemitismo, razzismo, islamofobia, omofobia, l’esaltazione di un patriarcato violento. Spesso tutto questo si maschera da “libertà individuale”. Alla meglio diventa un “mi piace”, alla peggio un insulto, una minaccia. Ma non voglio generalizzare, incontrando tanti ragazzi delle scuole vedo in molti una volontà chiara di sottrarsi alla logica della delega e dell’indifferenza. Riconoscono i rischi legati ai social e al web nel diffondere qualunquismo, isolamento, individualismo, indifferenza. Cambiano le forme della partecipazione, ma non manca l’impegno solidale. Portano esempi molto concreti di resistenza, segni di speranza. Parola che non era cara solo a un gigante come Papa Francesco, ma a tanta gente comune.
Nell’immagine di copertina: Jankiel Herszkowicz, artista del ghetto di Lodz e protagonista della resistenza. Foto di Mendel Grossmann, 1941
L'articolo “Non potevo fare altrimenti”: eroi loro malgrado, le storie di chi salvò migliaia di persone dallo sterminio nazifascista proviene da Il Fatto Quotidiano.


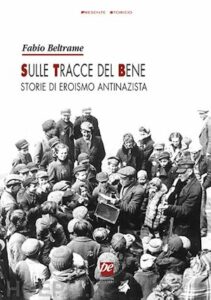
.png)

