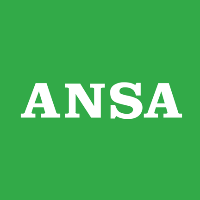San Siro, la resa di Milano: venduto il suo stadio simbolo
- Postato il 18 ottobre 2025
- Di Panorama
- 1 Visualizzazioni


Il Consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita di San Siro per 197 milioni di euro, aprendo la strada alla demolizione del Meazza e alla costruzione di un nuovo stadio da 1,2 miliardi firmato Foster e Manica. Questo è un fatto. Una decisione che cambia la storia del fútbol italiano e di una città che per quasi un secolo ha fatto del suo stadio la Scala del calcio.
Il nuovo impianto sarà privato e del vecchio resterà solo una parte del secondo anello della curva Sud.
Inter e Milan, sostenuti dalla giunta di Beppe Sala, puntano a impianti più redditizi. Per il Comune è un modo per alleggerire il bilancio, ma anche una resa di fronte a un monumento che altrove sarebbe stato restaurato. Dietro l’operazione ci sono i fondi americani Oaktree Capital, nuovo proprietario dell’Inter, e RedBird Capital Partners, azionista del Milan.
Ma resta la domanda: si poteva farlo senza cancellare un simbolo collettivo? Madrid, per esempio, ha scelto di non abbandonare il Bernabéu. Il Real ha investito oltre un miliardo di euro, finanziato da prestiti ventennali, per trasformare la sua arena in un colosso tecnologico, senza spostarla di un metro. Il campo è retrattile e scompare in sei vasche ipogee e climatizzate, sotto la tribuna principale. Il tetto si chiude in pochi minuti. Le facciate sono un velo d’acciaio e luce. Tutto resta dove è sempre stato, ma tutto è cambiato.
Le finali del 1957 e del 1982, la finale di Champions del 2010 e quella storica di Copa Libertadores del 2018 tra Boca e River sono parte del suo mito. È l’unico stadio al mondo ad aver ospitato finali di Coppa dei Campioni, Mondiale, Europeo e Libertadores. Ogni angolo è memoria viva: il boato di Alfredo Di Stéfano, la corsa di Francisco Gento, il trionfo di Paolo Rossi e Marco Tardelli. Innovare non ha significato demolire, ma dare futuro a un luogo identitario.
Liverpool ha fatto lo stesso. Anfield è stato ampliato portandolo a 61.276 posti, spendendo circa 120 milioni di euro per la nuova Anfield Road Stand. Il club non ha lasciato il quartiere, e la scritta “This is Anfield” continua a tremare sopra il tunnel degli spogliatoi. La voce della Kop, la storica curva, è la stessa. Lì, nel 1977, il Liverpool eliminò lo Saint-Étienne con una rimonta epica e iniziò la sua leggenda europea.
E poi, il 7 maggio 2019, la notte dell’impossibile: il 4-0 al Barcellona di Lionel Messi (dopo la sconfitta per 3-0 all’andata), l’urlo di Jurgen Klopp, le lacrime dei tifosi, la prova che un muro di cemento può diventare anima collettiva. Anfield è un esempio perfetto di come modernità e memoria possano convivere.
A Dortmund il Westfalenstadion, oggi Signal Iduna Park, è il tempio più caldo della Germania. I lavori di ammodernamento, per un costo complessivo intorno ai 200 milioni di euro, non ne hanno intaccato l’anima. La Südtribüne, la Muraglia gialla, accoglie ancora oltre ventiquattromila tifosi in piedi, la curva più grande d’Europa. La semifinale mondiale del 2006, Germania-Italia, 0-2 con Fabio Grosso e Alessandro Del Piero ai supplementari, è rimasta nella memoria collettiva. Nel 2001, in quello stesso impianto, il Liverpool vinse una finale di Coppa Uefa surreale, 5-4 contro l’Alavés, decisa da un autogol di Delfí Geli al golden goal. Ogni derby con lo Schalke trasforma lo stadio in un inferno giallo, e ogni partita è un rito comunitario. È la dimostrazione che si può essere moderni senza rinunciare al cuore.
Valencia ha tenuto in vita il Mestalla. Inaugurato nel 1923, è il più antico stadio di Spagna ancora in uso. Ha resistito all’alluvione del Turia nel 1957 e alle tentazioni del nuovo Nou Mestalla, un progetto da oltre 300 milioni rimasto incompiuto.
Qui, durante il Mondiale del 1982, si giocarono le partite della Spagna nel primo girone, e le immagini dei tifosi con i ventagli e i cori sotto il sole raccontano ancora il calcio come rito popolare. Il Mestalla, con le sue gradinate ripide e il colore arancio dei seggiolini, è un’icona di autenticità.
Berlino ha scelto la via della tutela. L’Olympiastadion, vincolato come bene monumentale, è stato restaurato tra il 2000 e il 2004 con una spesa di circa 240 milioni di euro. Ha conservato la maestosità del 1936 e l’apertura della Porta della Maratona, ma oggi è un impianto moderno e funzionale. Qui l’Italia vinse il Mondiale del 2006 ai rigori contro la Francia di Zidane. Qui si è giocata la finale di Euro 2024, Spagna-Inghilterra, confermando Berlino come capitale sportiva d’Europa. La Germania ha dimostrato che la storia non è un ostacolo, ma una risorsa.
Marsiglia ha investito 270 milioni di euro per coprire e ampliare il Vélodrome tra il 2011 e il 2014. Tetto avveniristico sopra 67 mila posti, ma lo stesso spirito mediterraneo. Qui si giocò la semifinale del Mondiale 1998, Brasile-Olanda, decisa ai rigori, e quella di Euro 2016, Francia-Germania, con la doppietta di Griezmann. Il Vélodrome è ancora la casa dei marsigliesi, tra bandiere e cori che si confondono con il rumore del mare. A Parigi, il Parc des Princes è rimasto di proprietà comunale nonostante i tentativi di acquisto del Qatar Sports Investments, che controlla il Paris Saint-Germain.
La sindaca Anne Hidalgo ha ribadito che lo stadio non è in vendita. È un bene civico e simbolico, e il Psg continuerà a giocarci in affitto.
Qui la Francia di Michel Platini vinse l’Europeo del 1984 contro la Spagna. Qui nascevano i gol di George Weah e le magie di Ronaldinho, e più tardi i trionfi del Psg di Zlatan Ibrahimovich e Mbappé. È la dimostrazione che un Comune può difendere la propria identità anche di fronte al potere dei fondi sovrani.
In Italia non mancano esempi diversi. Roma ha conservato l’Olimpico, restaurato per Italia 90 e poi più volte aggiornato, teatro del Mondiale 1990 e della finale di Champions 2009. Firenze ha scelto di recuperare l’Artemio Franchi di Pier Luigi Nervi, con un progetto da 95 milioni del Pnrr che tutela la torre di Maratona e le curve storiche. Fuori dall’Europa, il Messico ha scelto di rinnovare l’Azteca in vista del Mondiale 2026. Sarà il primo stadio della storia a ospitare tre Coppe del Mondo. I lavori, stimati tra 75 e 100 milioni di dollari, restituiranno vita al tempio di Pelé, Maradona e delle due finali più iconiche del secolo scorso.
Rio de Janeiro ha rifatto il Maracanã, spendendo oltre 600 milioni di dollari, mantenendo però il suo spirito: qui si consumò il Maracanazo del 1950 e si incoronò la Germania campione del mondo nel 2014. Buenos Aires ha ristrutturato il Monumental, portandolo a 84 mila posti con un investimento di circa 45 milioni di dollari, restituendo al River Plate un’arena moderna ma fedele alla propria anima.
Ci sono poi le scelte opposte. Londra ha demolito White Hart Lane per costruire il nuovo Tottenham Hotspur Stadium, un impianto da 62 mila posti costato 1,2 miliardi di euro, con prato retrattile e doppio campo per partite Nfl. L’Atletico Madrid ha abbattuto il Vicente Calderón per edificare il Metropolitano, investimento da 310 milioni che ha allontanato l’Atlético dal fiume Manzanares. Torino ha demolito il Delle Alpi nel 2009 per costruire l’Allianz Stadium nel 2011, spendendo 155 milioni.
Ma Milano ha scelto di vendere e demolire per attrarre capitali privati. Però avrebbe potuto seguire altre vie, come Berlino o Parigi. La ristrutturazione del Meazza, stimata tra 800 milioni e un miliardo, sarebbe costata meno di un impianto nuovo. San Siro è stato la Scala del calcio. Ha visto i gol di Nordahl, Liedholm e Schiaffino, le geometrie di Rivera e Mazzola, la potenza di Gullit e Rijkaard, le magie di Kaká e gli applausi per Javier Zanetti.
Lì Giuseppe Meazza, già simbolo dell’Inter e della Nazionale, incantò il pubblico nelle partite degli anni Trenta, quando la Nazionale di Pozzo provava le sue geometrie in vista dei Mondiali. Lì Marco van Basten segnò quattro gol al Göteborg nella notte del 25 novembre 1992, compresa una rovesciata da manuale che fece il giro del mondo.
Lì, alla terza giornata del suo primo campionato italiano, Ronaldo siglò la prima rete in Serie A: il primo “Fenomeno show” italiano. Lì, il 9 giugno 1990, si alzò il sipario sui Mondiali d’Italia con Argentina-Camerun: Maradona in campo, Omam-Biyik in cielo, e un colpo di testa che fece tremare il mondo.
A San Siro si sono giocate quattro finali di Coppa dei Campioni e Champions League: 1965, 1970, 2001 e 2016.
San Siro è la casa della memoria, il luogo dove Milano si riconosce e dove il calcio è diventato parte della sua storia. È la voce della città nel mondo, la sua colonna sonora collettiva. Come le grandi cattedrali avrebbe potuto essere restaurato, non abbattuto. Altrove lo hanno fatto, a Milano, no.