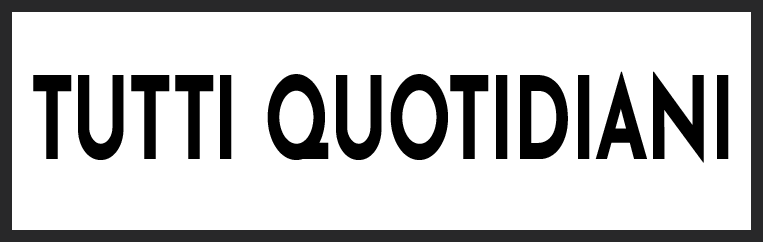Srebrenica, il luglio di sangue
- Postato il 5 luglio 2025
- Di Panorama
- 1 Visualizzazioni


A Srebrenica, nelle viscere della Bosnia Orientale, l’offensiva dei serbi contro una città inerme cominciò il 6 luglio 1995 quando le luci di un’alba ancora incerta stavano rosicchiando il buio della notte. I primi morti ammazzati vennero trascinati fuori dal letto dove dormivano. Non dovettero rendersi compiutamente conto del pericolo perché le lame delle baionette squarciarono loro la gola senza che avessero il tempo per un sospiro da svegli.
Invece, le altre migliaia di vittime – fino al 25 luglio – ebbero modo di capire che la loro vita non valeva più niente.
8.372 i nomi delle persone giustiziate anche se l’elenco risulta ancora «provvisorio». La gente della città sostiene che – per gli stenti e in seguito alle ferite – ne morirono 4 mila in più. Violenza arroventata dall’odio.
Non si fecero scrupolo dallo stuprare Devla Ajsic che era al quarto mese di gravidanza. Sventrarono una nonna di 94 anni – Saha Salih Izmirlic – che, sulla porta d’ingresso di casa sua, aveva tentato di sbarrare il passo dei soldati, risoluti a entrare. E trascinarono via Hava Muhic, ancora sporca degli umori del parto ma la piccola appena nata, con il cordone ombelicale appena staccato, la lasciarono dov’era senza preoccuparsi se era destinata a morire in mezzo agli stracci. Secondo l’esperienza dei pediatri, l’agonia durò due giorni. La mamma voleva chiamarla Fatima.
Ne ammazzarono in quantità, di donne, ma è contro gli uomini che si accanirono con feroce risolutezza. I bosniaci per etnia – «bosgnacchi» – e di religione musulmana dovevano essere totalmente eliminati. Non esistevano intenti strategici né motivazioni belliche. Li ammazzarono per rispondere a richiami ideologici infami.
Volevano cancellarne le tracce, «fare pulizia», distruggere la radice stessa delle loro esistenze. Non importa se ragazzi adolescenti o giovanotti, padri di famiglia o anziani, incapaci di muoversi senza appoggiarsi a un bastone. Insieme al futuro, dovevano azzerare anche la memoria.
A ondate, si tuffarono – anche scalzi – fra i rovi dei boschi dove le doline della periferia della città cominciano a prendere quota verso il Trebevic o lo Zvijerda. Sfidarono i colpi delle mitraglie che li inseguirono e rischiarono sotto il fuoco delle bombarde che tentarono di impedirne fuga.
Gli altri vennero ammassati a gruppi nelle scuole, nel recinto dell’istituto termale o nei capannoni di lavorazione delle miniere di zinco e di piombo.
Quelli che non trovarono la morte nelle prime ore di violenza furibonda (e che non riuscirono a scappare) vennero massacrati alla spicciolata. Con procedure ripetitive, ne prelevavano una trentina per volta, lasciando intendere che dovevano interrogarli per acquisire una serie d’informazioni. In realtà, le ruspe avevano già aperto la fossa che era stata loro destinata. Li obbligarono a consegnare tutto quello che avevano e, prima di sparare o affondare il pugnale, pretesero che si mettessero nudi. Almeno due volte, per evitare che i tumuli rivelassero l’esistenza di un cimitero, riesumarono i cadaveri alla rinfusa per seppellirli da un’altra parte.
Per questo, risultò difficile recuperare i morti e, soprattutto, dare un nome alle vittime che, con fatica, sono state identificate (non per tutte però è stato possibile) con complicate comparazioni dopo i prelievi di dna.
Fu una processione di morti in cammino che, con rari intervalli, andò avanti due settimane. Anche nelle ore della notte. I prigionieri terrorizzati con gli occhi a cercare un inesistente conforto nel buio. I soldati, eccitati dalle bottiglie di rakija da tracannare e sbronzi di quella pazzia che li rendeva refrattari all’indulgenza e indisponibili alla compassione. I meno rozzi confusero l’ignominia con il patriottismo.
Altri sfogarono antichi risentimenti razzisti malamente coltivati. Zeljko Raznatovic mise in pratica gli insegnamenti mandati a memoria fra una rapina e il carcere, un delitto per rivendicare la propria leadership criminale e un’evasione (dal Forest di Bruxelles, per esempio o dal San Vittore di Milano). Aveva scelto di farsi chiamare «arkan». Alcuni sostengono che il nome fosse mutuato dal termine latino «arcanus» che sta per «misterioso». Difficile che un selvaggio con gli istinti dell’assassino fosse in grado di ispirarsi all’antichità classica. Più facile – come sostengono i più – che abbia recuperato l’immagine di una tigre dello zoo di Belgrado che attirava l’ammirazione degli spettatori perché, più imponente della media, si muoveva in gabbia come fosse la patrona della Malesia.
Non a caso, i suoi uomini si presentarono come «tigri di Arkan». A Srebrenica, non uccisero a fucilate «perché i proiettili costavano» e preferirono affidarsi alle lame dei coltelli «che assicuravano maggiore soddisfazione».
Tuttavia, le maggiori responsabilità del massacro vanno equamente ripartite fra il capo di Stato maggiore militare Ratko Mladic e Radovan Karadzic cui era attribuita la carica di presidente della Repubblica serba di Bosnia ed Erzegovina. Due personaggi anonimi fino agli albori degli anni Novanta.
Uno – orfano, affiliato alla «lega comunista» e poi allievo della scuola ufficiali – fu protagonista di una carriera incolore nell’esercito fino al grado di colonnello. Poi, con la confusione dei riferimenti istituzionali, i galloni di generale se li attribuì da solo.
L’altro era figlio di un calzolaio che, per aver militato fra i «cetnici» monarchici, patì i rigori del governo a falce e martello. Studiò psichiatria, scrisse poesie e finì sotto inchiesta per alcuni finanziamenti che aveva ottenuto falsificando i documenti. Inizialmente, sembrò attratto dalle politiche green. Poi accettò di rappresentare il nazionalismo più risoluto.
La morte di «Tito» Josif Broz, il 4 maggio 1980, significò anche l’inizio della dissoluzione della Jugoslavia. Fino a quel momento, con pugno d’acciaio e atteggiamenti diplomatici proficuamente accorti, era riuscito a tenere insieme nazionalità anche incompatibili fra loro ma, senza il suo carisma, presero corpo rivendicazioni malamente represse. I successori alla presidenza congelarono alcuni problemi senza risolverli tanto che, a distanza di qualche anno, con il crollo del muro di Berlino (9 novembre 1989) i conflitti etnici – diventando evidenti – si fecero esplosivi. Gli sloveni furono i primi a dichiararsi indipendenti. Poi i serbi. E, dopo ancora, i croati.
La Bosnia (con l’Erzegovina) costituiva una doppia enclave. Prima fisica per l’essere una specie di «buco» circondato da montagne anche impervie. In passato, le Alpi Dinariche, da una parte, e il bacino del Narente, dall’altra, avevano rappresentato uno scudo capace di proteggere dalle incursioni dei nemici. Ma, in tempi più recenti, le barriere, provocandone l’isolamento, si erano trasformate, piuttosto, in un problema. Ancora più «pericolosa» l’enclave etnica che si ritrovò animata da un crogiuolo di razze che – più che «diverse» – si scoprirono antagoniste. Fino a pochi mesi prima, i vicini di casa – non importa se discendenti da turchi o di religione ortodossa – aprivano le porta a chi abitava dall’altra parte del pianerottolo. Andavano in vacanza insieme. Lasciavano che i figli giocassero fra loro.
Improvvisamente, ognuno si sentì investito dall’obbligo di rivendicare la propria identità e gli amici di un tempo presero le forme degli avversari da abbattere. I serbi si illusero di diventare parte della «Grande Serbia» e di portare la Bosnia a Belgrado. Pure i croati rivendicarono una supremazia sociale anche se loro guardavano piuttosto all’Albania con lo scopo di fondersi o di federarsi. A farne le spese furono i bosniaci musulmani che non avevano padrini e non avevano risorse. Finirono per diventare il vaso di coccio fra quelli di ferro. Da stritolare e fare a pezzi.
Le Nazioni Unite si resero conto del pericolo e inviarono reparti di caschi blu perché esercitassero il potere della dissuasione mettendosi fra fronti contrapposti. A Srebrenica, i soldati dell’Onu s’insediarono e apparvero determinati al punto da tranquillizzare gli abitanti. Erano 600 e venivano dall’Olanda. Ma quando le bande serbe misero a ferro e a fuoco la città, non ebbero il coraggio di intromettersi.