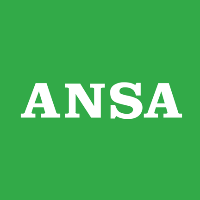Le possibili ragioni per cui si è evoluto l'autismo
- Postato il 10 settembre 2025
- Di Il Foglio
- 3 Visualizzazioni
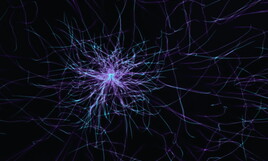
Le possibili ragioni per cui si è evoluto l'autismo
È stato appena pubblicato uno studio che prova a rispondere a una domanda difficile: perché l’autismo è così frequente nella nostra specie e non nelle altre? Per capirlo bisogna partire dal cervello, e in particolare da un tipo preciso di neuroni, le cellule nervose che costituiscono la neocorteccia, cioè la parte più recente ed espansa del nostro cervello, quella che ci permette di parlare, ragionare, immaginare. In ogni cervello ci sono molti tipi diversi di neuroni, e di solito quelli più numerosi tendono a cambiare molto poco lungo l’evoluzione, perché sono troppo importanti per correre rischi. Questo lo si è visto confrontando milioni di neuroni provenienti da diverse specie, studiati grazie a tecniche che permettono di leggere, cellula per cellula, quali geni siano attivi. La regola è semplice: più un tipo di neurone è abbondante, più rimane stabile tra specie.
Ma nell’uomo c’è un’eccezione clamorosa. I neuroni che stanno negli strati 2 e 3 della corteccia, quelli che collegano diverse aree tra loro e che sono particolarmente numerosi proprio nel nostro cervello, hanno seguito una traiettoria diversa: si sono evoluti più rapidamente del previsto, proprio lungo il ramo umano. Non è stato un cambiamento casuale: le analisi mostrano che la selezione naturale ha favorito un abbassamento coordinato dell’attività di molti geni, e in particolare di quelli che oggi sappiamo essere legati all’autismo. Per rendere l’idea, uno dei geni studiati, DLG4, serve a produrre una proteina fondamentale per l’impalcatura delle sinapsi, cioè i punti di contatto tra neuroni. Negli scimpanzé è molto attivo, nell’uomo molto meno. Non significa che questa sola differenza causi autismo, ma se il livello di partenza è già più basso, basta una mutazione o una variazione minima per scendere sotto una soglia critica. È come avere un sistema che funziona benissimo ma è più vicino al limite: guadagna in flessibilità, ma diventa anche più sensibile alle perturbazioni.
Gli autori hanno verificato questo schema in tre diverse regioni della corteccia, trovando sempre lo stesso segnale. Hanno anche confrontato gli esseri umani non solo con scimpanzé ma con gorilla, per capire su quale ramo evolutivo fosse avvenuto il cambiamento, e il risultato punta chiaramente alla linea umana. Per essere più sicuri, hanno riprodotto il fenomeno in laboratorio usando organoidi cerebrali, piccoli modelli tridimensionali di tessuto umano coltivati a partire da cellule staminali: anche lì, gli alleli umani mostrano un’attività ridotta rispetto a quelli degli altri primati.
Il punto interessante è che questa riduzione non è stata uno svantaggio, anzi probabilmente ha dato vantaggi notevoli. Un’attività genica più bassa nei neuroni di collegamento potrebbe aver rallentato la maturazione del cervello umano dopo la nascita. Significa che la nostra neocorteccia è rimasta plastica e modellabile più a lungo, allungando la finestra in cui l’ambiente e la cultura potevano lasciare un’impronta duratura. Questo prolungamento dello sviluppo cerebrale è considerato uno dei fattori cruciali che hanno permesso all’uomo di imparare il linguaggio, di accumulare conoscenze e di trasmetterle. In altre parole, le stesse trasformazioni che ci hanno reso capaci di linguaggio e di cultura sono quelle che hanno aumentato la probabilità che, in certi individui, il sistema superi la soglia critica e compaiano tratti autistici.
Lo studio però non si ferma qui. Lo stesso schema, seppure con minore forza, si osserva anche con i geni collegati a un’altra condizione tipicamente umana: la schizofrenia. Anche in questo caso, sono sempre i neuroni di collegamento della corteccia a essere coinvolti. È come se l’evoluzione avesse scelto di scommettere proprio su questo sottotipo neuronale, rendendolo il motore della nostra complessità cognitiva e al tempo stesso il punto più fragile. Il legame tra autismo e schizofrenia non è casuale: entrambe le condizioni colpiscono la capacità del cervello di integrare informazioni su lunga distanza e di bilanciare in modo fine le connessioni tra aree diverse.
Il messaggio che emerge non è che l’autismo o la schizofrenia siano stati selezionati perché utili, ma che le trasformazioni che hanno reso il nostro cervello più complesso e flessibile hanno comportato anche una maggiore vulnerabilità. Non si tratta quindi di adattamenti diretti, ma di effetti collaterali di una spinta evolutiva che ha reso l’uomo quello che è. La neurodiversità, in questo senso, non è un’anomalia da spiegare a parte, ma fa parte integrante del cammino evolutivo che ci ha resi umani, con le nostre straordinarie capacità cognitive e con le fragilità che ne derivano.
Continua a leggere...