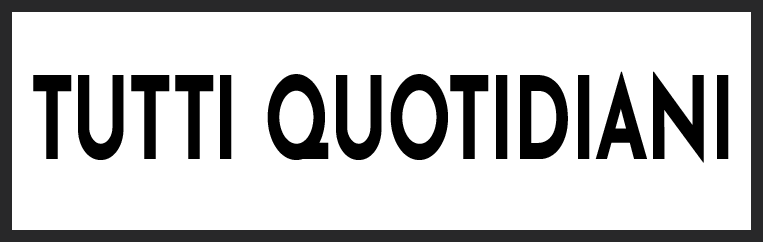Alla scoperta della Piccola Biblioteca di Cuti con il poeta Daniel Cundari
- Postato il 4 febbraio 2026
- Notizie
- Di Quotidiano del Sud
- 3 Visualizzazioni

Il Quotidiano del Sud
Alla scoperta della Piccola Biblioteca di Cuti con il poeta Daniel Cundari

Nel cuore di Rogliano, immerso nella Valle del Savuto, Daniel Cundari ci ha guidati alla scoperta della Piccola Biblioteca di Cuti. L’intervista al poeta. Un racconto dove arte e restanza si intrecciano senza retorica, con naturalezza radicale.
ROGLIANO, CUTI (COSENZA) – «Non a Brooklyn né a Manhattan, ma a Cuti». Il navigatore ci guida fin dove la tecnologia smette di avere importanza. Poi si arresta. Rogliano emerge come un respiro antico nella Valle del Savuto. Tra le sue vie silenziose, un piccolo rione si illumina con la Piccola Biblioteca di Cuti. Ad accoglierci, sulla soglia, c’è Daniel Cundari. Poeta, scrittore, performer plurilingue. Uno di quegli artisti che il mondo ha conosciuto prima del suo stesso territorio. Dalla Cina al Messico, dalla Spagna a Cuba, dalla Francia alla Serbia, ha portato con sé radici e lingue, frammenti di paesaggi e di memorie. Premi importanti costellano il suo percorso – Lerici Pea, Genil de Literatura, Pericle d’Oro, Premio Metastasio, Premio Roublikon – eppure qui, in questo spazio raccolto e pulsante, nulla è celebrazione. Tutto è necessità.
La biblioteca è un ventre caldo. Varcarne la soglia è attraversare il tempo. Luci soffuse illuminano oggetti naufragati da ogni angolo del mondo: piccole mongolfiere sospese come sogni, specchi che restituiscono domande invece di riflessi e custodiscono motti e visioni, maschere, fotografie di Pier Paolo Pasolini, Alda Merini, Fabrizio De André, Marina Abramović. Il manifesto di “Un ragazzo di Calabria”. Una valigia traboccante di promesse regge una lavagna con una scritta che è già un invito: “Ascoltiamo storie d’amore gratis”.
E poi i libri. Ovunque. Libri come ossa, come semi, come fondamenta. È una biblioteca, sì. Ma non solo. È rifugio e soglia, laboratorio poetico e presidio culturale. Una fenditura luminosa nel quotidiano. Qui si ospitano performance, presentazioni, incontri. Piccola nelle dimensioni, enorme nella capacità di accogliere saperi, esperienze, ricordi. Una stanza del mondo, una casa della parola, dove artisti, viaggiatori e pensieri trovano dimora. Ci siamo immersi in questa magica atmosfera per ascoltare una storia che parla di talento e resilienza. Una storia di Calabria. Di quella Calabria che non chiede più il permesso di esistere, che non fugge, ma resta. E proprio restando si apre a geografie lontane.
La Piccola Biblioteca di Cuti opera ufficialmente come contenitore di libri e idee dal 2023, ma le sue pietre raccontano metamorfosi molto più antiche: vineria, filatoio di lane, ultima cellula clandestina del partito monarchico in Calabria, deposito di derrate alimentari durante la guerra. Ogni angolo è memoria. Ogni oggetto, un testimone silenzioso di passaggi, fatica, creatività. Oggi, la biblioteca è spazio di cultura viva. Qui sono passati, tra gli altri, il percussionista Alfio Antico, il cantautore Peppe Voltarelli, il chitarrista Francesco Loccisano, l’antropologo e scrittore Vito Teti, il violinista Rares Morarescu. Ognuno ha lasciato una traccia, una vibrazione, un racconto sospeso nell’aria.
La Piccola Biblioteca di Cuti non è folklore, né curiosità da cartolina. È una visione concreta. Dimostra che la periferia può diventare centro, che la poesia può essere infrastruttura, che la Calabria – quando crede nelle proprie parole – non ha bisogno di partire per esistere. Basta fermarsi. Ascoltare. E, a volte, perdersi un po’. Questa sera, al Calabrie Fes Fest di Reggio Calabria, Daniel Cundari presenterà “Una catastrofe psicocosmica e la parola tellurica”. Noi lo abbiamo intervistato qualche giorno fa, per entrare nel suo universo e scoprire una delle più piccole biblioteche del mondo, dove arte e restanza si intrecciano senza retorica, con naturalezza radicale.
Daniel Cundari, la Piccola Biblioteca di Cuti sembra una biografia in forma di spazio. Da dove nasce tutto questo?
«Sono nato qui, a Cuti. Mi sono formato prevalentemente fuori, ma questo luogo è sempre stato una matrice. Da bambino, grazie a mio nonno, ai miei genitori, alla biblioteca di mia madre, a otto anni già recitavo in dialetto. Qui facevo le prime prove con gli amichetti. Questo posto è stato tante cose: nell’Ottocento un filatoio di lane, poi una vineria, poi un’enoteca, in cui lavoravo d’estate. Ho sempre avuto una grande passione per l’enogastronomia, anche all’estero. Ma ovunque io sia stato – Granada, Barcellona, Valencia – ho sempre militato nelle riviste, frequentato intellettuali, ascoltato. Ho fatto da spugna. E quando sono tornato, ho riportato tutto qui».
Il dialetto è centrale nella sua poetica, è lingua universale…
«Il dialetto che uso è quello di mia nonna. Ho annotato frasi, suoni, cadenze, reinventandoli come lingua universale. Quando recito nel mio dialetto, sto usando una lingua al pari del giapponese o dell’inglese. La lingua, quando viene detta, diventa suono, vibrazione. È questo che arriva al pubblico, ovunque nel mondo».
Al centro della stanza, una gabbia aperta che custodisce un libro cattura subito lo sguardo. Che relazione esiste tra libertà, memoria e letteratura?
«Mio padre, da bambino, catturava fringuelli e canarini e registrava il loro canto. Quelle gabbie sono rimaste impresse nella mia memoria. Ne ho presa una, l’ho pulita, l’ho aperta e vi ho posto dentro un libro di António Lobo Antunes. È arte concettuale: aprire la gabbia significa liberare la letteratura. I fili che vedi sospesi intorno sono tracce di performance e mostre passate. Ogni settembre, durante il festival “Fuggire per restare, restare per fuggire”, questo luogo si trasforma in un kilim, un arazzo di opere, storie e biografie appese».

La mongolfiera sospesa è un simbolo di evasione o, paradossalmente, di restanza consapevole?
«L’ho realizzata io. È il simbolo della libertà, ma anche dell’ironia calabrese. Ci sono scritte frasi dei cosiddetti “scoraggiatori militanti”: “Ma chi ta fa fa’?”. A un certo punto al calabrese devi dire “tieni ragiune” e poi andare avanti. C’è scritto anche “mo scinno”, nel senso “ora scendo”. È una presa in giro, ma anche una filosofia».
Tra i suoi viaggi, quale esperienza l’ha segnata di più?
«Ho vissuto a Siena, Roma, Granada, Shanghai, in Cina, e in Messico. Forse il Messico mi ha segnato più di tutti, anche perché lì mi sono dedicato alla cucina oltre che alla scrittura e alla performance».
Daniel Cundari, nei suoi testi le parole sembrano respirare, vibrare, a volte persino ferire. Cosa accade quando la parola va oltre il significato, diventando presenza, energia o canto interiore?
«Domanda difficile! La parola, per un poeta, è tutto. E allo stesso tempo può essere anche il nulla. Recitare è un atto primordiale, antico quanto l’uomo. Attraverso la parola ci si smarrisce per ritrovarsi: è questo il cuore della recitazione, un’arte fondamentale che oggi, travolta dalla pornografia dell’immagine, rischiamo di percepire come artefatta. Ma nei secoli è stata basilare: pensiamo alla poesia greca, al canto arcaico.
Federico García Lorca, nel “Gioco e teoria del duende”, dice che ogni parola possiede una forza intrinseca che il poeta deve saper trasmettere. E il duende, quello spiritello misterioso, si siede raramente sulla nostra spalla: porta con sé qualcosa di demoniaco, unico, e allo stesso tempo vicino alla divinità. Vive nella garganta, nella gola del cantante di flamenco o del poeta che recita. Oggi, purtroppo, abbiamo massacrato tutto con l’omologazione dei linguaggi: un’unica timbrica, un’unica emozione. Ma ogni persona è custode delle proprie differenze. Se imponiamo un solo colore a tutto, la parola perde la sua ragion d’essere».

Daniel Cundari, lei scrive in italiano, dialetto e spagnolo. Ogni lingua porta con sé un universo emotivo unico. Quale parte di lei emerge in ciascuna?
«Nel 2013 pubblicai un libro con Rubettino Editore dal titolo “Poesie contro me stesso”. È un trittico scritto in dialetto, italiano e spagnolo con una bellissima prefazione di Juan Carlos Friebe che appunto identifica nella mia poetica tre elementi. Il dialetto è la lingua dei nonni: del restare, del difendere, del sognare lucido. L’italiano è la lingua dei genitori, della scuola, della consapevolezza intellettuale. Lo spagnolo è la lingua dei figli: del viaggio, del lavoro all’estero, una lingua molto colorata, che si ricollega sempre agli altri due elementi. Negli ultimi anni mischio spesso queste tre lingue. Inoltre, utilizzo l’inglese, il francese, il greco e il latino, proprio per significare che la parola quando viene detta si disperde e diventa una cosa diversa, diventa suono, ma soprattutto melodia».
L’improvvisazione come verità: il suo “repentismo cutise” nasce dall’improvvisazione totale. Cosa scopre di sé stesso nei momenti in cui la parola sgorga senza rete, quasi come un atto involontario?
«De repente, all’improvviso. La poesia nasce, prende il volo, si dissolve… e smette di appartenere a chi l’ha generata. Spesso ci rinchiudiamo in schemi rigidi: etichettiamo, incaselliamo, cataloghiamo persone, opere, generi. Ma la vita cambia, cambia l’emozione, cambia il modo di dire, il modo di pensare. Anche le parole cambiano. Penso ad autori locali di straordinaria potenza, come Duonnu Pantu o alcuni scrittori della letteratura farsesca tra Settecento e Ottocento: i loro testi ci sono giunti attraverso l’oralità, spesso svincolati dall’idea originale del poeta che li aveva concepiti. È un esempio di come la parola viva, respiri e muta, senza mai fermarsi».
Daniel Cundari, ha tradotto anche numerosi testi, dico bene?
«Esatto! Ho tradotto tantissimo, da e verso lingue diverse. Nel mio primo libro, Cacagliùsi (balbuzienti), pubblicato a Roma nel 2005-2006, si possono trovare alcune di queste traduzioni».
Nei suoi spettacoli scompare il confine tra palco e platea. Che lavoro c’è dietro la capacità di trasformare ogni parola in esperienza condivisa?
«È come una partita a ping pong o a tennis. Io lancio la parola, qualcuno la rimanda. Ma per giocare bisogna allenarsi. C’è un lavoro quotidiano immane: linguistico, diaframmatico. C’è anche una follia, ma sempre guidata dallo studio. Il repentista si aggrappa ai ricordi, come facciamo tutti nella vita. Spesso, ci perdiamo in elucubrazioni mentali quando dobbiamo parlare di teatro, di letteratura che non hanno senso di esistere. E invece tutto risulta semplice se stiamo nella parola. Comanda sempre il libro, comanda sempre la lettura».

La sua poesia è carezza e denuncia. Come tiene insieme la rabbia e la tenerezza nello stesso testo?
«Roberto Bolaño scrive: “C’è un momento per fare a pugni e uno per fare poesia”. Forse questa è la risposta perfetta per la tua domanda. La poesia è una lotta tra opposti. Rabbia e dolcezza, arroganza e umiltà si mischiano fino quasi a non riconoscersi più. È una danza sull’orlo del cratere. Nel libro “Geografia feroce”, scritto in Spagna, racconto la condizione di chi costruisce qualcosa di bello sull’altra sponda del fiume, mentre dalla riva opposta un popolo con il martello in mano attende il momento di distruggere ciò che sta nascendo. Un’altra immagine che attraversa il libro è quella di una danza in equilibrio: corpi che si muovono sul filo, mentre mani invisibili cercano di afferrarti per farti cadere. È un equilibrio instabile. Il poeta deve essere un funambolo».
Ha collaborato con musicisti, attori, artisti visivi. Tra questi, anche Gianna Nannini..
«Esatto! Ci siamo conosciuti a Barcellona. In studio le ho fatto ascoltare qualcosa di mio e mi ha fatto registrare “Tu ragazzo nell’Europa”. È stata generosissima. Non mi ha mai chiesto di snaturarmi. Ho condiviso il palco con Francesco Loccisano, Peppe Servillo, Sasà Calabrese. Con Cesare Berlingeri ho un dialogo continuo. Dipingo molto, anche se non espongo. L’arte avvicina l’ego dell’artista sempre all’individualismo, alla solitudine, che sono importanti nel momento in cui si crea, però poi a un certo punto bisogna liberarsi anche da queste sovrastrutture e mettersi in contatto con gli altri affinché nasca qualcosa di creativo. A me piace dialogare persino con linguaggi come musica elettronica, musica tecno. È un progetto a cui sto lavorando».
Perché per gli artisti è così difficile far sentire la propria voce in Calabria?
«In Calabria bisognerebbe dare maggiore attenzione a scrittori e artisti, non solo dal punto di vista economico, ma anche offrendo spazi concreti. La programmazione culturale tende a privilegiare l’intrattenimento, che va bene, ma dimentica chi crea».
Su uno degli specchi presente nella libreria, ha scritto: «Non a Brooklyn né a Manhattan, ma a Cuti». Come mai?
«Dobbiamo capire che siamo in un paese, non a New York. Da qui, nasce la citazione. Quindi, occorre rispettare chi lo abita, rendendo l’arte fruibile attraverso un linguaggio semplice, comprensibile a chi la vive ogni giorno. Poi, certo, qui arrivano persone da tutto il mondo, soprattutto nei periodi estivi o durante le festività natalizie».
Nel mese di marzo, la Piccola Biblioteca di Cuti ospiterà un nuovo incontro. Daniel Cundari, può anticipare qualcosa?
«Sì, presenteremo il libro di un grande artista. Ci sarà Cesare Berlingeri, che considero il pittore più importante vivente della Calabria. Una persona di straordinaria umanità, che ha esposto in tutto il mondo e ha una formazione internazionale, ma ha deciso di tornare nella sua Taurianova. Oltre a essere pittore, è stato anche un grande scenografo».
Prossimi progetti? Potremo leggere presto nuove pubblicazioni?
«Prossimamente, pubblicherò due libri su cui lavoro da tempo. Testi accumulati negli anni e ora in fase di rifinitura. Nel frattempo, porto avanti i laboratori teatrali e continuo a far vivere la Piccola Biblioteca di Cuti».
Il Quotidiano del Sud.
Alla scoperta della Piccola Biblioteca di Cuti con il poeta Daniel Cundari