Arte e artisti nel panorama contemporaneo italiano. Parola ad Alessandra Franetovich
- Postato il 1 luglio 2025
- Arte Contemporanea
- Di Artribune
- 3 Visualizzazioni


Borsista di ricerca presso l’Università degli Studi di Firenze ma anche curatrice per Cripta747 (a Torino), co-docente presso NABA (a Milano) e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Verona. Alessandra Franetovich, che per le sue ricerche ha ricevuto borse di studio dalla Quadriennale di Roma, Regione Toscana, Garage Museum of Contemporary Arte V-A-C Foundation, Mosca, è stata anche la vincitrice nel 2020 del Premio Mosca per giovani curatori indetto dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero della Cultura. I suoi testi critici sono pubblicati in cataloghi oltre che sulle riviste e-flux Journal, Middle Plane, Cosmic Bulletin e Dune. E, data l’uscita del suo libro, L’arte italiana e il post 1989 Domeniche alla periferia dell’impero per Postmedia books, con il sostegno della Quadriennale di Roma, tramite la borsa di studio post-doc Panorama dell’arte del XXI Secolo, l’abbiamo incontrata per approfondirne in questo dialogo alcuni temi.
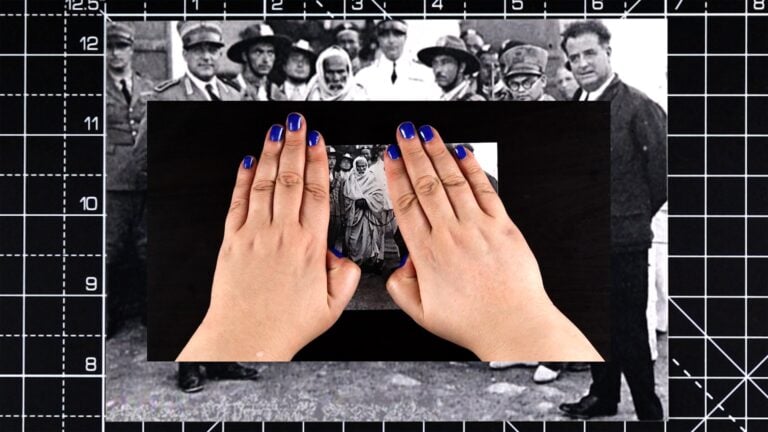 1 / 6
1 / 6
 2 / 6
2 / 6
 3 / 6
3 / 6
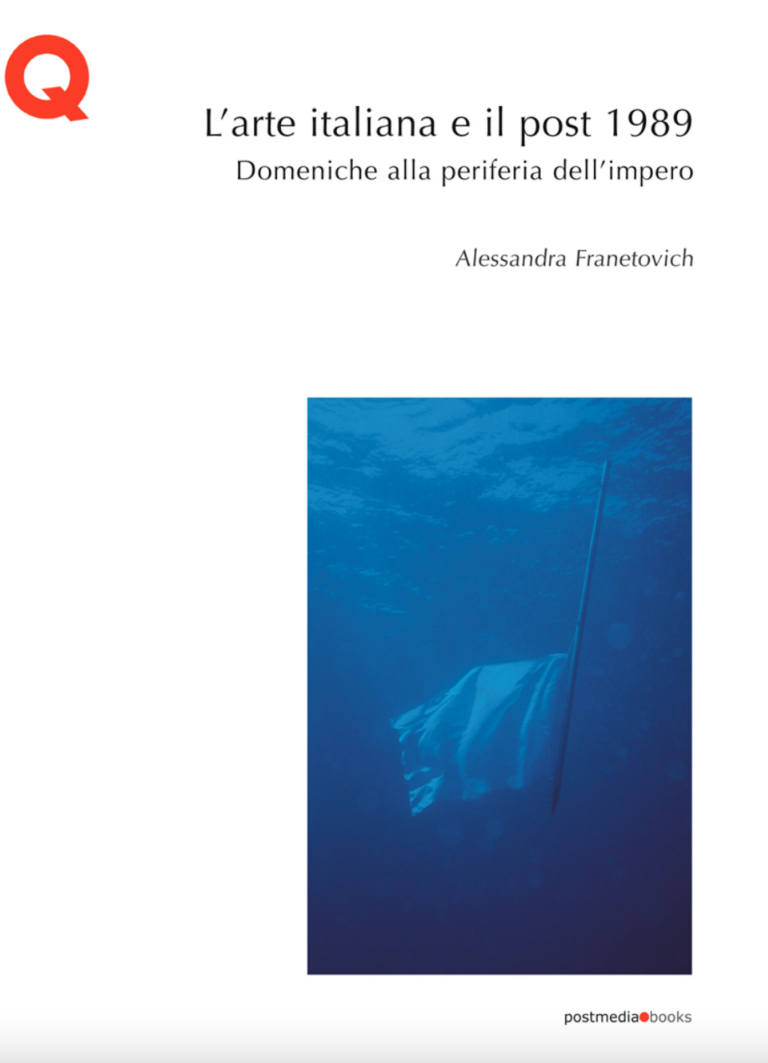 4 / 6
4 / 6
 5 / 6
5 / 6
 6 / 6
6 / 6






Intervista a Alessandra Franetovich
Nel suo libro l’immagine dell’arte italiana successiva al 1989 prende forma gradualmente, innanzitutto attraverso una considerazione sulla condizione dell’artista. Perché ha scelto di iniziare il suo studio da questo presupposto?
In uno scenario caratterizzato da uno stato di crisi politica, economica, sociale, apparentemente senza fine, il sistema dell’arte sembra contrarsi e affrontare un progressivo cambio di valori in favore del mercato, del temporaneo e del patinato. In questo contesto sono per lo più gli artisti a indicare con profondità le fratture, i luoghi problematici, le marginalità su cui soffermarsi e ripartire. Diversamente, le istituzioni arrivano dopo e solo a volte operano con sguardo etico, mentre altre volte attivano pratiche estrattive e di washing. Quindi gli artisti sono stretti nella morsa del precariato e di una visione culturale arretrata che ne permette lo sfruttamento e la quasi totale mancanza di potere, in un gioco asimmetrico che li vede sempre in attesa che qualcosa cambi.
Una visione precisa…
Visione da cui deriva, in parte, il titolo del libro, Domeniche alla periferia dell’impero, espressione con cui il compositore Fausto Romitelli descrive quest’attesa asfissiante che sta rovinando la scena artistica italiana, impoverendola non solo in termini materiali ma anche emotivi. L’impero è quello dell’omonimo e fondamentale libro di Michael Hardt e Antonio Negri che, già nel 2000, postulavano il ruolo del proletariato cognitivo. Guardando allo scenario italiano, alcuni artisti e lavoratori dell’arte hanno seriamente dedicato tempo ed energie a progetti che hanno contribuito alla costruzione di un sistema plurale e più equo. Basti pensare a progetti collettivi quali il Forum dell’arte contemporanea e AWI per non parlare degli spazi non profit che da decenni costituiscono un baluardo della produzione contemporanea.
Un tema altrettanto centrale è quello delle possibilità narrative, decisive affinché l’opera d’arte possa diventare anche “un catalizzatore eterogeneo per storytelling alternativi”. Tali possibilità come hanno influenzato le operazioni artistiche svolte in Italia?
Sul territorio italiano troviamo molti esempi di prassi artistiche attente alla narrazione e trovo interessanti quelle che si impegnano ad articolare storie alternative mostrando apertura a temi marginali o invisibili, a costruire spazi di pluralità. Ciò si pone in linea con la diffusione di prospettive critiche attivate da institutional critique, femminismo, discorso post-coloniale e post-1989. D’altra parte, nella scena nazionale questa prospettiva dimostra un radicamento del concetto di storia peculiare.
Ci può dire di più?
La storia è al centro della ricezione dell’arte anche da parte della popolazione italiana, come dimostra la disparità di interesse e investimenti sull’arte del passato rispetto a quella attuale. Tuttavia, è un tema che permette di aprire il discorso criticando le narrazioni ufficiali, favorendo il pensiero critico. Elisabetta Benassi e Francesco Arena operano un dialogo prioritario con vicende e figure della storia italiana. Rossella Biscotti e Alessandra Ferrini attivano fondamentali riletture della storia coloniale italiana. Ciò permette di fare luce su storie rimosse perché scomode, su cui è invece importante soffermarsi per comprendere i meccanismi tramite cui si attua la costruzione della storia. Ne è esempio Chiara Fumai, in cui il recupero di figure dal passato, in ottica femminista e trans-storica, ha riportato attenzione a questioni assolutamente urgenti quali la marginalizzazione sistematica della donna nella società e nella cultura contemporanea.
Oltre che visionaria e critica verso la storia e lo stato attuale di cultura e società, nella sua ottica l’arte italiana degli ultimi venticinque anni è anche innervata da una certa tendenza pessimista – animata da riflessioni sul fallimento, la crisi, la catastrofe, gli insuccessi delle relazioni umane. Questi approcci come influenzano le poetiche italiane che ha esaminato?
Credo che si possa parlare più di scetticismo, per la volontà di analizzare criticamente strutture costituite al fine di scardinarle e sostituirle con sentieri non battuti. Teresa Macrì ha raccontato quanto il fallimento sia endemico e quotidiano ma anche salvifico rispetto a dinamiche conservatrici, al conformismo di classe. Nello scenario nazionale poi esistono esempi che traggono dai fallimenti punti di osservazione, come mostrano Alterazioni Video con Incompiuto siciliano e le problematiche relative alla speculazione edilizia e agli ecomostri. Stefano Serretta, per esempio, con il suo lavoro unisce lo sguardo politicizzato e contro-culturale delle riviste Anni Settanta al dibattito attuale tra Alt-right e post-verità; mentre Giulio Saverio Rossi fonda la sua pratica pittorica in una rilettura critica e storico-artistica sull’estrattivismo delle risorse e delle terre rare.
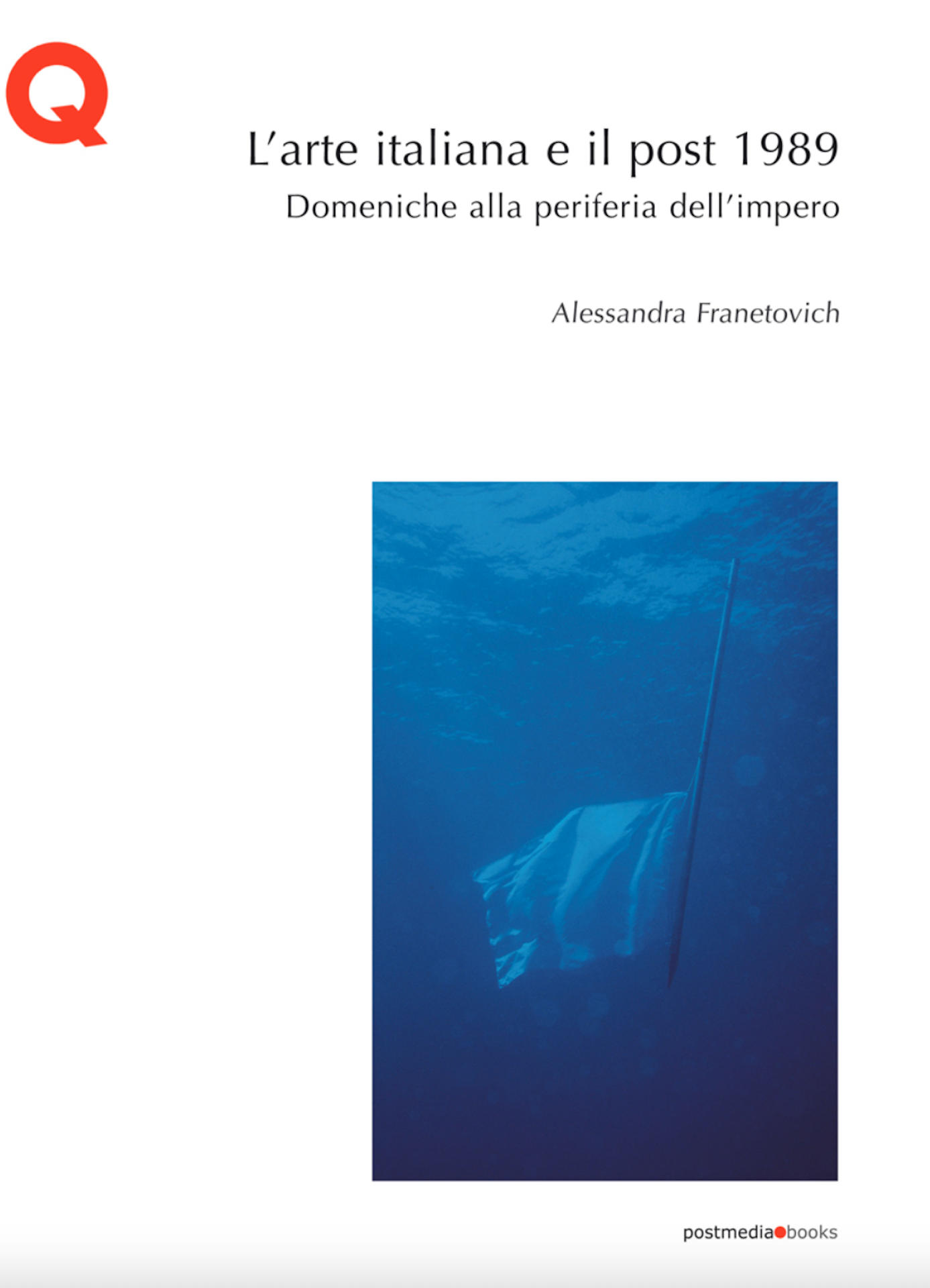
La seconda parte del libro offre un’immagine della rigenerazione delle contemporanee pratiche artistiche italiane in rapporto ai processi di auto-organizzazione e di produttività indipendente. Quali sono i principali risultati che hanno conseguito?
L’auto-organizzazione ha indubbiamente dato vita a forme di sostegno alla produzione delle generazioni più giovani sopperendo a gravi mancanze istituzionali. Questo è un problema enorme per la curatela trainata dal mercato, sempre più burocratica e priva di riflessione intellettuale. Nella estrema eterogeneità della scena no profit e indipendente auto-organizzata troviamo progetti radicalmente politici come Macao e Isola Art Center, altri votati alla produzione, tra cui Viafarini e Careof, Zingonia, Cherimus, Spazio GRIOT, Cripta747, i quali – con la loro esistenza e programmazione – possono essere interpretati come forme di resistenza. A ciò si aggiunge il ruolo fondamentale di istituzioni fondate da artisti, come Fondazione Baruchello e il PAV, promotrici di progetti in grado di parlare in maniera transgenerazionale, ricercando orizzontalità e favorendo produzione e pensiero seguendo formati non canonici.
Decisamente una panoramica dettagliata…
Penso sia fondamentale riconoscere ciò che questa costellazione di persone e luoghi ha permesso di costruire negli anni: progetti espositivi, circuiti di residenze, eventi di approfondimento, diventando punti di riferimento per la sperimentazione e spesso luogo di approdo per artisti impegnati nelle loro prime produzioni. Il circuito no profit è stato ed è ancora oggi seguito da gallerie e istituzioni, proprio perché è lì che sono accolte e sviluppate la maggior parte delle proposte artistiche in Italia.
Tenendo conto dei più recenti scenari geografico e culturale, quale direbbe sia oggi il profilo dell’artista contemporaneo in Italia?
Non credo esista un profilo cui fare riferimento ma l’esatto contrario. In questa complessità di visioni mi sembra ci sia sempre più spazio per lo sconfinamento tra discipline che, assieme a uno sguardo sul mondo attuale, può portare a operazioni complesse e sfidanti. Si potrebbe dire che la rivendicazione dell’agency da parte degli artisti sia uno dei tratti più identificativi del post-1989 in Italia. Penso che sarà sempre più importante il discorso critico attivato dalle seconde generazioni e realtà come Spazio GRIOT, che riesce a canalizzare il discorso in maniera strutturale; inoltre, sarà altrettanto influente l’apertura dei dottorati practice based in Italia.
Davide Dal Sasso
Libri consigliati:
(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)
Gli episodi precedenti
L’articolo "Arte e artisti nel panorama contemporaneo italiano. Parola ad Alessandra Franetovich" è apparso per la prima volta su Artribune®.




