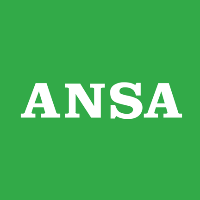Da Venezia al mondo: perché Casanova continua a essere il mito più moderno di sempre
- Postato il 1 novembre 2025
- Di Panorama
- 3 Visualizzazioni


C’è qualcosa di profondamente ironico nel celebrare Giacomo Casanova – uomo della fuga, dell’evasione, dell’instancabile peregrinare – con una mostra che si chiude il 2 novembre. Come se il tempo, quella dimensione che egli attraversò con l’urgenza del desiderio e la leggerezza del gioco, potesse essere contenuto tra le pareti di Palazzo Mocenigo, sia pure quelle sontuose del Centro Studi di Storia del Tessuto e del Costume. Eppure è proprio nella materialità degli abiti settecenteschi, nelle pieghe delle marsine e nei ricami dei gilè, che Venezia ha scelto di interrogare il mito del suo figlio più “scandaloso” per il tricentenario della nascita (1725-2025).
Casanova attraverso il linguaggio dei vestiti
La mostra veneziana – primo capitolo di un’indagine più ampia che la Fondazione Musei Civici dedica al celebre avventuriero – parte da una premessa intrigante: per comprendere Casanova non basta leggerne le imprese amorose o gli intrighi diplomatici. Bisogna capire come si vestiva, come si muoveva nello spazio sociale del suo secolo, quale linguaggio silenzioso parlava attraverso il panciotto e la calza di seta. Nel Settecento veneziano, l’apparenza era tutto, e nessuno incarnò questo principio con maggiore consapevolezza dell’autore della Storia della mia vita.
L’allestimento di Palazzo Mocenigo – che accosta prestiti dal Museo Stibbert di Firenze alle ricche collezioni proprie – restituisce la progressiva trasformazione dell’abbigliamento maschile nel secolo dei Lumi: da espressione di potere bruto a simbolo di raffinatezza, da ostentazione della forza a esibizione della cultura. Il completo di tre pezzi che si codifica in quegli anni – marsina, gilè e calzoni – rappresenta una rivoluzione silenziosa, l’abbandono delle ridondanze barocche in favore di un’eleganza che, paradossalmente, ancora oggi detta le regole del vestire maschile. È la nascita della modernità sartoriale, e Casanova ne fu insieme protagonista e profeta.
Casanova tra cinema e storia
Ma la mostra non si limita alla dimensione storica. Con un gesto curatoriale coraggioso, intreccia il Settecento veneziano con il suo doppio cinematografico: il Casanova di Federico Fellini del 1976, capolavoro straniante e visionario che trasformò il libertino in automa malinconico, la seduzione in meccanica del vuoto. È un cortocircuito temporale che illumina entrambe le epoche: Fellini, raccontando Casanova, racconta anche la fine di un’idea di virilità, il tramonto di un certo modo di abitare il desiderio. E la Venezia del regista riminese – ricostruita interamente a Cinecittà, città di cartapesta e specchi – diventa metafora perfetta di quella settecentesca: splendida, decadente, già fantasma di se stessa.
Del resto, la decadenza attraversa la biografia casanoviana come un basso continuo. L’evasione dai Piombi nel 1756 – impresa che lo rese celebre in tutta Europa – segnò anche l’inizio dell’esilio, il vagabondaggio attraverso corti e capitali che durò decenni. Conversatore brillante, giocatore d’azzardo, spia, occultista, militare: Casanova fu tutte queste cose insieme, e nessuna definitivamente. Incontrò Voltaire e Rousseau, frequentò Maria Teresa d’Austria e Federico di Prussia, ma finì i suoi giorni come bibliotecario nel castello boemo di Dux, scrivendo memorie che nessuno avrebbe pubblicato prima della sua morte.
Casanova nelle opere letterarie che lo raccontano
È questo Casanova crepuscolare che Arthur Schnitzler cattura con precisione chirurgica ne Il ritorno di Casanova, racconto del 1918 ambientato quando il seduttore ha cinquantatré anni – la stessa età che aveva Schnitzler scrivendolo. Il protagonista cerca disperatamente di rientrare a Venezia, si dibatte in una tenuta mantovana tra il corteggiamento respinto della giovane Marcolina e il duello mortale con il sottotenente Lorenzi. La notte di passione ottenuta con l’inganno, la spada che trafigge il rivale all’alba: sono gli ultimi fuochi di un fascino ormai spento, la presa di coscienza del «decadimento fisico e della scomparsa del fascino erotico». Schnitzler fa di Casanova una figura tragica, prigioniero della propria leggenda, condannato a recitare una parte che non gli appartiene più.
Matteo Strukul, nel suo Giacomo Casanova. La sonata dei cuori infranti, sceglie invece il momento dell’apogeo: la Venezia del 1755, quando il protagonista è ancora nel pieno delle forze e la Repubblica – benché prossima alla decadenza – conserva l’illusione della grandezza. Il romanzo intreccia avventura e ricostruzione storica, mescola personaggi reali (Tiepolo, Goldoni) e invenzione narrativa in un affresco che ricorda i meccanismi del feuilleton ottocentesco. Anche qui, però, la seduzione è insieme trionfo e trappola: Casanova si innamora davvero della bella Francesca Erizzo, finisce ai Piombi, scopre di essere stato pedina in un gioco di spie tra Venezia e l’Impero Austriaco.
La nuova biografia di Miklós Szentkuthy promette di restituire un Casanova meno cristallizzato nel mito: non solo uomo di corte e umanista, ma anche frequentatore di porti e taverne, figura complessa che attraversa tutti i registri sociali del suo tempo. È un approccio necessario, dopo decenni di riduzioni caricaturali che hanno fatto del seduttore veneziano poco più che un’icona da operetta.
L’eredità di Casanova
Perché Casanova continua a ossessionarci? Forse perché incarna un’idea di libertà – sessuale, intellettuale, esistenziale – che la modernità ha insieme esaltato e reso impossibile. O forse perché la sua vita, raccontata con quella «leggerezza» che Calvino avrebbe elevato a valore letterario, immortalò «un mondo che la Rivoluzione Francese avrebbe spazzato via». Un mondo in cui l’estetica era linguaggio imprescindibile, la visibilità unico mezzo per affermare il proprio ruolo sociale, e la seduzione non semplice conquista ma arte della conversazione, del gesto, della presenza.
La mostra di Palazzo Mocenigo chiude il 2 novembre. Ma Casanova – quello vero, quello delle memorie e dei travestimenti, delle fughe rocambolesche e dei fallimenti senili – continuerà a sfuggire a qualunque catalogazione. Come si conviene a chi fece dell’evasione non solo un’impresa, ma una filosofia di vita.