Gli anni 80 in nove dischi di culto
- Postato il 9 settembre 2025
- Blog
- Di Il Fatto Quotidiano
- 4 Visualizzazioni
.png)
Scegliere nove dischi per raccontare gli anni 80 significa accettare un rischio: quello di lasciare fuori capolavori che meriterebbero lo stesso posto. Un decennio esplosivo e contraddittorio, che ha prodotto musica di culto, fenomeni di massa e una quantità impressionante di album destinati a restare nella memoria collettiva. In questa selezione non c’è la pretesa di stabilire una classifica definitiva, ma l’intenzione di attraversare, attraverso nove titoli emblematici, un percorso tra ombre e luci, tra sperimentazione e icone. Nei consueti nove punti di questo blog, ecco dunque una rassegna di dischi che hanno segnato – e continuano a segnare – il tempo.
Cominciamo!
1. Bauhaus – In the Flat Field (1980)
Una dichiarazione di intenti radicale. La voce di Peter Murphy scava ferite, le chitarre di Daniel Ash lanciano fendenti che ancora oggi restano come avvisaglie. Qui prendono forma i contorni di un linguaggio in trasformazione, dove il gotico non è posa ma necessità viscerale, urgenza estetica e insieme fisica. Ogni brano vibra di tensione, ogni suono è una ferita aperta che diventa stile. Un album che non concede tregua, che trasforma l’ossessione in orizzonte. Più che un disco, un atto fondativo.
2. Killing Joke – Killing Joke (1980)
Un’esplosione, tra tribalismo e minaccia. Il debutto dei Killing Joke è feroce, spinto da un basso martellante e da una batteria che sembra un rituale apocalittico. Jaz Coleman non canta: invoca, denuncia, annuncia catastrofi sempre imminenti. Nessuna concessione, soltanto tensione pura. È un album che trasforma la rabbia in disciplina, la paranoia in ritmo. Una lezione di politica e visione che continua a risuonare attuale come allora.
3. The Cure – Seventeen Seconds (1980)
È in atto la costruzione di un mondo sospeso. Quello dei Cure. Brani minimali, atmosfere dilatate, silenzi che pesano quanto le note. Robert Smith scrive un diario di ombre e fragilità, restituendo un disco che non ha paura di essere essenziale. In trentacinque minuti inventa un linguaggio malinconico che influenzerà generazioni. Un lavoro che più che un album sembra una stanza vuota da attraversare.
4. The Sound – From the Lion’s Mouth (1981)
Adrian Borland e i suoi Sound hanno inciso un album che alterna ferocia e dolcezza, rabbia e intimità. Dentro c’è tutto: inni epici, confessioni brucianti, una tensione emotiva che non si placa. I Sound non hanno mai avuto il riconoscimento che meritavano, eppure ascoltare questo disco significa capire che il post-punk non fu solo stile ma carne viva. È un grido che vibra ancora, lontano dalle luci dei riflettori.
5. Siouxsie and the Banshees – Juju (1981)
Siouxsie Sioux domina con una voce che è insieme rito e arma, un magnete capace di trasformare ogni parola in evocazione. John McGeoch reinventa la chitarra con suoni che ancora oggi sembrano provenire da un altrove, frutto di un’architettura sonora che segna uno spartiacque. Tra oscurità tribale e raffinatezza pop, rituale e melodia; un equilibrio unico e difficilmente imitabile. Ogni brano è un sortilegio, e “Spellbound” resta un classico che continua a stregare, come un incantesimo perfetto.
6. Dead Can Dance – Spleen and Ideal (1985)
Lisa Gerrard e Brendan Perry cancellano i confini tra generi e costruiscono un linguaggio senza tempo. Spleen and Ideal unisce Medioevo e avanguardia, malinconia e tensione spirituale. Non è rock, non è classico, non è folk: ma che cos’è? Un miracolo, una magia, meglio ancora, un capolavoro assoluto. La voce di Lisa sembra provenire da un’altra dimensione, pura e ipnotica, mentre Brendan erige architetture sonore solenni, stratificate, di una gravità che inchioda. Non è un disco che si lascia ascoltare: pretende immersione totale, trasformando ogni brano in esperienza metafisica.
7. The Cult – Love (1985)
Un rito mistico orchestrato magicamente: Ian Astbury predica con voce febbrile, Billy Duffy intreccia riff che diventano mantra elettrici. È un album in cui convivono romanticismo decadente e furia tribale, dove la sensualità incontra la psichedelia e l’oscurità si apre a visioni luminose. Love non è soltanto rock: è un manifesto oscuro e luminoso che eleva i Cult a band capace di incarnare un immaginario potente e riconoscibile, destinato a imprimersi nella memoria collettiva degli anni Ottanta.
8. The Sisters of Mercy – First and Last and Always (1985)
Un requiem elettrico che si erge come una cattedrale gotica. Andrew Eldritch intona con voce cavernosa, Gary Marx e Wayne Hussey intrecciano chitarre che diventano muri solenni, mentre Craig Adams scolpisce linee di basso scure e implacabili. A scandire il tempo c’è il Doktor Avalanche, drum machine elevata a liturgia. First and Last and Always è un’opera irripetibile, destinata a restare isolata e proprio per questo mitica: l’inizio e la fine di un’epoca compressi in un unico, monumentale testamento.
9. Depeche Mode – Music for the Masses (1987)
Un titolo ironico che nasconde una verità: i Depeche Mode non hanno mai scritto pensando davvero alle masse, eppure con questo album conquistano il mondo. Le atmosfere cupe richiamano il disco precedente, ma qui i suoni si fanno più stratificati, la scrittura più teatrale, la visione più ampia. È un lavoro che segna la maturità definitiva della band, trasformando l’elettronica in epica e portando i Depeche oltre il culto per farne una delle voci simbolo della musica contemporanea.
Come sempre, questo spazio si chiude con una connessione musicale: una playlist dedicata, disponibile gratuitamente sul mio canale Spotify — la trovi qui sotto. Se ti va di dire la tua, puoi farlo nei commenti o passare dalla mia pagina pubblica su Facebook, collegata a questo blog: lì il confronto continua tra post, scambi e nuove suggestioni. E fidati: da quelle parti, se ne leggono e se ne sentono delle belle.
9 canzoni 9 … dei miei anni 80
L'articolo Gli anni 80 in nove dischi di culto proviene da Il Fatto Quotidiano.

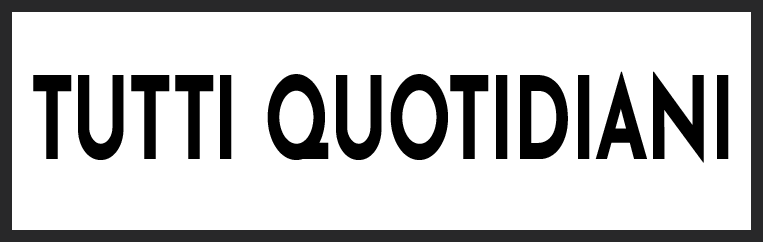
.png)