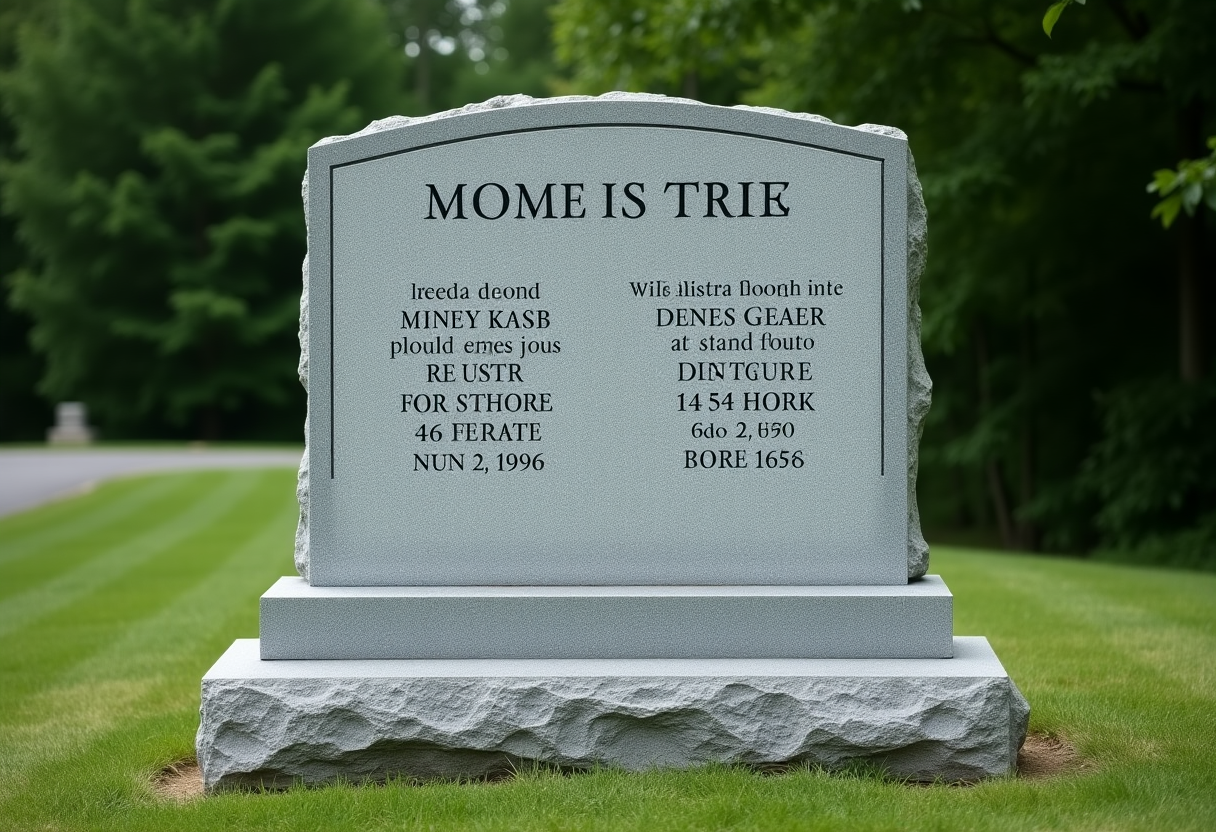Il Dna di due mummie di 7.000 anni fa riscrive la storia dell’uomo di Neanderthal: “Scoperta una popolazione umana finora sconosciuta, geneticamente distinta”
- Postato il 29 aprile 2025
- Cultura
- Di Il Fatto Quotidiano
- 1 Visualizzazioni
.png)
Un tassello mancante nel complesso puzzle della Storia umana è stato finalmente ritrovato, sepolto per millenni sotto la sabbia di quello che un tempo era un Sahara lussureggiante. L’analisi del Dna estratto dai resti scheletrici di due donne, vissute circa 7.000 anni fa e scoperte nel rifugio roccioso di Takarkori, nella Libia sudoccidentale, ha rivelato l’esistenza di una popolazione umana finora sconosciuta, geneticamente distinta e rimasta sorprendentemente isolata per lungo tempo.
La scoperta, frutto del lavoro dei ricercatori del prestigioso Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia, in Germania, e pubblicata sulla rivista scientifica Nature, sfida le precedenti ipotesi sulla storia del popolamento del Nord Africa durante il periodo del cosiddetto “Sahara Verde”. Tra 14.500 e 5.000 anni fa, infatti, questa vasta regione oggi desertica era un ambiente fertile, ricco di acqua ed erba, condizioni che gli scienziati ritenevano avessero favorito intensi scambi e mescolanze tra le popolazioni locali e i gruppi umani in arrivo dall’Africa subsahariana e dal Medio Oriente.
La scoperta che ribalta le teorie
I risultati genetici delle mummie di Takarkori raccontano però una storia diversa. Invece di mostrare un mix di ascendenze africane, mediorientali ed europee, il loro Dna rivela uno stretto legame genetico con un gruppo molto più antico di cacciatori-raccoglitori che vivevano in grotte nell’attuale Marocco circa 15.000 anni fa, durante l’ultima Era Glaciale. Sia questo gruppo dell’Era Glaciale che le donne di Takarkori possiedono un patrimonio genetico completamente differente da quello degli africani subsahariani contemporanei. “La nostra ricerca sfida le precedenti ipotesi sulla storia della popolazione nordafricana e mette in evidenza l’esistenza di una stirpe genetica profondamente radicata e isolata a lungo”, afferma Nada Salem, ricercatrice del Max Planck Institute e prima autrice dello studio. Questo isolamento è particolarmente sorprendente, considerando che proprio 7.000-8.000 anni fa nel Sahara si diffondevano le prime pratiche di pastorizia, probabilmente introdotte da popolazioni provenienti dal Medio Oriente.
Poco DNA Neanderthal
Un altro dato significativo emerso dall’analisi è la scarsa presenza di Dna Neanderthal nelle mummie di Takarkori, molto inferiore rispetto all’1-2% tipicamente riscontrato negli esseri umani vissuti al di fuori dell’Africa (come gli agricoltori mediorientali) nello stesso periodo. Questo rafforza l’idea di un prolungato isolamento di questa popolazione nordafricana ancestrale. Questi risultati suggeriscono che la diffusione delle prime pratiche agricole e di pastorizia nel Sahara Verde sia avvenuta principalmente attraverso la diffusione culturale (un gruppo che insegna le tecniche a un altro) piuttosto che tramite migrazioni di massa e sostituzione della popolazione locale da parte degli agricoltori mediorientali (la cosiddetta “migration theory”). Le idee e le tecniche si sono diffuse perché pratiche e vantaggiose in quell’ambiente fertile, ma i contatti e gli incroci tra le diverse popolazioni sono stati molto più limitati di quanto si pensasse.
Un patrimonio genetico tutt’oggi vivo
Sebbene questa antica e unica linea genetica non esista più nella sua forma originaria, i ricercatori sottolineano che la sua “ascendenza è ancora una componente genetica centrale delle attuali popolazioni nordafricane, evidenziando la loro eredità unica”. Le donne di Takarkori, con il loro Dna sorprendente, ci raccontano quindi non solo una nuova pagina della preistoria umana, ma anche un pezzo delle radici profonde delle popolazioni che oggi abitano il Nord Africa.
Foto d’archivio
L'articolo Il Dna di due mummie di 7.000 anni fa riscrive la storia dell’uomo di Neanderthal: “Scoperta una popolazione umana finora sconosciuta, geneticamente distinta” proviene da Il Fatto Quotidiano.


.png)