Non solo conservazione, ecco come la natura si può restaurare (rilanciando l’economia)
- Postato il 22 aprile 2025
- Ambiente
- Di Il Fatto Quotidiano
- 3 Visualizzazioni
.png)
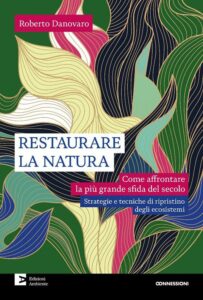
Non solo combattere l’inquinamento, giusto slogan degli anni Settanta; non solo salvare, conservare, proteggere, obiettivi principali degli anni Ottanta e Novanta. La natura ha bisogno anche di altro e cioè di essere “restaurata”, “ri-generata”, una consapevolezza che esiste dal primo decennio di questo millennio. D’altronde, se l’azione umana ha già impattato significativamente sul 75% delle terre emerse e sul 66% di quelle marine, sostenere la natura significa anche “aiutarla a riprendersi, restituirle quelle che sono le sue strutture e funzioni”, come spiega Roberto Danovaro, docente di ecologia all’Università Politecnica delle Marche e presidente della Fondazione Patto con il Mare per la Terra, in un importante libro frutto di un decennio di ricerche, “Restaurare la natura. La più grande sfida del secolo” (Edizioni Ambiente).
D’altronde, molti ambienti “sono ormai talmente danneggiati da rendere impossibile o troppo lento un recupero senza l’intervento umano: richiedono, invece, azioni di restauro attivo”. La soluzione esiste e si chiama restauro ecologico, una disciplina capace di integrare l’ecologia con le scienze sociali ed economiche.
Tutti i danni da sfruttamento eccessivo delle risorse – La causa principale della perdita di molti habitat in ambito terrestre è la produzione di cibo: oltre l’85% delle 28.000 specie a rischio di estinzione immediata è minacciato dall’espansione dei campi agricoli e dall’uso di pesticidi. Per quanto riguarda gli ambienti marini, nota l’ecologo, il problema è altrettanto grande, anche se meno visibile. Tra tutte le attività umane, la pesca a strascico è la più dannosa. E poi ci sono le specie aliene, una delle nuove minacce alla biodiversità, responsabili di oltre il 60% delle estinzioni di specie terrestri con cui entrano in conflitto.
Le normative per il ripristino, globali ed europee – Nella Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità è stato approvato nel 2022 il Global biodiversity framework, che prevede 23 target specifici, tra cui quelli che richiedono il raggiungimento, entro il 2030, della conservazione del 30% delle terre emerse, delle acque dolci e degli oceani, e il restauro del 30% degli ecosistemi degradati terrestri, marini e di acqua dolce (in particolare, prevede 350 milioni di ettari di superficie da recuperare entro il 2030).
Inoltre, è stato lanciato dalle Nazioni Unite il decennio del “Restauro degli ecosistemi” 2021-2030 e, in tutti gli ambiti internazionali, si parla della teoria e della pratica delle cosiddette “soluzioni basate sulla natura“(nature-based solutions). L’Unione Europea in particolare, con il regolamento Nature Restauration Law approvato nel 2024, prevede di ripristinare almeno il 20% degli ecosistemi degradati entro il 2030, per poi giungere al 90% nel 2050. Si tratta però, nota l’autore, di una sfida molto complessa, “perché restaurare gli ecosistemi degradati richiede molte competenze e spesso tempi lunghi, proprio come avviene quando si deve curare un paziente affetto da molte patologie croniche”.
Gli ostacoli al restauro – Particolarmente difficile, è quantificare in quale percentuale un restauro ecologico abbia recuperato rispetto all’habitat perso: il risanamento degli ecosistemi deve essere valutato con appositi indicatori e rispetto a traguardi chiari, predefiniti e misurabili. Ci sono anche (pochissimi) casi di fallimento dell’azione di restauro, conclusisi, spiega Danovaro, con la perdita completa delle specie reintrodotte, ma si tratta di una percentuale inferiore al 5%.
In ambito terrestre, il restauro degli ecosistemi dovrebbe essere effettuato su aree vaste, ma questo appare non necessario in ambiente marino. Tuttavia, si dovrebbero privilegiare gli ambienti che potrebbero soffrire in misura minore dei cambiamenti climatici, in modo tale che possano offrire protezione a determinati organismi.
Il restauro? È sempre un guadagno economico – I benefici del restauro tuttavia sono immensi. Aumentando gli sforzi di restauro e protezione degli ecosistemi come foreste, torbiere e zone umide, che rappresentano depositi di carbonio significativi a livello globale, si potrebbero ridurre del 40% i livelli di CO2. Restaurare solo il 15% degli ecosistemi degradati ridurrebbe del 60% la perdita di specie.
Ci sono poi i ritorni economici che possono stimolare una nuova forma di economia rigenerativa. Basti pensare che il 60 % del prodotto interno lordo a livello globale deriva dal semplice utilizzo delle risorse ambientali. Ogni investimento nel restauro potrebbe garantire un ritorno economico da 1,7 sino a 30 volte maggiore. Alcuni esempi? Le iniziative per il restauro delle barriere coralline in Indonesia – secondo i dati forniti dall’Unep – sono in grado di restituire 2,5-2,6 miliardi di dollari all’anno in termini ecosistemici e di benefici. Un altro esempio: attraverso il restauro delle foreste a mangrovie si potrebbe far crescere l’abbondanza di pesci e di invertebrati fino a un valore commerciale di 60 trilioni (migliaia di miliardi). Ancora: il restauro degli ambienti umidi in aree a rischio elevato – per esempio, molte zone costiere negli Stati Uniti – potrebbe invece determinare un risparmio di 18,2 miliardi di dollari sui danni causati dai fenomeni climatici estremi.
Le soluzioni naturali hanno un duplice vantaggio: da un lato sono più efficienti, poiché la natura ha evoluto questi sistemi con adattamenti di straordinaria efficacia. Dall’altro, si automantengono, a differenza delle opere totalmente artificiali.
Se il restauro porta pace – Ma secondo l’autore il restauro ha anche una valenza sociale, politica e culturale. Crea un ponte tra scienziati, decisori politici, imprese, mondo legislativo e governi, insieme al mondo del volontariato, perché “presuppone una simbiosi tra competenze fondamentali ed esperienza pratica, capace di valorizzare anche la cultura ecologica tradizionale e quella locale”. Fondamentale infatti è il coinvolgimento della popolazione locale e dei cittadini.
Ma c’è di più: ogni investimento nel risanamento degli ecosistemi, infatti, contribuisce alla risoluzione dei conflitti, poiché́ l’erosione delle risorse naturali – soprattutto nelle aree geografiche caratterizzate da una situazione geopolitica complessa – si lega a un’acutizzazione delle guerre e alla spinta all’emigrazione. Il restauro degli ecosistemi “è quindi uno strumento di costruzione della pace”, afferma Danovaro. Infine, una natura sana previene un quarto delle malattie a livello globale, e fornisce degli spazi naturali nei quali possiamo abbassare i nostri livelli di stress, e raggiungere numerosi obiettivi di tipo relazionale.
Un capovolgimento concettuale: “yes in my backyard” – Ma come si restaura la natura? Tre, secondo il libro, sono gli approcci. Il primo prevede la costruzione di strutture artificiali che permettano agli organismi di ricolonizzare ambienti degradatati, il secondo prevede il miglioramento delle condizioni ambientali in cui crescono gli organismi, il terzo, quello biologico, consiste di solito nella raccolta di organismi da un ambiente sano/integro e nel loro trapianto in un ambiente degradato. Alcuni esempi: il restauro delle barriere coralline impiega il giardinaggio dei coralli (coral gardening) e la ricollocazione nell’ambiente da restaurare degli organismi cresciuti.
Altre iniziative in corso sono: la Bonn challenge, che ha come obiettivo principale il restauro di almeno 350 milioni di ettari di foreste e di ambienti terrestri entro il 2030; la Great green wall initiative, che ha come obiettivo il recupero di 100 milioni di ettari di territorio desertificato dell’Africa, per bloccare l’avanzata del deserto. Esiste poi la Global peatlands initiative, ovvero un progetto internazionale volto al recupero degli ambienti di torbiera e alla loro gestione sostenibile. Ma i progetti ormai sono tantissimi e sparsi per il mondo.
“Il restauro della natura”, conclude l’autore, “non può essere visto né come qualcosa di destra né di sinistra, esattamente come la cura della nostra salute, per cui non ci dovrebbe essere nessun partito pregiudizialmente contro”. Si rovescia in qualche modo il principio del “not in my backyard”, ovvero “non nel mio giardino” al contrario, si tratta di interventi che tutti vorrebbero nel proprio territorio perché ne aumentano il valore. “L’idea della natura da ricreare è un passaggio concettuale radicale, che supera quella più passiva, e a volta non efficace abbastanza, della protezione e della conservazione”.
L'articolo Non solo conservazione, ecco come la natura si può restaurare (rilanciando l’economia) proviene da Il Fatto Quotidiano.


.png)
