Volontariato o spettacolo dell’ego? Attenti al boom estivo dei giovani che vanno a ‘fare del bene’
- Postato il 26 luglio 2025
- Blog
- Di Il Fatto Quotidiano
- 3 Visualizzazioni
.png)
In un’epoca segnata da crisi globali, tagli alla cooperazione e derive populiste, la solidarietà internazionale dovrebbe essere più urgente, più radicale e più trasformativa che mai. Eppure, molte iniziative di volontariato sembrano oggi allontanarsi da questi ideali. Al contrario: sempre più spesso si trasformano in palcoscenici dove a dominare non è la giustizia sociale, ma l’ego del volontario. Tra white saviourism, volunturismo e capitalismo emozionale, il volontariato rischia di diventare uno spettacolo narcisista, più attento alla narrazione del “io ho aiutato” che all’impatto reale sulle comunità coinvolte. Il medico e cooperante Iñaki Alegría, su El País nel luglio 2025 nell’articolo “El negocio de sentirse bien en verano”, spiega come si stia assistendo a un vero e proprio boom del volontariato estivo, spesso senza alcuna formazione adeguata, soprattutto in ambito medico.
Giovani provenienti dal Nord globale si recano in Paesi impoveriti per “fare del bene”, con risultati talvolta disastrosi: sistemi sanitari locali interferiti, comunità trattate come oggetti esotici da fotografare, bambini trasformati in protagonisti inconsapevoli di contenuti social destinati al consumo online. A rafforzare questa critica, la giornalista Martina Merlino, sempre su El País nel 2021, già metteva a fuoco un’altra dimensione: quella delle narrazioni. Nell’articolo “¿Por qué los blancos siempre tienen que ser los protagonistas de la historia?”, Merlino denunciava come la comunicazione umanitaria mainstream insista nel rappresentare l’operatore bianco come eroe, mentre le persone locali vengono sistematicamente marginalizzate, ridotte a comparse passive. Una narrazione tossica che perpetua gerarchie coloniali e rafforza un’idea di superiorità culturale mai davvero decostruita.
Il problema non è nuovo. Già nel 2018, il giornalista Martín Caparrós parlava di volunturismo come “turismo emozionale” che muove milioni di euro, in cui l’obiettivo non è il cambiamento sistemico, ma la costruzione di una biografia personale “impegnata” da esibire sui social e nei colloqui di lavoro. Una logica che riduce la solidarietà a consumo, le comunità a scenario, e la giustizia a sentimento individuale.
Tuttavia, la trasformazione è possibile. Lo dimostrano realtà che stanno costruendo modelli nuovi, decoloniali, partecipativi e femministi. Tra queste, spicca Acápacá, piattaforma latinoamericana che lavora per la trasformazione delle pratiche di cooperazione internazionale. Attraverso ricerca, formazione, e il Foro Permanente Latinoamericano para la Decolonización de la Cooperación, Acápacá promuove un approccio basato su giustizia, corresponsabilità e riconoscimento dei saperi e delle leadership locali. Niente più “aiutare gli altri”: si tratta piuttosto di costruire insieme, in ascolto reciproco, rompendo le asimmetrie storiche.
Un altro esempio virtuoso viene dalla Norvegia, con la famosa campagna Radi-Aid dell’ong SAIH. Il loro video virale “African for Norway”, in cui giovani africani mandano aiuti invernali ai poveri norvegesi “che soffrono per il freddo”, capovolge i ruoli e svela l’assurdità delle narrazioni salvifiche occidentali. Ironico, potente, educativo. Un invito a ridefinire i codici della comunicazione, per raccontare la cooperazione non come missione individuale, ma come relazione orizzontale.
Ma come si costruisce, allora, un volontariato decoloniale? La chiave sta, innanzitutto, nello spostare il centro. Non siamo noi i protagonisti. Il volontariato non è un atto di eroismo, ma un processo collettivo di apprendimento, di accompagnamento, di costruzione di legami. Richiede formazione reale, conoscenza dei contesti, capacità di lavorare in équipe con attori locali. Soprattutto nei contesti fragili o complessi – come quelli segnati da povertà strutturale, conflitti o esclusione storica – improvvisarsi è pericoloso.
Non basta “la buona volontà”: servono competenze specifiche, formazione settoriale, etica della cura e capacità di analisi critica. La professionalizzazione non è in contraddizione con l’impegno solidale: al contrario, è ciò che permette di moltiplicare l’impatto ed evitare danni involontari. E poi, è davvero necessario viaggiare per migliaia di chilometri per “fare la differenza”? In molti casi, no. Ciò che spesso viene ignorato – anche perché meno “instagrammabile” – è che la solidarietà comincia da vicino. Nei quartieri delle nostre città, nelle campagne italiane, nei piccoli centri urbani, esistono decine di iniziative che lavorano quotidianamente per l’inclusione, la giustizia sociale, il sostegno ai più vulnerabili. Progetti di mutuo appoggio, supporto alle persone migranti, cura delle persone anziane, educazione popolare, lotta alla povertà. Serve quindi ripensare anche il dove e il perché del nostro impegno perché la vera trasformazione può non aver bisogno di migliaia di chilometri, né di applausi digitali, ma di tempo, di relazioni, di ascolto.
Perché in fondo, la vera solidarietà non nasce dal bisogno di sentirsi buoni, ma dalla volontà di mettere in discussione il proprio privilegio, fare spazio, accompagnare senza invadere. È una pratica esigente, ma profondamente necessaria, in un mondo che ha bisogno di relazioni nuove, non di vecchie carità in abiti moderni.
Se vogliamo che il volontariato sia davvero una leva di cambiamento – e non l’ennesima espressione del capitalismo dell’ego – è tempo di rivedere linguaggi, posture, intenzioni. Ripartendo non da chi “aiuta”, ma da chi ogni giorno, anche vicino a noi, costruisce giustizia, dignità e comunità.
L'articolo Volontariato o spettacolo dell’ego? Attenti al boom estivo dei giovani che vanno a ‘fare del bene’ proviene da Il Fatto Quotidiano.

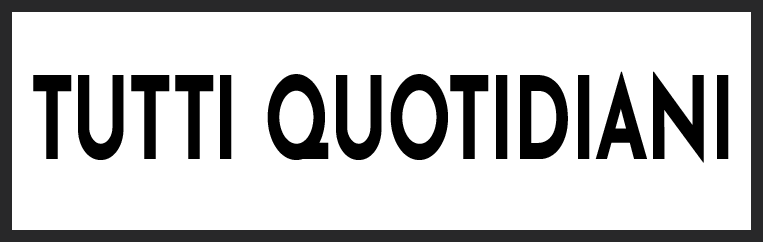
.png)
