Querele intimidatorie e minacce legali: è lecito usare il diritto per far tacere chi denuncia violenza?
- Postato il 25 novembre 2025
- Blog
- Di Il Fatto Quotidiano
- 2 Visualizzazioni
.png)
Se nel Medioevo alle donne veniva imposta la mordacchia, oggi ci sono strumenti più sofisticati contro le donne che svelano, parlano, prendono posizione pubblica contro la violenza sessista: cause legali minacciose, intimidazioni giudiziarie e attacchi mediatici. A finire nel mirino non sono solo le vittime di violenza e attiviste femministe, ma anche operatrici dei centri antiviolenza e giornaliste che raccontano la vittimizzazione istituzionale delle donne. A volte ci sono giornaliste che vengono condannare in cause civili per diffamazione, anche se quanto hanno scritto era basato su documenti ufficiali e si trasforma la verità in un’imputata.
È lecito usare il diritto per soffocare la voce di chi denuncia violenza? La legge serve a proteggere le persone dalla calunnia, certo. Ma le vittime devono poter parlare, denunciare pubblicamente ciò che hanno subito, senza il rischio di essere trascinate in tribunale.
In Italia cresce il rischio di Slapp – Strategic Lawsuits Against Public Participation – cause legali strategiche contro chi partecipa al dibattito pubblico sul tema della violenza maschile contro le donne. Sono strumenti di intimidazione pensati per zittire chi denuncia abusi, chi si espone, chi osa rompere il silenzio. L’obiettivo è chiaro: riportare le donne al silenzio.
Il backlash preannunciato da Susan Faludi nel 1991 è qui ed è evidente. Minacce legali, pressioni di potere, violenza istituzionale: tutto per impedire alle donne di parlare. Il movimento #MeToo del 2017, che portò milioni di donne a denunciare pubblicamente violenze e molestie superando i confini geografici negli Usa e culminò nella condanna del produttore Harvey Weinstein a 24 anni di carcere, dimostrò quanto la solidarietà e la visibilità possano fare la differenza. Ma oggi, lo stesso sostegno allo svelamento delle vittime sarebbe garantito?
Recentemente, alcune operatrici dei centri antiviolenza sono state denunciate per testimonianze rese in aula durante processi per violenza. La Procura ha archiviato, ma il danno è stato fatto: stress, intimidazione. Altri casi vedono uomini imputati per violenza inviare minacce legali tramite i propri avvocati a chi aveva semplicemente svolto il proprio lavoro: relazioni inviate ai servizi sociali o alle forze dell’ordine sulle donne accolte nei centri. Tutto finisce spesso nel nulla, ma intanto il centro perde tempo e risorse preziose, e le operatrici vengono logorate psicologicamente.
E se da una parte c’è lo Slapp, dall’altra ci sono continue aggressioni digitali alle pagine social dei Centri antiviolenza, che a volte si amplificano con shitstorm organizzate, fatte spesso da profili fake che scagliano insulti e minacce. Gli aggressori attaccano le pagine social dei centri antiviolenza, prendendo di mira le operatrici e le sopravvissute con campagne coordinate di umiliazione e di intimidazione. A volte, gli autori di violenza le cui compagne sono state ospitate nelle case rifugio lanciano accuse pubbliche, volte a diffamare l’operato dei Centri antiviolenza con l’accusa di sottrazione di minore. Accuse alle quali le rappresentanti dei Centri antiviolenza difficilmente possono replicare, sia perché sono tenute alla riservatezza su quanto viene svelato nel Centro antiviolenza, sia perché difendersi potrebbe dire esporsi al rischio di denuncia per diffamazione.
Un caso emblematico che rispecchia la situazione che ho appena descritto è quella capitata dell’attivista croata Tölle, condannata per aver diffamato il marito di una donna accolta nel suo centro antiviolenza. Tolle aveva respinto pubblicamente le accuse dell’uomo (di aver sottratto la figlia) spiegando i motivi per cui il centro antiviolenza aveva accolto la donna e la minore. La Corte Europea dei Diritti Umani riconobbe la querela fatta dall’uomo come azione legale intimidatoria. Non si trattò di un normale processo, ma dell’uso distorto del diritto per silenziare chi difende le donne. Lo Stato croato fu condannato a risarcire l’attivista.
Quanto alle vittime di violenza, il passo da sopravvissute a imputate può essere brevissimo. Il rapporto Da sopravvissuta a imputata, pubblicato da Index on Censorship, conferma la tendenza: in Regno Unito e Irlanda, le sopravvissute alla violenza sessuale sono sempre più spesso bersaglio di minacce legali, citazioni in giudizio e intimidazioni da parte di studi legali, solo per aver raccontato la propria esperienza.
In Italia, donne che denunciano violenza istituzionale sui social o pubblicamente possono subire lo stesso trattamento: accuse di diffamazione, cause civili, processi infiniti. Come osserva Elena Biaggioni: “Quello che non si vuole vedere è la disparità di potere. Tutte le donne che parlano di violenza sanno che prima o poi dovranno affrontare il timore di una denuncia. Sono forme di intimidazione che funzionano. Investono anche i Centri antiviolenza. Sono le parole dei bulli che diventano legge.”
È un paradosso inquietante: denunciare la violenza e trovarsi nuovamente colpite dalla violenza stessa, questa volta sotto forma di diritto piegato al potere. È ora di affrontare questa problematica perché la legge non può diventare un’arma contro chi denuncia violenze, né in aula di tribunale, né sui social.
L'articolo Querele intimidatorie e minacce legali: è lecito usare il diritto per far tacere chi denuncia violenza? proviene da Il Fatto Quotidiano.

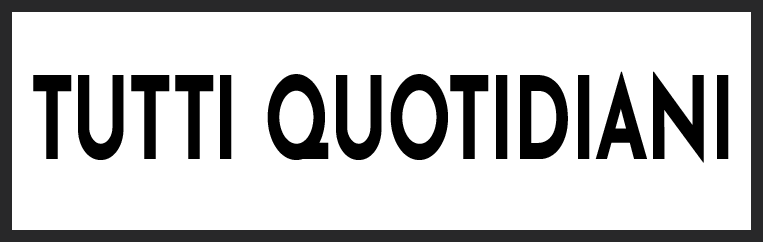
.png)