Cosa significa davvero ‘modello Milano’ e perché non ha più senso parlarne
- Postato il 4 agosto 2025
- Blog
- Di Il Fatto Quotidiano
- 1 Visualizzazioni
.png)
Il drammatico momento di difficoltà che sta caratterizzando la vita politica meneghina spinge molti commentatori e colleghi giornalisti a parlare del declino del “modello Milano”. Sul fronte opposto c’è chi invece lo difende, nella solita diatriba tra quelli che Umberto Eco chiamava apocalittici e integrati (mutatis mutandis). A prescindere dalla posizione in merito, siamo sicuri si parlare davvero della stessa cosa? Che cosa si intende con “modello Milano”?
Agli albori dell’inchiesta sull’urbanistica, andava più di moda l’espressione “rito ambrosiano”, caratterizzata da un’accezione altrettanto negativa, ma più circoscritta: si riferiva precisamente agli interventi edilizi fatti con una semplice SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e non con un iter più complesso, che passa per il piano attuativo. Per il Comune è un modo di snellire la burocrazia, per gli inquirenti è una violazione di legge.
Stabilirà il tribunale chi ha ragione, ma passare dagli strali sul “rito ambrosiano” a quelli sul “modello Milano” non è un giochino semantico. Così si è estesa la critica un po’ a tutto il resto: dai prezzi inaccessibili delle case al proliferare di “week” su qualunque tema, passando per le ciclabili e giù fino ad Area B, Area C e pure… alle aree di rigore di San Siro, che nei progetti di Milan e Inter dovranno essere coperte da un altro intervento immobiliare, con tutto il resto dello stadio. Finita la pausa di agosto, su questo punto specifico si decideranno le sorti dell’amministrazione in carica, senza dimenticare che già nello scorso marzo la Procura ha aperto un’inchiesta sulla vendita dell’impianto.
Ma di “modello Milano” si sente parlare da diversi anni, cioè da molto prima che iniziasse il caos urbanistica. La definizione è diventata una sorta di omnibus in grado di contenere tutti quei tratti che fanno della città un caso oggettivamente unico in Italia, alimentando nel contempo una certa antipatia nel resto del Paese. Noi milanesi tendiamo a non accorgerci di quanto possa essere indigesto il nostro essere sui generis che dura addirittura dal 397 dC, quando il nostro Santo Protettore (allora Vescovo) consolidò pratiche liturgiche locali autonome da quelle romane, differenziando le date di Avvento, Quaresima e Carnevale, tuttora sfalsate rispetto alla Capitale. Il “rito ambrosiano”, appunto, nel suo senso originale.
Il senso originale di “modello Milano” è invece più difficile da individuare. All’inizio del ciclo del governo di centrosinistra, c’eravamo illusi che identificasse la larghissima coalizione con la quale Pisapia aveva strappato la città non tanto alla Moratti, quanto a Berlusconi. Non a caso, la prima pagina del Fatto Quotidano del 31 maggio 2011 (che tuttora conservo) titolava un eloquente “E adesso vattene”, con la foto del Premier affranto per le sconfitte subite in più città, compresa la sua Arcore. Il doppio arcobaleno di Piazza Duomo rimane il simbolo indiscusso di quel momento politico, di un successo reso possibile dalla nascita di una coalizione che spaziava da Cappato a Di Pietro, dalla sinistra-sinistra che oggi è in larga parte all’opposizione al cattolicesimo sociale e al civismo che fu fondamentale nel recuperare i voti di sfiduciati e astenuti.
Credemmo a tal punto in quel modello che provammo ad esportarlo in campo nazionale prima con la coalizione Italia Bene Comune, con Bersani che nel 2013 sfiorò soltanto il successo, sia per la vittoria zoppa nelle urne (maggioranza alla Camera, non al Senato), sia per il niet da parte del M5S. Poi ci provò lo stesso Pisapia, ma il suo progetto Campo Progressista si arenò addirittura prima delle elezioni 2018, a causa dei contrasti che impedirono la federazione delle forze a sinistra del Pd. Specialità della casa.
Si è peccato di ingenuità? Sì, ammettiamolo. La storia insegna che Milano spesso anticipa le tendenze nazionali, ma raramente i suoi sindaci ne diventano veri protagonisti, proprio in ragione della profonda differenza tra la Capitale economica e il resto del Paese.
Non solo: la stessa espressione “modello Milano” era già stata usata anche in precedenti epoche storiche. A ritroso nel tempo, Letizia Moratti la sbandierava come tendenza all’attrazione di investimenti, sia attraverso lo sviluppo del partenariato pubblico-privato, sia con la candidatura a Expo 2015. Una direzione simile a quella del suo predecessore Albertini, che però aveva un taglio meno manageriale e più politico su liberalismo, europeismo e attenzione all’ambiente. Negli anni delle giunte socialiste, in piena “Milano da bere”, la stessa locuzione tracciava la prospettiva di uno sviluppo che, cavalcando il boom economico, intrecciasse le sorti di imprese, istituzioni e sindacati, ricadendo positivamente anche sulle fasce più deboli della popolazione. Tangentopoli rappresentò un brusco risveglio per chi ci aveva creduto. E un redde rationem per le anime meno candide.
I paragoni tra allora e oggi sono inevitabili, anche perché gli arresti domiciliari di un assessore in carica sembrano riportarci indietro nel tempo. Stando a quanto finora emerso, lo scenario è però molto diverso, così come non sono univoche – salvo qualche ovvia sovrapposizione – le varie direzioni politiche che pure hanno tutte usato “modello Milano” come bussola. Un vero e proprio paradosso: nella città della moda, dovremmo sapere bene che la stessa vetrina non può andare bene per ogni stagione.
O, per uscire dalla metafora, nella Capitale della comunicazione e dell’editoria non si può pensare che lo stesso brand identifichi prodotti così diversi tra loro. Se è un errore di storytelling, è davvero molto grave. Ma può succedere. Se invece si persevera, è più probabile che sia un modo come un altro per imbiancare i sepolcri, che però a lungo andare pare non funzionare più granché, inflazionato oltre misura dai suoi molteplici cantori.
L'articolo Cosa significa davvero ‘modello Milano’ e perché non ha più senso parlarne proviene da Il Fatto Quotidiano.

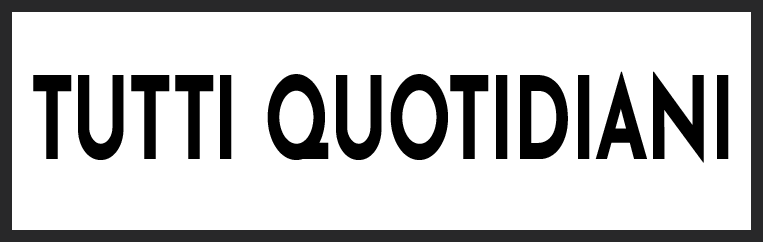

.png)