La sentenza di Torino sul caso Lucia Regna? Non pronunciatela in nostro nome, signori giudici
- Postato il 13 settembre 2025
- Blog
- Di Il Fatto Quotidiano
- 1 Visualizzazioni
.png)
Le motivazioni della sentenza della terza sezione penale del Tribunale di Torino (presidente Paolo Gallo, Elena Rocci e Giulia Maccari, giudici a latere) che ha condannato ad un anno di reclusione un uomo per aver devastato il volto della moglie durante un pestaggio di sette minuti, sono un capolavoro di sottocultura patriarcale che purtroppo attraversa la società italiana ed entra anche nei Palazzi di Giustizia.
Andrebbe letta passaggio per passaggio per far comprendere come il paradigma patriarcale è ancora tra noi e non c’è da essere ottimiste. La Cedu, dal 2015 ad oggi, ha inflitto all’Italia otto condanne per inadempienze nella tutela delle vittime di violenza: fra queste, la sentenza del 27 maggio 2021 (JL contro Italia) rilevò la violazione dell’articolo 8 – diritto al rispetto della vita privata e dell’integrità personale. I giudici di Strasburgo scrissero che le motivazioni della sentenza di assoluzione di sette uomini dall’accusa di stupro si focalizzarono sulla vita privata di J.L. e sulle sue scelte sessuali. Elementi ininfluenti per la valutazione della credibilità della vittima.
Il procuratore di Tivoli, Francesco Menditto, in un intervista rilasciata ieri durante la trasmissione radiofonica Effetto giorno, ha spiegato che la Corte di Cassazione, in ben quindici sentenze, ha ribadito ai giudici di merito che “l’attenzione non va calibrata sul comportamento della vittima ma sul comportamento dell’autore, non si può giustificare una condotta dell’uomo maltrattante perché è stato tradito, perché era geloso o perché la donna ha reagito, si va in violazione di legge“.
Eppure la sentenza dei giudici di Torino pone le scelte e i comportamenti della vittima al centro delle motivazioni che hanno portato all’assoluzione dell’imputato per il reato di maltrattamenti, nonostante ripetute minacce di violenza e denigrazioni, e hanno deciso di condannarlo solo per lesioni, focalizzandosi su quell’unico episodio. In una sorta di inversione di ruolo con l’imputato, la donna è stata colpevolizzata per le sue scelte, ovvero per aver scritto al marito su Whatsapp che non provava più alcun sentimento per lui, per aver posto fine ad un matrimonio “che durava da vent’anni” e per avere un’altra relazione.
E’ una sentenza che preoccupa perché empatizza con chi ha sfogato la propria violenza vendicativa sul volto della moglie, ricostruito con 21 placche di titanio. Una furia che si è scatenata per aver fatto esperienza della fine del matrimonio e aver saputo della relazione con un altro uomo. Un evento normale perché può accadere nella vita di milioni di coppie. E’ la violenza nelle relazioni di intimità che non dovrebbe essere normalizzata. Non nei tribunali. Se ne trae una conclusione amara: le donne hanno più probabilità di ottenere giustizia se, secondo i canoni moralistici di certi magistrati, sono irreprensibili ma, quando non lo sono, possono leggere in una sentenza che le azioni violente che hanno subìto sono comprensibili. Quanta empatia invece per il “dolore” dei violenti – o forse dovremmo dire per il loro “onore”?
C’è un passaggio della sentenza che è estremamente significativo. Sposando completamente il punto di vista dell’imputato, i giudici banalizzano le volgarità umilianti che la donna si sentiva rivolgere quotidianamente e scrivono: “Pare evidente che queste frasi devono essere calate nel loro specifico contesto: l’amarezza per la dissoluzione della comunità domestica era umanamente comprensibile, era pienamente legittimo, poi, che l’imputato rivendicasse il contributo da lui dato alla famiglia; le frasi finali, al di là dello scurrile linguaggio adoperato, semplicemente esprimevano il disappunto e la preoccupazione per il sicuro peggioramento delle condizioni economiche a cui la famiglia sarebbe andata incontro. E’ perciò sincero e persuasivo l’imputato quando afferma: ‘E’ successo che è volata qualche parolaccia perché stava rovinando un matrimonio felice e una famiglia felice’.”
E’ un vero peccato che i magistrati non si rendano conto, poiché non lo rilevano nelle motivazioni, che per la vittima quel matrimonio non fosse perfetto e nemmeno felice, logorato da quei vent’anni tanto decantati nella sentenza come un primato che non doveva essere sconfessato. Un uomo, quindi, può valutare unilateralmente la buona riuscita di un matrimonio senza che la moglie “rovini tutto” con la legittima scelta di separarsi?
Quanto al contributo che l’imputato aveva dato durante il matrimonio, i giudici di Torino, così come i magistrati della sentenza Montefusco (Corte di Assise di Modena), non considerano che anche le donne danno il loro contributo durante il matrimonio. Il bias culturale della rovina economica maschile, a tutto vantaggio di un privilegio femminile, si è fortemente radicato nelle aule di giustizia.
L’avvocata Clarice Carassi, presidente di Trama di Terre, sostiene che “Siamo di fronte ad una sorta di antagonismo culturale che, attraverso gli stereotipi giudiziari, si insinua nelle aule dei Tribunali, nelle sue decisioni così come nella dinamica processuale. E’ una forma di resistenza che parrebbe voler ‘contrastare’ una fase in cui la prassi giudiziaria, proprio partendo dalla Cassazione, si apre al riconoscimento di forme di maltrattamento all’interno delle relazioni di intimità non più solo coincidenti con la violenza fisica e sessuale, ma anche con la quella psicologica ed economica, cogliendo quindi in maniera più ampia le modalità di oppressione e controllo che il maltrattante agisce nella relazione con la partner. Decisioni come quella del Tribunale di Torino, che non considera come maltrattamenti le abituali denigrazioni, le offese, gli agiti percossivi dell’imputato verso la moglie, derubricandoli a espressione di una comprensibile frustrazione per la fine della relazione, focalizzandosi unicamente sull’efferato episodio lesivo, ci parlano di una regressione culturale e giuridica purtroppo diffusa per ciò che riguarda i reati di violenza di genere, poiché deresponsabilizzano gli autori riconoscendo come innata e quindi giustificabile, ‘comprensibile’, la risposta maschile violenta alla libertà delle donne.”
Le sentenze si pronunciano in nome del popolo italiano, ma questa sentenza non è pronunciata nel nome delle donne, delle vittime di violenza, dei loro familiari e di tutte le attiviste che ogni giorno lavorano per un cambiamento culturale che tolga legittimità alla violenza maschile. Non in nostro nome, Signori Giudici.
@nadiesdaa
L'articolo La sentenza di Torino sul caso Lucia Regna? Non pronunciatela in nostro nome, signori giudici proviene da Il Fatto Quotidiano.

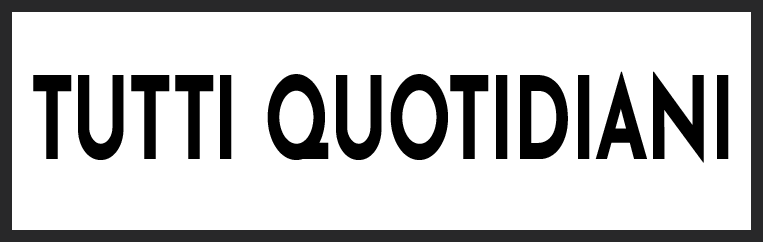
.png)