Un design a prova di natura, l’antropologo: “Cominciamo a imparare dall’architettura animale”
- Postato il 27 maggio 2025
- Ambiente
- Di Il Fatto Quotidiano
- 1 Visualizzazioni
.png)
“Comprendere l’architettura animale può offrire spunti rivoluzionari per il modo in cui progettiamo e viviamo gli spazi. Possiamo imparare moltissimo: gli animali utilizzano esclusivamente materiali disponibili in loco, spesso riciclabili o biodegradabili, e progettano strutture che richiedono un dispendio energetico minimo per la costruzione e il mantenimento. Pensiamo ai nidi degli uccelli, che sfruttano la forma per ottimizzare l’isolamento termico, o alle dighe dei castori, che creano microclimi stabili e favoriscono la biodiversità. Non usano cemento, acciaio o plastica, ma sanno costruire in modo resiliente e adattivo”. Andrea Staid, docente di Antropologia culturale e visuale alla Naba di Milano e di Antropologia culturale all’Università di Genova, ospite della sedicesima edizione dei Dialoghi di Pistoia che si è tenuta dal 23 al 25 maggio, ha scritto un libro, Dare forme al mondo. Per un design multinaturalista (Utet), in cui racconta la possibilità di un design ecologico, low cost, sostenibile, suggestivo. Un design che si ispiri, in generale, alle forme della natura, così come alle soluzioni abitative messe in campo dagli animali, di cui poco o nulla si parla, “forse perchè gli animali non pagano affitti, non si indebitano a vita per una casa, ma occupano uno spazio e collettivamente autocostruiscono”, commenta Staid.
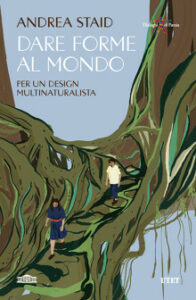 Lei è un antropologo. Come è arrivato a riflettere sulle intersezioni tra natura, design, modi di abitare?
Lei è un antropologo. Come è arrivato a riflettere sulle intersezioni tra natura, design, modi di abitare?
Questo mio nuovo libro chiude una trilogia che è iniziata con un libro sulle case (La casa vivente) e uno sul concetto di natura (Essere natura). L’antropologia ci ricorda che l’architettura non è solo una questione di forme e funzioni, ma di persone. Gli edifici non sono sculture autonome, ma spazi in cui le persone vivono, lavorano, interagiscono, formano comunità e costruiscono significati.
In che senso l’architettura non deve ignorare la questione ecologica?
Un’architettura che ignora l’antropologia e la questione ecologica rischia di creare spazi che non rispondono ai bisogni reali degli abitanti, non promuovono il benessere sociale o non riflettono le identità culturali. Si tratta di comprendere come l’architettura e il design possano facilitare o ostacolare la formazione di legami comunitari e l’impatto che abbiamo sulla natura di cui facciamo parte.
Il design ecologico ha una storia che lei racconta molto bene. Nel passato si costruiva in maniera più sostenibile?
Sì, le radici del design ecologico e sostenibile odierno affondano nel passato, grazie a pensatori, artisti e architetti che, anticipando i tempi, hanno promosso un approccio rispettoso dell’ambiente e delle risorse. In passato, le scelte costruttive erano guidate dalla necessità di adattarsi al clima, ai materiali locali e alle tradizioni. Questo ha dato vita a edifici che, ancora oggi, sorprendono per l’efficienza energetica e l’integrazione perfetta nel paesaggio. Si potrebbe affermare che in un’epoca basata su un sapere ancestrale e una profonda conoscenza del territorio, l’abitare umano fosse intrinsecamente più saggio e sostenibile.
Oggi si parla molto di una crisi del modello abitativo. Le case nelle città hanno prezzi sempre più irraggiungibili. Eppure lei spiega come sia possibile un design che unisce sostenibilità, isolamento termico, biocompatibilità, costo contenuto.
La crisi del modello abitativo attuale e la negazione del diritto alla casa sono problemi sistemici e il contrasto con la possibilità di un design sostenibile e accessibile è stridente. Anziché migliorare le condizioni abitative per i residenti esistenti o creare nuova edilizia sociale, si traducono in interventi che attraggono investimenti di lusso, che portano all’aumento dei prezzi, alla gentrificazione, all’omologazione. Ma io propongo qualcosa di diverso dalla transizione “verde”: delle scelte di critica radicale alla città del “produci, consuma, crepa”, ripensando la città e l’abitare in un modo non gerarchico e senza segregazione di classe e specie. Dal mio punto di vista è l’unica via se vogliamo salvarci da questa tremenda crisi ecosistemica.
Perché non è vero che il design debba essere per forza iper tecnologico? Lei parla di “design low tech”.
Il concetto di design low-tech offre una prospettiva affascinante che decostruisce la convinzione, appunto, che il design debba essere per forza iper-tecnologico. Invece di affidarsi a soluzioni complesse e all’avanguardia, il low- tech privilegia la semplicità, l’efficienza e la durabilità, spesso attingendo a tecniche tradizionali e materiali locali. L’innovazione non risiede solo nella complessità tecnologica, ma anche nella capacità di risolvere problemi con intelligenza e risorse limitate. Però viviamo in un mondo globalizzato, in cui esiste l’aspettativa che il “buon design” sia necessariamente quello “globale” e “tecnologico”, spesso a discapito delle specificità locali e sostenibili.
La sua visione multinaturalista vede la progettazione anche come riparazione. Perché non stiamo andando verso il modello che lei propone?
Purtroppo sono pochi gli esempi virtuosi, sicuramente minoritari, ma sono convinto che nei margini possiamo scovare i laboratori di possibilità per un futuro migliore. Ci sono tanti problemi normativi ma la questione principale è agire sulle convinzioni culturali.
Quali sono le buone pratiche di un design multinaturalista?
Una visione multinaturalista nel design e nell’architettura implica riconoscere la molteplicità delle “nature” e dei modi in cui possiamo relazionarci con esse, andando oltre una visione unica e antropocentrica. Tra i vari esempi una buona pratica è quella delle architetture vegetali per interni o esterni, bambù, Arundo donax (canna comune), terra, paglia, canapa, cocciopesto…oppure eliminare il packaging o svilupparne uno a impatto zero con materiali al 100% biodegradabili, e poi il riuso creativo.
Perché, in conclusione, nel dibattito pubblico si parla poco dei modi di progettare abitazioni, come se costruire fosse un fatto neutro?
La narrazione dominante tende a presentare la costruzione come un fatto tecnico, economico e funzionale, quasi neutro, slegato da implicazioni culturali, politiche, sociali ed etiche. Si parla di metri quadrati, di costi al metro cubo, di materiali performanti, di normative edilizie. Tutto questo è ovviamente importante, ma maschera un aspetto fondamentale: ogni scelta progettuale è intrisa di politica. Quando un edificio viene progettato, si decide implicitamente come le persone interagiranno al suo interno, si stabiliscono gerarchie, si promuovono o meno la privacy, la socialità, il benessere. Questa dimensione valoriale, politica, sociale e quindi antropologica viene spesso ignorata, come se fosse un “extra” invece che l’essenza stessa dell’abitare. Penso che anche i media potrebbero fare di più attraverso l’amplificazione di un dibattito necessario, perché di fatto da come abitiamo possiamo cominciare a cambiare il mondo.
L'articolo Un design a prova di natura, l’antropologo: “Cominciamo a imparare dall’architettura animale” proviene da Il Fatto Quotidiano.


.png)
